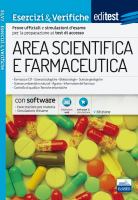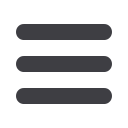

274
PROVE UFFICIALI
www.
edises
.it
In questa prova vengono presentati due bra-
ni, tratti da testi più ampi ai quali sono
state apportate alcune modifiche, per ren-
derli più adatti allo specifico contesto di
applicazione.
Ciascuno dei brani presentati è seguito da
cinque quesiti riguardanti il suo contenuto;
tali quesiti sono numerati progresivamente da
66 a 75. Per ogni quesito sono previste cinque
risposte differenti, contrassegnate con le lettere
A, B, C, D, E.
Per ogni quesito scegliete fra le cinque risposte
o affermazioni quella che ritenete corretta in
base soltanto a ciò che risulta esplicito o im-
plicito nel brano, cioè solo in base a quanto
si ricava dal brano e non in base a quanto
eventualmente sapete già sull’argomento.
TESTO I
INTRODUZIONE DI SPECIE ALLOCTON
IN AMBIENTE MARINO
(modificato e rielaborato da: Towsend –
Harper – Begon,
L’essenziale di ecologia
,
Zanichelli, 2001 e da: Cognetti – Sarà –
Magazzù,
Biologia marina
, Calderini, 2008)
Nella storia della vita sulla Terra molte specie
hanno allargato il loro areale, occupando nuovi
habitat, come conseguenza di colonizzazioni
casuali o di cambiamenti ambientali. Le attività
antropiche hanno tuttavia aumentato la porta-
ta di questo “rivolo” naturale trasformandolo in
una “inondazione” e alterando i pattern globali
di ricchezza di specie.
Alcune specie sono state introdotte accidental-
mente, spesso come conseguenza dei traspor-
ti umani, mentre altre sono state introdotte
intenzionalmente, ad esempio per tenere sotto
controllo organismi nocivi, per ottenere nuovi
prodotti agricoli o per offrire nuove opportu-
nità ricreative. Molti “invasori” sono entrati a
far parte delle comunità naturali senza con-
seguenze evidenti sui popolamenti autoctoni;
alcuni hanno invece contribuito all’estinzione
di specie preesistenti, alterando in maniera
significativa le comunità naturali.
In ambiente marino, l’introduzione di specie
a seguito di attività antropiche ha molteplici
cause, tra le quali: l’eliminazione di barriere
naturali con l’apertura di canali di navigazione
(per esempio Suez, Panama), il trasporto acci-
dentale sulle chiglie delle navi e/o nelle acque
di zavorra, l’importazione volontaria di specie
ittiche per l’acquacoltura, la pesca sportiva o
l’acquariologia amatoriale, l’importazione in-
volontaria di organismi in qualche modo as-
sociati alle specie citate al punto precedente
(commensali, parassiti ecc.).
L’ingresso nel Mediterraneo di specie origina-
rie del Mar Rosso attraverso il Canale di Suez
prende il nome di migrazione lessepsiana (da
Ferdinand de Lesseps, progettista del canale
stesso). La migrazione lessepsiana è stato un
fenomeno abbastanza modesto fino al 1945
per la presenza dei Laghi Amari, due laghi salati
situati lungo il Canale di Suez, che rappresen-
tavano una barriera naturale per la ipersalinità
delle loro acque. A causa dell’intensificazione
del traffico navale e dell’aumento del flusso
d’acqua, la salinità dei laghi Amari è fortemen-
te diminuita e pertanto il passaggio di specie
è aumentato. Come conseguenza le bioceno-
si presenti nel Mar di Levante (Mediterraneo
orientale) e lungo le coste dei paesi medio-
orientali hanno subito un netto cambiamento.
In alcuni casi si sono creati equilibri fra specie
autoctone (preesistenti nel Mediterraneo) e
specie alloctone lessepsiane (provenienti dal
Mar Rosso) con esigenze ecologiche simili, at-
traverso una differente localizzazione sui fon-
dali; per esempio, il crostaceo
Squilla mantis
si
è spostato in profondità ed è stato sostituito in
superficie dalla specie migrante lessepsiana
Squilla massawensis
. In altri casi l’interazione
tra le specie ha portato all’esclusione compe-
titiva della specie mediterranea da parte del
migrante lessepsiano; per esempio, la stella
marina
Asterina gibbosa
è stata sostituita da
Asterina vega
lungo le coste del Mar di Levante.
Come già detto, la colonizzazione di nuovi are-
ali da parte di specie marine alloctone è spesso
collegata al trasporto passivo nelle incrosta-