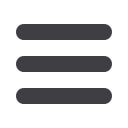

Parte I - Letteratura
92
14) B
. Achille è il Pelíde perché figlio di Peléo, re di Ftia nella Tessaglia e di Teti,
dea del mare. Egli venne a Troia guidando l’esercito dei Mirmidoni. Πηληιάδεω è un
patronimico, cioè un aggettivo che sta ad indicare la paternità dell’eroe. L’individuazio-
ne mediante il nome del padre è una caratteristica della società greca dell’età arcaica in
cui l’individuo vale in quanto appartenente ad un γένος. Si tratta di un genitivo singolare
della prima declinazione, forma ionica con sinizesi che corrisponde all’attico - ου.
15) D.
Nel XXIV libro dell’
Iliade
, vv. 486-506, Priamo, giunto nella notte alla tenda
di Achille per richiedere il corpo del figlio Ettore, rivolge ad Achille un lungo discorso
nel quale paragona la propria situazione a quella che vive anche Peleo che è infelice,
perché vecchio e solo. Inoltre. Priamo precisa di essere più sfortunato del padre di
Achille, che può ancora sperare nel ritorno del figlio. Così Achille, pensando al vec-
chio padre, si commuove e compie un gesto rituale e umano: prende per mano Priamo
e lo aiuta a sollevarsi, riconosce così il re troiano come suo ospite.
16) A.
Nel IX dell’
Odissea
, vv. 250-414, Polifemo si accorge di Odisseo e dei suoi
compagni e chiede loro chi siano; sono le domande con le quali abitualmente si accol-
gono i forestieri che capitano in casa. Polifemo chiede loro l’identità, da dove proven-
gono e perché sono in viaggio. La differenza rispetto alla consuetudine greca sta nel
fatto che qui le domande vengono rivolte all’ospite prima e non dopo avere ristorato
i forestieri con cibo, riposo e accoglienza. L’eroe greco si presenta come guerriero di
Agamennone e chiede che siano rispettate le leggi della ξενία: secondo la mentalità
arcaica infatti, i doni ospitali sono un diritto degli uomini civili e rafforzano la fama di
chi li riceve. Nonostante tutto Polifemo si vanta della sua empietà poi si avventa su due
compagni di Odisseo, li sbrana e si addormenta.
17) D.
Il νόστος di Odisseo verso Itaca richiede la sua discesa nell’Ade, la terra dei
morti, dove dal vate Tiresia riceverà informazioni sul viaggio di ritorno. Dopo avere
eseguito le istruzioni che la maga Circe gli ha impartito, giunge nell’Ade dove incon-
tra la madre Anticlea morta durante la lunga assenza del figlio. Dopo avere bevuto il
sangue, Anticlea può parlare e chiede a Odisseo come sia giunto in quel luogo pur es-
sendo ancora vivo, l’eroe risponde di essere giunto lì per interrogare Tiresia e le chiede
informazioni sulla morte di lei, sul padre, sulla moglie e sul figlio. Anticlea risponde
di essere morta di nostalgia per lui, quando poi egli cerca inutilmente di abbracciarla,
lei spiega che le anime sono ombre e che sono prive di corporeità e di consistenza e lo
invita ad allontanarsi da quel luogo di dolore e rimpianto.
18) C.
La sistemazione definitiva dei poemi omerici risale ai filologi alessandrini che,
dal III sec. a.C. curarono la divisione dell’
Iliade
e dell’
Odissea
in ventiquattro canti cia-
scuna. Furono i filologi alessandrini a scrivere molti commenti e apparati, pervenuti a
















