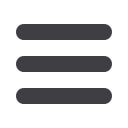

Parte I - Letteratura
98
un signore; la citarodia lungo compianto a carattere mitologico eseguito durante feste
religiose locali.
45) B.
L’ode ad Afrodite
nelle edizioni alessandrine apriva il primo libro dell’opera
di Saffo, l’ode ci è giunta intera grazie ad una citazione di Dionigi di Alicarnasso che
ne fa un esempio di composizione “ elegante e fiorita”. Il carme appare come un inno
e segue lo schema tipico del rito: invito alla divinità perché sia presente alla festa,
invocazione dei suoi epiteti, preghiera. Al centro del componimento però non è Afro-
dite, bensì la poetessa stessa. L’esperienza individuale dell’amore diviene collettiva,
in quanto viene espressa davanti alle fanciulle del tíaso e il canto assume un valore
paideutico: Saffo mostra alle giovani come è potente Afrodite e le ammonisce a non
rifiutarla. Il componimento è scritto in strofe saffica.
46) D.
Il tíaso saffico elaborò uno stile di vita in cui la grazia e la raffinatezza di un gesto,
la danza e la poesia diventano elementi fondamentali. Nei frammenti 49, 55, 57, 133 Saffo
esprime il primato della grazia e della raffinatezza sulla mancanza di cultura e sulla poca
eleganza e il cattivo gusto di alcune fanciulle rivali. “
Quale zoticona ti strega la mente?
Rustica veste indossa, non sa drappeggiare la stola attorno alle caviglie
” (fr. 57).
•
La tragedia: Eschilo, Sofocle, Euripide
47) D.
La tragedia greca è costituita da alcune parti fondamentali: un prologo, che è un
discorso preliminare; una parodo, che è il canto d’entrata dei coreuti; più episodi, interval-
lati da stasimi, o canti del coro (risp. C); si conclude con un esodo (risp. B). La
contami-
natio
è la pratica degli antichi commediografi latini di inserire nella rielaborazione latina
di una commedia originale greca una o più parti estratte da un’altra commedia greca.
48) A.
Il termine «φθόνος», ed il verbo «φθονέω» ad esso collegato, indicano la
malevolenza e l’invidia, tanto degli uomini quanto degli dèi. Il sostantivo ha valore
anche sociale perché in numerose occorrenze si riferisce alla malevolenza verso una
parte politica avversa.
49) B.
Nella visione eschilea il volere divino è presente, alto, spesso imperscrutabile,
potente; e così è presente la dimensione comunitaria. Inoltre, com’è noto, se l’indivi-
duo commette una colpa, innesca un meccanismo di reazione a catena, denominato
dai critici come «catena delle colpe», che coinvolge i suoi familiari e discendenti, fino
all’espiazione finale.
50) A.
Le scelte di fronte alle quali si ritrova l’uomo tragico sofocleo sono indivi-
duali, così come lo è il suo destino (mentre nelle tragedie di Eschilo maggiore peso
















