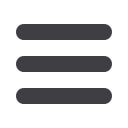

93
Risposte commentate
•
Le origini e l’epica: Omero, Esiodo
margine del testo omerico nei codici medioevali. Precedentemente invece circolavano
edizioni “civiche” (κατ
ὰ
πόλεις) del sec. VI a.C. e, a partire dai secoli successivi, edizioni
che prendevano il nome del privato che le aveva commissionate o curate (κατ
ὰ ἄ
νδρα).
19) C.
La lingua di Omero presenta tratti linguistici riconducibili ai gruppi dialettali
ionico e eolico. Sono presenti anche alcuni atticismi spiegati come frutto della redazione
pisistratea o dell’attività dei copisti di epoche successive che avevano maggiore familia-
rità con l’attico. Mancano invece elementi propri dei dialetti occidentali come il dorico.
20) C.
I poemi omerici, almeno nella loro struttura originaria (a parte le interpola-
zioni e le rielaborazioni posteriori), risalgono ad un periodo attorno al 750 a.C. (epoca
arcaica) o di poco precedente. Il filosofo Senofane, vissuto nel VI sec. a.C. è l’autore
più antico che parla di Omero. Erodoto affermava che Omero ed Esiodo erano vissuti
400 anni prima di lui e perciò intorno all’850 a.C. Inoltre in Omero si trovano riferi-
menti relativi a istituzione e usi della tarda età del bronzo (età micenea) insieme ad altri
che rimandano all’epoca arcaica.
21) B.
L’abate francese d’Aubignac fu il primo che, nelle sue
Conjectures académi-
ques ou Dissertation sur l’Iliade
(1664), mise in dubbio la reale esistenza storica di
Omero e sostenne che i poemi derivavano dall’unione di vari canti separati e preesistenti.
Sulla stessa linea fu l’idea dell’illuminista napoletano Giambattista Vico, il quale nella
Scienza Nuova
(libro III
Sulla discoverta del vero Omero
del 1730) sostenne che i poemi
omerici furono composti oralmente nell’ambito della tradizione popolare greca e che
quindi il loro autore doveva considerarsi un popolo intero nel corso di più generazioni.
Queste teorie trovarono un sostenitore anche in Jean-Jacques Rousseau (1761) e furono
poi riprese in Inghilterra da Robert Wood (
An Essay of the Original Genius of Homer
,
1796) il quale sostenne che i poemi omerici furono tramandati oralmente e che furono
scritti per la prima volta solo nell’Atene di Pisistrato nel VI sec. a.C.
22) C.
Si tratta dell’inizio del proemio della
Teogonia
di Esiodo. La Teogonia è
un poema teogonico in 1022 esametri dattilici di cui solo i primi 900 sono, secondo
Martin West, attribuibili ad Esiodo. L’opera è divisibile in tre sezioni: il proemio (vv.
1-115); la cosmogonia e teogonia (vv. 116-885) in cui si espone l’origine dell’uni-
verso e delle divinità fino alla signoria di Zeus e all’assegnazione agli dèi delle loro
prerogative; i cataloghi delle spose divine di Zeus e delle generazioni degli eroi (vv.
886-1022). Nel Proemio della Teogonia Esiodo racconta il suo incontro con le Muse
mentre pascolava le greggi sul monte Elicone in Beozia, sede delle Muse. Il poeta di
Ascra venne chiamato per nome dalle dee che gli insegnarono un bel canto e gli con-
cessero l’investitura di poeta con un ramoscello d’alloro, invitandolo a cantare le cose
future e passate e le stirpi degli dèi, iniziando e concludendo sempre nel nome delle
















