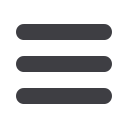

324
Parte Seconda
L’insegnamento dell’italiano lingua non materna (L2)
www.
edises
.it
La frammentarietà del parlato persiste anche nel parlante competente ed entro
certi limiti non va considerata come indizio di scarsa competenza linguistico-co-
municativa; tuttavia, nel passaggio a forme di parlato più pianificate (ad esem-
pio relazione, intervento su scaletta, ecc.) l’insegnante potrà rendere consapevo-
le l’allievo anche di questi aspetti puntualizzando come la comprensione e, in
generale, l’interazione comunicativa sia più facile quando l’emittente sia in gra-
do di parlare fluentemente, senza un eccessivo ricorso all’autoriparazione (in
particolare a partire dai livelli B2 fino a C1 e C2 di apprendimento della lingua
seconda o straniera).
La testualità meno coesa che nello scritto, dovuta a frammentarietà formale e
tematica, si traduce in fenomeni tipici del parlato quali, ad esempio:
– “
false partenze, pause da esitazione, interruzioni e autocorrezioni, mutamenti di
progetto, frasi lasciate a metà;
–
prevalere della semantica sulla sintassi;
–
temi sospesi (sintatticamente ma non semanticamente slegati dal resto della fra-
se) che mettono in rilievo il centro di interesse del locutore e facilitano la ricezio-
ne (secondo l’ordine “elemento dato”+“informazioni nuove su quell’elemento”)
ma indicano anche la difficoltà di pianificare il discorso a breve gittata;
–
ripetizione delle stesse parole, anche a distanza ravvicinata, per realizzare la co-
referenza, cioè il riferimento al medesimo oggetto del discorso;
–
ripetizioni e riformulazioni, che permettono di riempire le pause, rallentando il
ritmo della produzione e dando il tempo a chi ascolta di pianificare il proprio
intervento successivo;
–
minore ricorso a sostituenti (come pronomi e sinonimi) rispetto allo scritto;
–
ripresa e riformulazione (anche a distanza) degli stessi concetti;
elementi identificati dagli studiosi che si sono dedicati all’analisi della strumentazione prag-
malinguistica a disposizione dei parlanti, si distingue in genere tra
segnali discorsivi che hanno
funzione interazionale
(e che servono quindi alla gestione degli scambi comunicativi soprat-
tutto nell’oralità o in situazioni che le assomigliano) e
segnali discorsivi che hanno funzione
metatestuale
(e che sono funzionali alla segnalazione di collegamenti tra sezioni diverse del te-
sto), che si potrebbero anche chiamare
esoforici
ed
endoforici
: i primi sono quelli che puntano
alla situazione comunicativa, i secondi quelli che si riferiscono in qualche modo al testo; sono
questi ultimi – o meglio, alcuni di questi ultimi – ad avere funzione coesiva. Distinguiamo, in
particolare, tra i segnali discorsivi esoforici, (1) quelli
di presa di turno
(
dunque.., allora…
),
(2)
di richiesta di attenzione
(
Allora, sentite…; Ecco, scusate…; Dunque, guardate…
),
(3)
di dismis-
sione dello scambio
(questi vengono più spesso prodotti dal destinatario che non dall’emitten-
te:
bene…, perfètto…; ottimo…
).
Tra i segnali endoforici che hanno funzione di incrementare la non-discontinuità di superficie
distinguiamo invece quelli (1)
demarcativi
(
insomma, comunque, in ogni caso…
),
che hanno
funzione strutturale, che servono, cioè, a segnalare snodi discorsivi in cui, a volte, si ripren-
dono argomenti temporaneamente abbandonati a causa di una digressione; quelli (2)
identifi-
catori di fuoco tematico (appunto, proprio…
), che servono a segnalare elementi comunicativa-
mente salienti (…
Ma io
penso che questa azione sia sbagliata
–
È appunto quello che sostengo
io…
); quelli (3)
indicatori di
riformulazione
(
cioè, in sostanza, insomma, vale a dire, per la preci-
sione…
) che fanno riferimento al co-testo precedente (hanno, quindi, una funzione anaforica),
per riproporlo in una forma modificata (parafrasata o sunteggiata) (Prada, 2003, vol. 1:371).
















