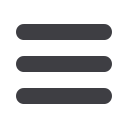
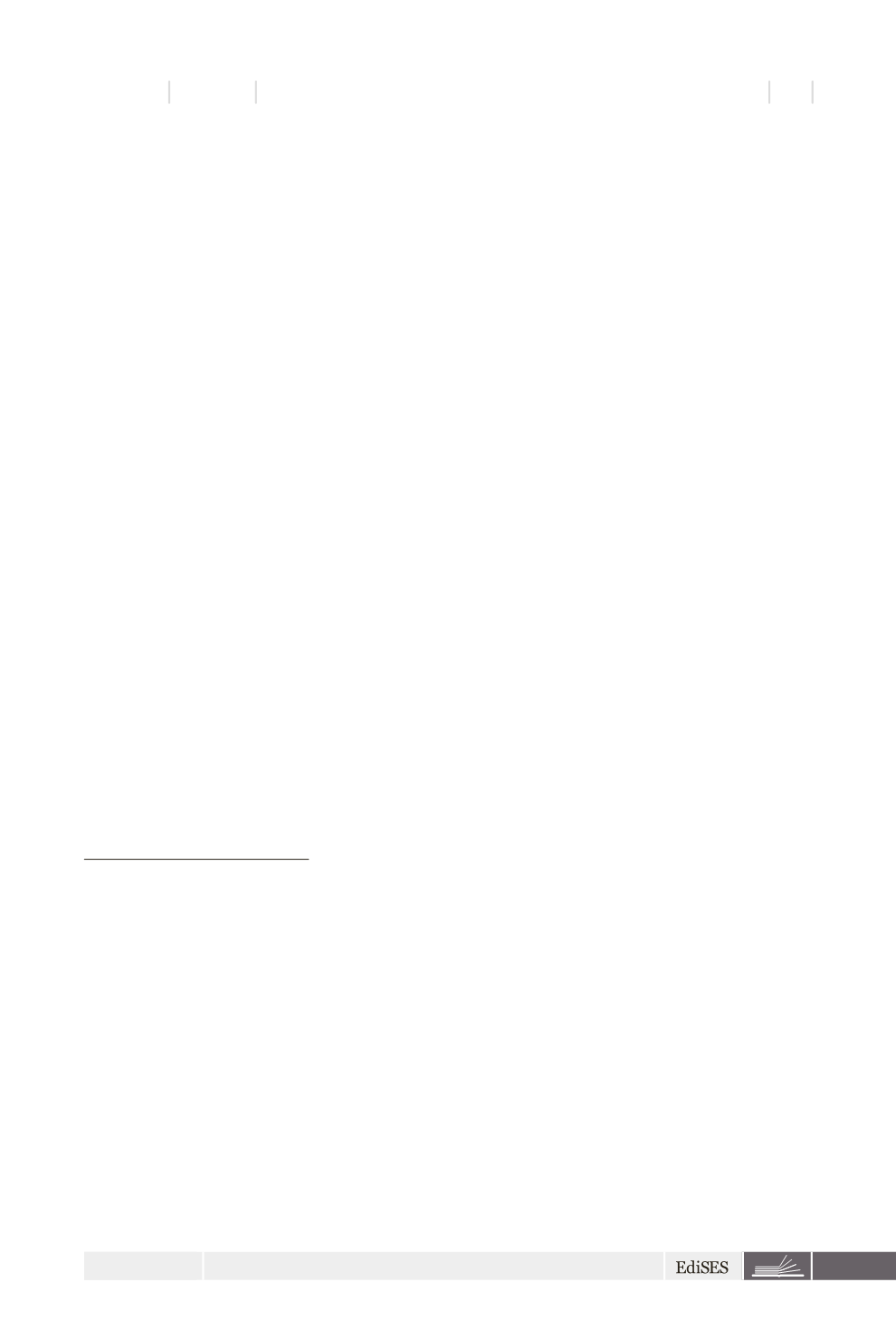
Capitolo 3
Modalità e tecniche per l’insegnamento e lo sviluppo delle abilità linguistiche
323
www.
edises
.it
perché è grave commette anche il reato di omissione di atti d’uf<ficio> in-
somma io fino a una settimana fa ero di un’opinione # dopo di che # così ri-
pensandoci studiando cambio idea oggi mi dimostrano che ho ho completa-
mente preso una toppa micidiale
A: cioè cambian<do> hai preso la toppa cambiando idea
B: già! …
(da BADIP,
Banca dati dell
’
italiano parlato
).
La frammentarietà e la discontinuità sono caratteristiche tipiche della maggior
parte delle forme di parlato in cui il grado di informalità è massimo. Queste si
attenuano, naturalmente, nelle forme di parlato più pianificate e formali, quali,
ad esempio, una relazione, un intervento su scaletta, un discorso in pubblico.
La frammentarietà e la discontinuità della maggior parte delle forme di parlato
che più tendono verso il polo di massima informalità danno luogo a quelle che
Monica Berretta (1984) definisce “strategie di autoriparazione”: intercalari, se-
gnali generici (“ehm, mhm”), espressioni di ripresa dopo pause o esitazioni nel
discorso (“allora…”, “bene…”, “ecco…”, “eh… cioè…”), espressioni di “commen-
to” (“certo”, “giusto”, “ma dai…!”, incisi, uso di particelle e segnali discorsivi
“
che hanno
[…]
la funzione di articolare e strutturare con mezzi non sintattici il
discorso
(2008
3
:42)
e di gestire l’interazione con l’interlocutore
” (Berruto, 2008:42),
quali, ad esempio, “diciamo…”, “insomma”, “allora…”, “veramente” “ascolta…”,
“sai…”, “chiaro fin qui…?”, “o(c)chéi”, “mi segui”, “appunto”, “bene…”, “per così
dire”, “che poi…”, “praticamente”, “capisci”, “mi spiego?”, “sei d’accordo no?”,
“ho reso l’idea?”, “in buona sostanza…”, ecc. Questi segnali discorsivi possono
svolgere funzioni diverse: indicare un’apertura di discorso o una conclusione,
attenuare un’affermazione, segnalare una correzione o una riformulazione, ri-
chiamare l’attenzione, il consenso, sollecitare la partecipazione dell’interlocuto-
re, ecc., essere usati anche come fatismi per controllare e mantenere aperto il
canale comunicativo o come semplici intercalari
3
.
3
La necessità di verificare costantemente lo stato del canale/veicolo e l’andamento dello
scambio comunicativo rende i testi parlati particolarmente ricchi di elementi di controllo,
chiamati
segnali discorsivi
.
I
segnali discorsivi
sono
elementi linguistici ascrivibili a diverse
categorie grammaticali che – nel parlato, e soprattutto nell’interazione dialogica – hanno la
funzione di mantenere aperto il canale comunicativo
(Ascolta Rosa, non è quello che intende-
vo…
), di verificare la sussistenza del contatto (
Pronto
,
pronto? Sei in linea?)
, di gestire i turni
conversazionali
(appunto…,
detto dall’interlocutore al parlante, intervenendo nel discorso e
prendendo la parola), di dare una veste linguistica ad alcuni rapporti sociali (per esempio a
quello della condivisione di una medesima situazione, condizione o classe:
Come lei sa bene,
caro Rossi, il fatto è comune…
). Tra i
segnali discorsivi,
si contano, inoltre forme verbali o
avverbiali e congiunzioni come
guardi, senta, ascolti, vero?, no?, come?, allora?,
o elementi
interiettivi come
mah, beh, ah, umh, cioè…
e persino intere frasi (
È una bella giornata, eh?
Ci siamo per caso visti altrove…
?) e altri ancora, che non hanno la funzione di contribuire ad
aumentare la quantità di informazione veicolata, la ricchezza contenutistica del testo, ma di
dare indicazioni sul suo uso.
Per quanto non esista una classificazione esaustiva e condivisa dei segnali discorsivi (né, ov-
viamente, una terminologia veramente partecipata con la quale fare riferimento a tutti gli
















