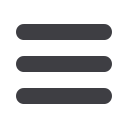
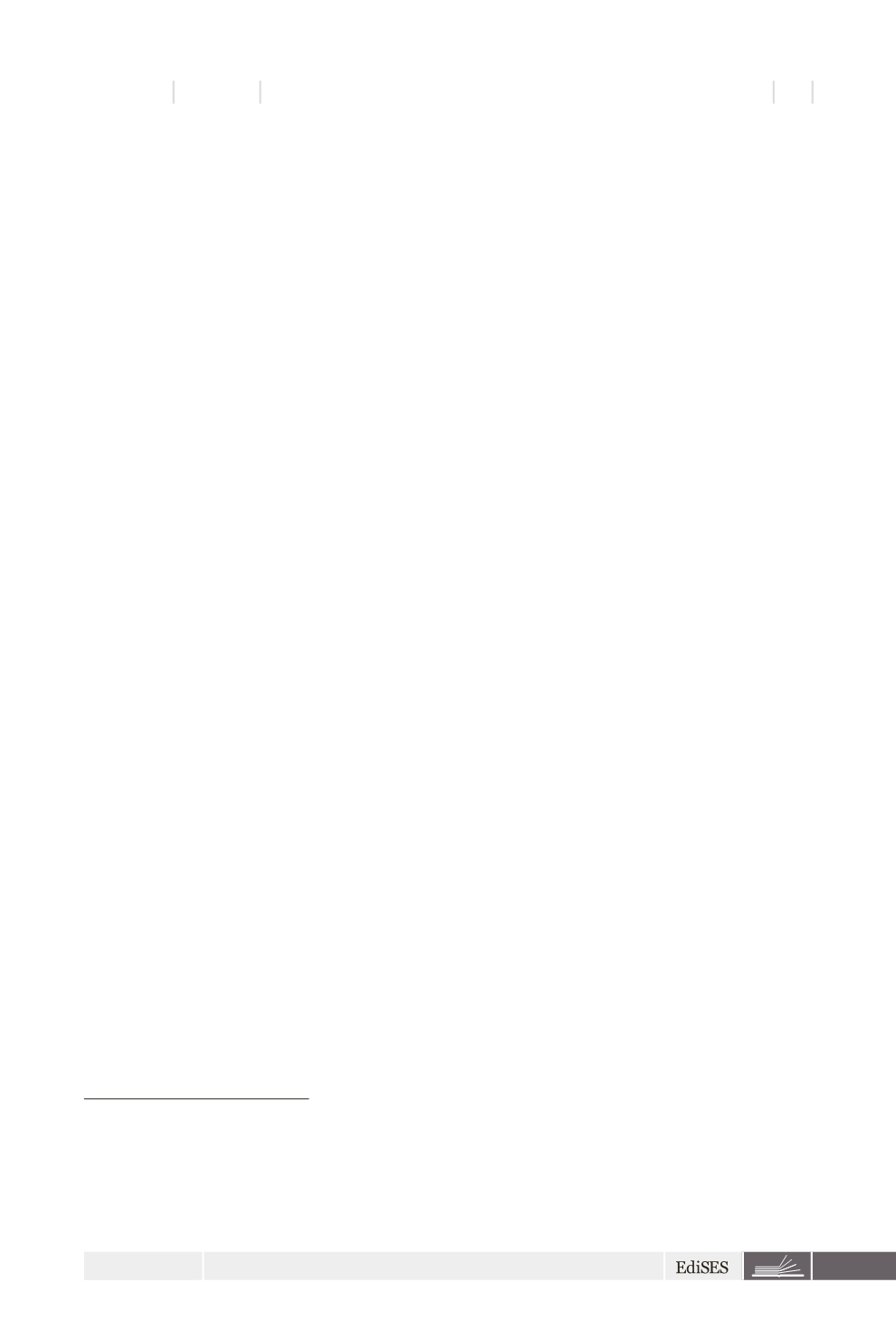
Capitolo 3
Modalità e tecniche per l’insegnamento e lo sviluppo delle abilità linguistiche
321
www.
edises
.it
–
modulazione della voce che, grazie al volume, al tono, all’intonazione, al ritmo,
permette di variare lo stile comunicativo (tipici i fenomeni di “allegro” legati al
ritmo sostenuto del parlato spontaneo) o connota il parlante dal punto di vista
della sua provenienza geografica;
–
fenomeni di messa in evidenza di parti del discorso mediante strategie verbali
(dislocazioni e frasi scisse
[…])
e paraverbali (innalzamento del tono, rallenta-
mento del ritmo, intonazione);
–
fenomeni di allegro
2
(variabilità diatopica, elisioni, apocopi, alterazioni di suoni);
–
coesione affidata anche all’intonazione e al ritmo
” (Diadori, 2004:74).
3.2.2
Discontinuità nel parlato
La produzione orale, in quanto produzione sequenziale, è strettamente correlata
con la memoria a breve termine e risulta perciò meno controllabile dall’emitten-
te rispetto alla produzione scritta in cui il messaggio persiste in quanto fissato
man mano sulla carta o, ad esempio, sullo schermo del computer o sulla lavagna
elettronica.
La sequenza parlata è tuttavia correggibile a seconda delle intenzioni del parlan-
te, dell’esito dei suoi atti comunicativi, della reazione dell’interlocutore: “
i cam-
biamenti di programma, le autocorrezioni, entrano come tali nel discorso e vengo-
no recepiti dall’ascoltatore (nello scritto tali cambiamenti vengono in vario modo
cancellati perché si scrive, oltre che lentamente anche, per così dire, quando si
vuole e col ritmo che si vuole; nel parlato invece il ritmo di produzione non è auto-
nomo: si è come costretti a continuare a parlare, a prendere la parola nel momento
richiesto dalla situazione e dall’interlocutore, ecc.). Di qui viene il carattere di
frammentarietà
del parlato: le pause di programmazione, le esitazioni, i cambia-
menti di programma, le autocorrezioni, le frasi incompiute e in genere la sintassi
fratta
” (Berretta, 1984, pp. 18-19).
Ciò vale maggiormente per quelle forme di parlato, quali la conversazione, le cui
caratteristiche linguistiche e testuali più si discostano dallo scritto. La scarsa
pianificazione incide particolarmente, sul piano linguistico, sui fenomeni di
concordanza, di ripresa pronominale, di coerenza e di coesione testuale attra-
verso una semplificazione o addirittura un collasso di relazioni funzionali, come
si può vedere nella trascrizione di questo dialogo, dove sono anche evidenti i
cambiamenti di “programma” determinati dal contesto, dalla situazione (il rien-
tro a casa, i saluti, la cena, il racconto della studentessa):
A: chi e’? chi e’? fatti vedere?
B: come stai?
2
Il parlato “
è caratterizzato, soprattutto se veloce, da fenomeni detti “di allegro”, cioè da fenome-
ni che determinano, nella catena parlata, frequenti aferesi, apocopi, assimilazioni, alterazioni e
semplificazioni di suoni, ecc., tali da rendere spesso difficilmente segmentabili e riconoscibili le
singole parole, specie per parlanti non nativi. Esempi italiani:
‘nsomma/’somma
;
‘sto per
questo;
son andato
(
anche
so’ andato
o so’ anda’ nell’italiano dell’Italia centrale, marcato dunque anche
in diatopia
);
arimmetica per
aritmetica
,
propio per proprio
” (Lavinio, 2009).
















