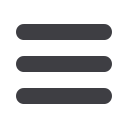

Capitolo 3
Modalità e tecniche per l’insegnamento e lo sviluppo delle abilità linguistiche
319
www.
edises
.it
cazione orale) e la
mediazione
ovvero la
traduzione
(nella comunicazione scritta).
Alle quattro abilità di ascolto, parlato, lettura e scrittura si aggiunge una quinta
abilità, l’abilità metalinguistica che si riferisce alle intuizioni che il parlante na-
tivo ha sulla propria lingua e sulla capacità di riflettere sulle sue caratteristiche
formali e d’uso. Un apprendente conoscerà la L2 quando avrà sviluppato in modo
adeguato anche questa quinta abilità.
Per sviluppare in modo corretto l’apprendimento di una lingua seconda o stra-
niera occorre conoscere alcune caratteristiche della lingua parlata e della lingua
scritta e dei processi che contraddistinguono le diverse abilità linguistiche. In
questo capitolo ci occuperemo delle quattro abilità di base e dell’abilità metalin-
guistica.
3.2
Alcune caratteristiche della comunicazione orale (ascolto e
parlato)
3.2.1
Fattori extralinguistici e contesto
Il parlato è generalmente associato a situazioni comunicative caratterizzate dal-
la compresenza degli interlocutori: si parla per lo più di situazione “faccia a
faccia”. In tali situazioni, nella determinazione del senso del discorso interven-
gono altri mezzi di comunicazione non verbali: mimica facciale, uso dello sguar-
do, gesti, posture che, realizzandosi in base a regole e convenzioni note, inter-
pretabili dall’interlocutore, sorreggono e amplificano il messaggio trasmesso dal
parlante e ne favoriscono la comprensione.
Tali mezzi possono integrare o sostituire segmenti o parti di enunciato, raccor-
dare enunciati e battute dialogiche tra loro, avere funzione di segnalare accordo,
disaccordo o stati d’animo quali lo stupore, la sorpresa, la meraviglia, la perples-
sità, l’incredulità, la stizza, l’ironia, ecc., e funzione di
feed-back
e possono colle-
gare direttamente l’enunciato con il contesto extralinguistico.
Nella comunicazione orale è inoltre possibile, da parte del parlante, fare riferi-
mento alle presupposizioni (idee, ipotesi, congetture), alle conoscenze e ai valo-
ri condivisi dall’interlocutore, a sottintesi, a elementi della situazione comunica-
tiva e lasciare quindi implicite determinate informazioni desumibili e inferibili
dal contesto della situazione complessiva che non vengono perciò enunciate. Se
io ho un dialogo, ad esempio:
– È tornato il sole!
– Era ora, non ne potevo più
le presupposizioni condivise dai due interlocutori possono essere, ad esempio:
–
Ha smesso di piovere
. È tornato il sole!
– Era ora, non ne potevo più
di questo mal tempo
/
di questi giorni di pioggia.
Tale componente è presente in molti atti di comunicazione, anche scritta, ma
essa ha indubbiamente, nel parlato, un peso e un’influenza maggiori, tali da de-
terminare in esso un più alto grado di implicitezza e di ellitticità rispetto allo
scritto.
















