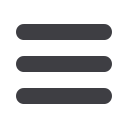

Capitolo 3
Modalità e tecniche per l’insegnamento e lo sviluppo delle abilità linguistiche
327
www.
edises
.it
Una volta acquisita la lingua scritta come sistema di trascrizione, non è detto
che si sappia scrivere. Non sapere scrivere significa spesso limitarsi a trascrivere
il proprio modo di parlare, in quanto si ignorano le caratteristiche specifiche
dello scrivere che lo distinguono dal parlare, al di là della diversità del segnale
fisico. Nell’ambito di una didattica dello scrivere in L2 o straniera lo sviluppo
dell’abilità di scrittura è necessariamente correlato allo stadio
dell
’
interlingua
dell’apprendente, le caratteristiche della quale occorre tener presenti nella piani-
ficazione e nella costruzione delle attività di produzione considerando, inoltre,
che scrivere contribuisce a sua volta in modo significativo allo sviluppo dell’in-
terlingua stessa dell’apprendente;
c)
distanziata
: scrivere un testo comporta, si è detto, una maggiore pianificazio-
ne e organizzazione del testo stesso e una maggiore attenzione a livello delle
scelte lessicali e sintattiche. Va aggiunto che scrivere richiede anche una capaci-
tà di mediazione cosciente che si interponga tra la “realtà” della situazione e
dell’argomento, il vissuto immediato e l’atto stesso dello scrivere. In altri termi-
ni, lo scritto non può essere immediato, come spesso l’orale, non solo in termini
di tempo, ma anche in termini di punto di vista. Salvo forse che per i messaggi
più informali, e per quelli che si producono “chattando” o per e-mail – con carat-
teristiche che si sovrappongono a quelle dell’orale – l’io che scrive è sempre un
io “costruito”. Da un punto di vista pedagogico ciò comporta il passaggio da un
uso del linguaggio come proiezione immediata dell’io ad un uso più riflessivo e
controllato;
d)
controllata
: più sopra si accennava al fatto che, diversamente dalla comunica-
zione orale, l’assenza di retroazione nella comunicazione scritta accresce le pos-
sibilità di fraintendimento del testo da parte del lettore. Chi scrive deve perciò
organizzare e controllare il processo di sviluppo interno del testo, definire ed
esplicitare nel testo un “programma di lettura” (e questo richiede un alto livello
di pianificazione sia del contenuto che della forma linguistica) in modo che il
lettore comprenda esattamente ciò che chi scrive vuole che capisca.
L’articolazione transfrastica, la concatenazione dei paragrafi vanno organizzati
conformemente alle convenzioni della forma testuale a cui il testo appartiene e
ai principi di un’efficace costruzione testuale, in modo da evitare discontinuità e
travisamenti nell’attività di decifrazione del lettore.
Chiaro è qui il riferimento ai principi costitutivi e regolativi del testo,
coerenza
,
appropriatezza
,
efficienza
,
efficacia
, e inoltre al fatto che scrivere un testo consiste
nel seguire i principi costitutivi della forma testuale e del tipo di testo al quale
essa appartiene (ad esempio, la forma della cartolina, della lettera informale o
formale, degli appunti, dei messaggi ad uso personale, della ricetta, dell’articolo,
ecc.: i tipi informativo, descrittivo, narrativo, argomentativo, ecc.). Il riconosci-
mento di questi principi tipologici da parte del lettore consente una corretta
comprensione e interpretazione del testo propostogli dallo scrivente.
Questa capacità dello scrivente di creare un programma di lettura dipende dalla
qualità della sua esposizione a testi scritti, dal fatto che egli abbia o non abbia
assunto le regole di una grammatica del testo attraverso pratiche di lettura ade-
















