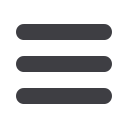
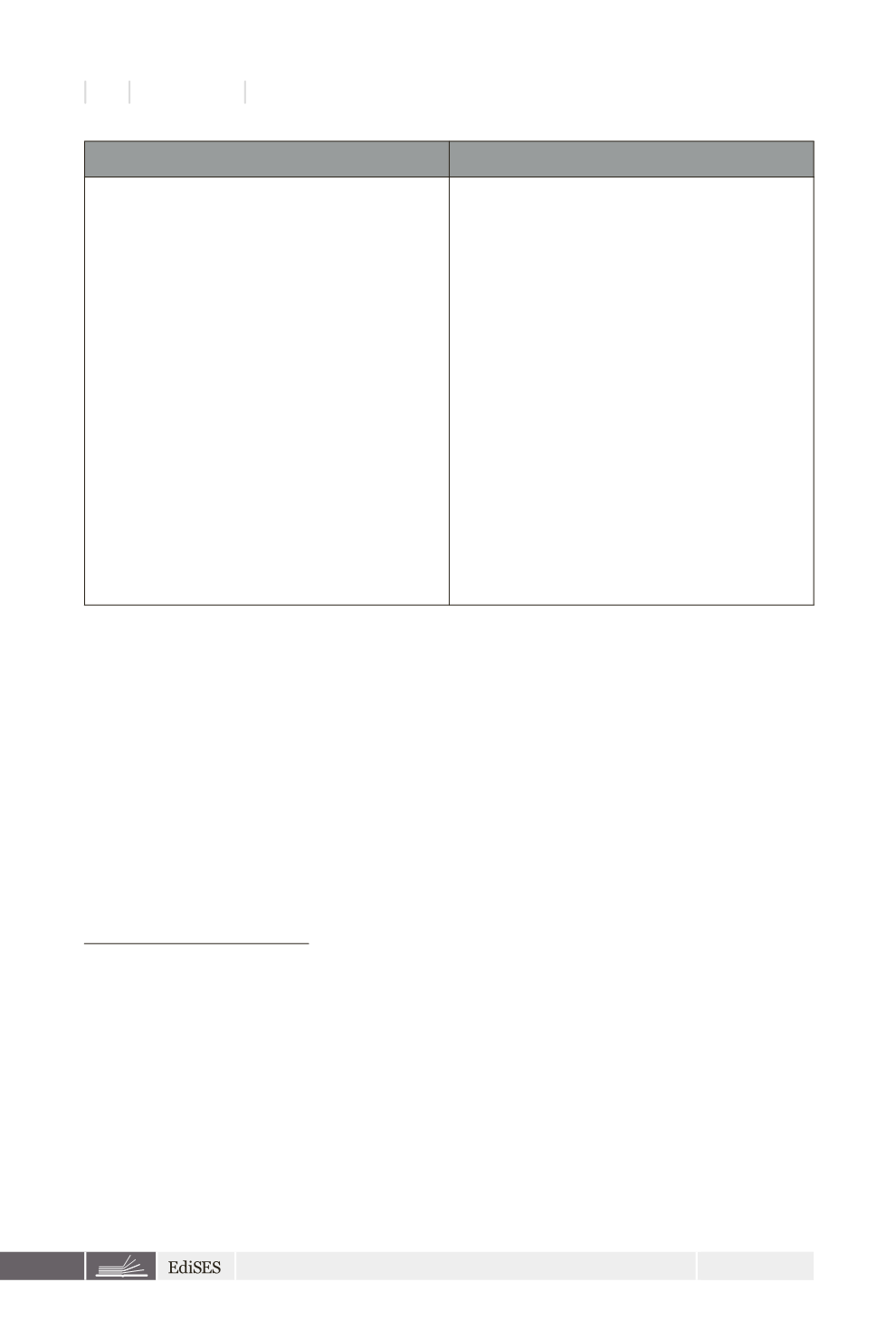
330
Parte Seconda
L’insegnamento dell’italiano lingua non materna (L2)
www.
edises
.it
PARLATO
SCRITTO
Il “testo” parlato, orientato verso una mag-
giore informalità, ha proprie le caratteristi-
che del linguaggio “informale”: è perciò
meno controllato, organizzato, strutturato e
pianificato, il periodare è breve, tendenzial-
mente paratattico o giustappositivo, mono-
proposizionale; il lessico è più generico ed è
poco diversificato
1
.
Il testo scritto più è formale più deve essere
pianificato e controllato: durante la sua ste-
sura chi scrive può “riscrivere”, può cioè in-
tervenire sul suo testo modificandolo fino ad
una stesura definitiva che ritiene soddisfare
in modo adeguato le caratteristiche e i prin-
cipi costituitivi:
–
del testo scritto: scopo, coerenza, coesio-
ne, informatività, efficacia, efficienza, ap-
propriatezza;
–
del tipo di testo (narrativo, descrittivo, ar-
gomentativo, espositivo, regolativo) e del-
la forma testuale (ad esempio, lettera, rac-
conto di un’esperienza personale, descri-
zione di un ambiente, di una persona, di
oggetti nel racconto di un evento, appunti,
riassunto, relazione, ecc.) che si è inteso
produrre in funzione della situazione e
dello scopo comunicativi.
3.4
I processi sottesi alle abilità linguistiche ricettive (ascoltare
e leggere)
Nella comprensione si possono mettere in atto diversi tipi di processi:
a)
dall’alto
(
top-down
): sono processi di tipo deduttivo, guidati dal sistema co-
gnitivo e da modelli concettuali, quindi dalle conoscenze, dalle regole generali,
dalle aspettative, ecc. di chi ascolta o legge. In un approccio dall’alto la compren-
sione è un’attività intenzionale, interattiva: consiste nel fare previsioni circa il
contenuto del “testo” orale o scritto sulla base dell’esperienza e delle conoscenze
di cui chi ascolta o legge è in possesso e nell’utilizzare il testo stesso per confer-
1
Nel parlato conversazionale “
vengono in genere selezionate anche le congiunzioni subordina-
tive più comuni e più versatili, il cui uso è talora indebitamente esteso (si pensi al fenomeno del
che polivalente
nelle sue varie manifestazioni, più o meno marcate:
son tre giorni che non dor-
mo; prendi l’ombrello che piove; la ragazza che le ho dato il libro…);
sono comuni anche gli
anacoluti che dipendono dalla scarsa progettualità dell’espressione orale; è tipico
della sintassi
dei testi parlati anche l’uso di costruzioni marcate, che tendono a spostare elementi salienti della
frase in posizioni di particolare evidenza
(dislocazione a destra, dislocazione a sinistra)
o a ot-
tenere lo stesso effetto tramite la segmentazione di frasi semplici
(frase scissa, frase pseudoscis-
sa, c’è presentativo). […]
In merito al lessico,
[oltre che alla selezione di termini generici, ad
alta disponibilità]
se il rapporto che lega emittente e destinatario lo consente, il discorso orale si
dimostra aperto all’accoglimento di forme alterate (derivazione), di termini espressivi o disfemici,
di dialettismi, di gergalismi, di geosinonimi, di stranierismi più di quanto non lo sia l’espressione
scritta”
(Prada, 2003:148-149).
















