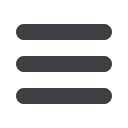
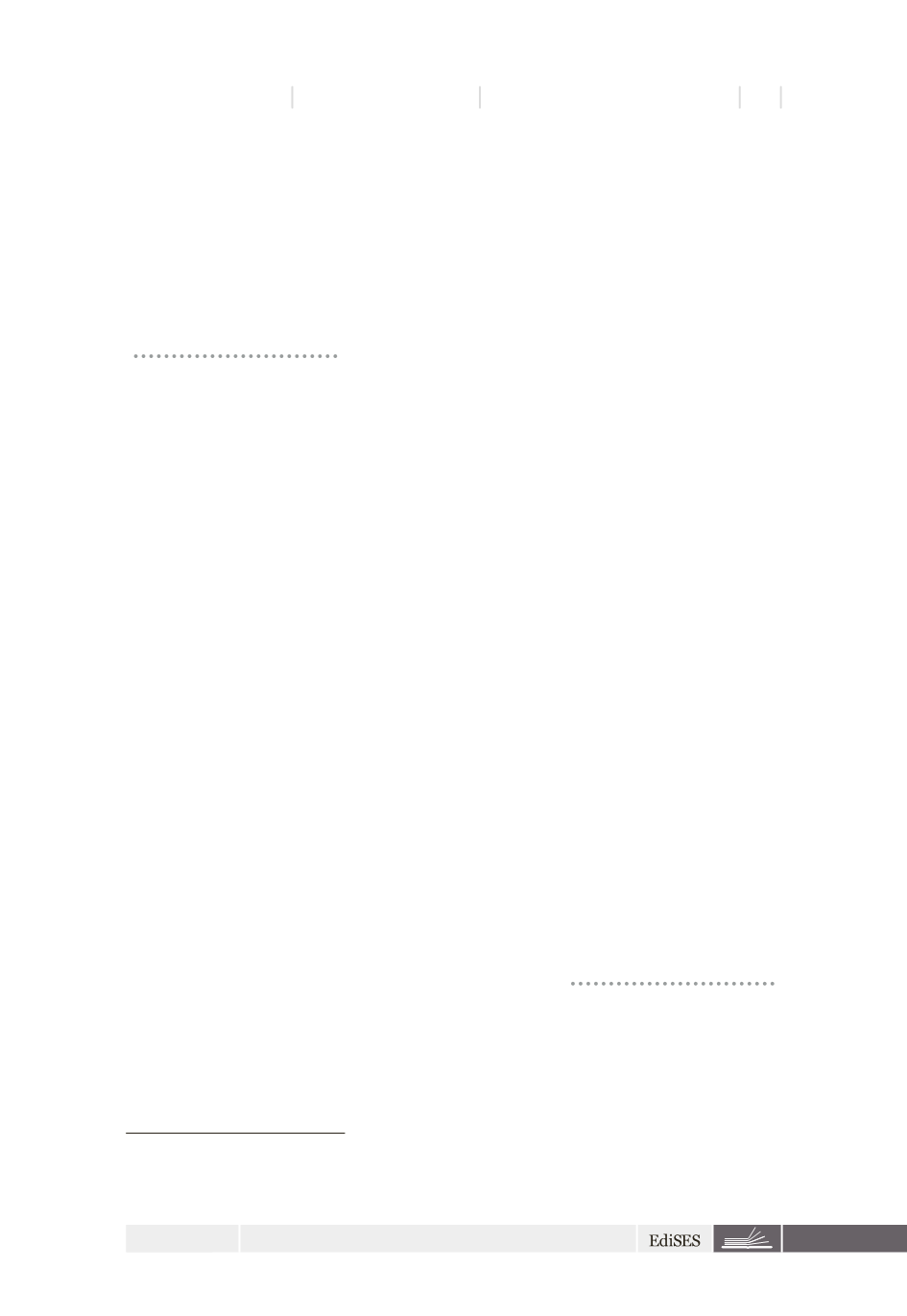
Unità di Apprendimento 1
Contrattualismo e neocontrattualismo
427
www.
edises
.it
come per lui, all’opposto di Hobbes, l’uomo sia naturalmente buono, finché
rimane in uno stato di natura primitivo e innocente, e come con lo sviluppo
delle arti e delle tecniche, e in particolare con l’introduzione della proprietà
privata, i nuovi egoismi portano a generare invidie, sopraffazioni, conflitti,
rendendo necessario stipulare un contratto istitutivo della società civile e
delle leggi.
Delineato questo quadro si trattano i termini del contratto partendo dall’anali-
si di alcuni brani significativi del filosofo francese.
Documento 6
6
(Occorre) trovare una forma di associazione che difenda e protegga con tutta la forza co-
mune la persona e i beni di ciascun associato; e per la quale ognuno, unendosi a tutti, non
ubbidisca tuttavia che a sé stesso, e resti altrettanto libero come prima. (…) Le clausole di
questo contratto, bene intese, si riducono tutte a una sola: cioè l’alienazione totale di cia-
scun associato, con tutti i suoi diritti, alla comunità. (…) Il patto sociale si riduce ai termini
seguenti: ciascuno di noi mette in comune la sua persona e tutto il suo potere, sotto la
suprema direzione della volontà generale; e noi tutti in corpo riceviamo ciascun membro
come parte indivisibile del tutto. Immediatamente (…) in cambio della persona privata di
ciascun contraente, quest’atto di associazione produce un corpo morale e collettivo, com-
posto di tanti voti quanti membri ha l’assemblea: il quale riceve da questo atto la sua unità,
il suo io comune, la sua vita e la sua volontà.
Documento 7
7
La volontà generale può sola dirigere le forze dello Stato secondo il fine della sua istituzio-
ne, che è il bene comune, ossia ciò che vi è di comune fra gli interessi privati, e che forma
il vincolo sociale. (…) La sovranità, non essendo che l’esercizio della volontà generale, non
può mai alienarsi, e il sovrano, che non è se non un ente collettivo, non può essere rap-
presentato che da sé stesso: può bensì trasmettersi il potere, ma non la volontà. (…) Per la
stessa ragione che la sovranità è inalienabile, essa è indivisibile. (…) La volontà generale è
sempre retta e tende sempre all’utilità pubblica; ma non ne consegue che le deliberazioni
del popolo abbiano sempre la stessa rettitudine. Si vuol sempre il proprio bene, ma non
sempre lo si vede: non si corrompe mai il popolo, ma spesso lo si inganna, ed allora soltanto
esso sembra volere ciò che è male. V’è spesso grande di erenza tra la volontà di tutti e la
volontà generale: questa non guarda che all’interesse comune, l’altra guarda all’interesse
privato e non è che una somma di volontà particolari: ma togliete da questa volontà il
più e il meno, che si distruggono a vicenda, e resta per somma delle di erenze la volontà
generale.
Emergeranno, quindi, la ricerca di un contratto giusto, il valore e i termini della
sovranità popolare, il ruolo e il senso del governo, ecc.
6
J.J. Rousseau,
Contratto sociale
, libro I, capitolo 6.
7
Ivi
, libro II, capitoli 1 e 3.
















