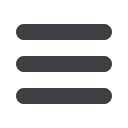
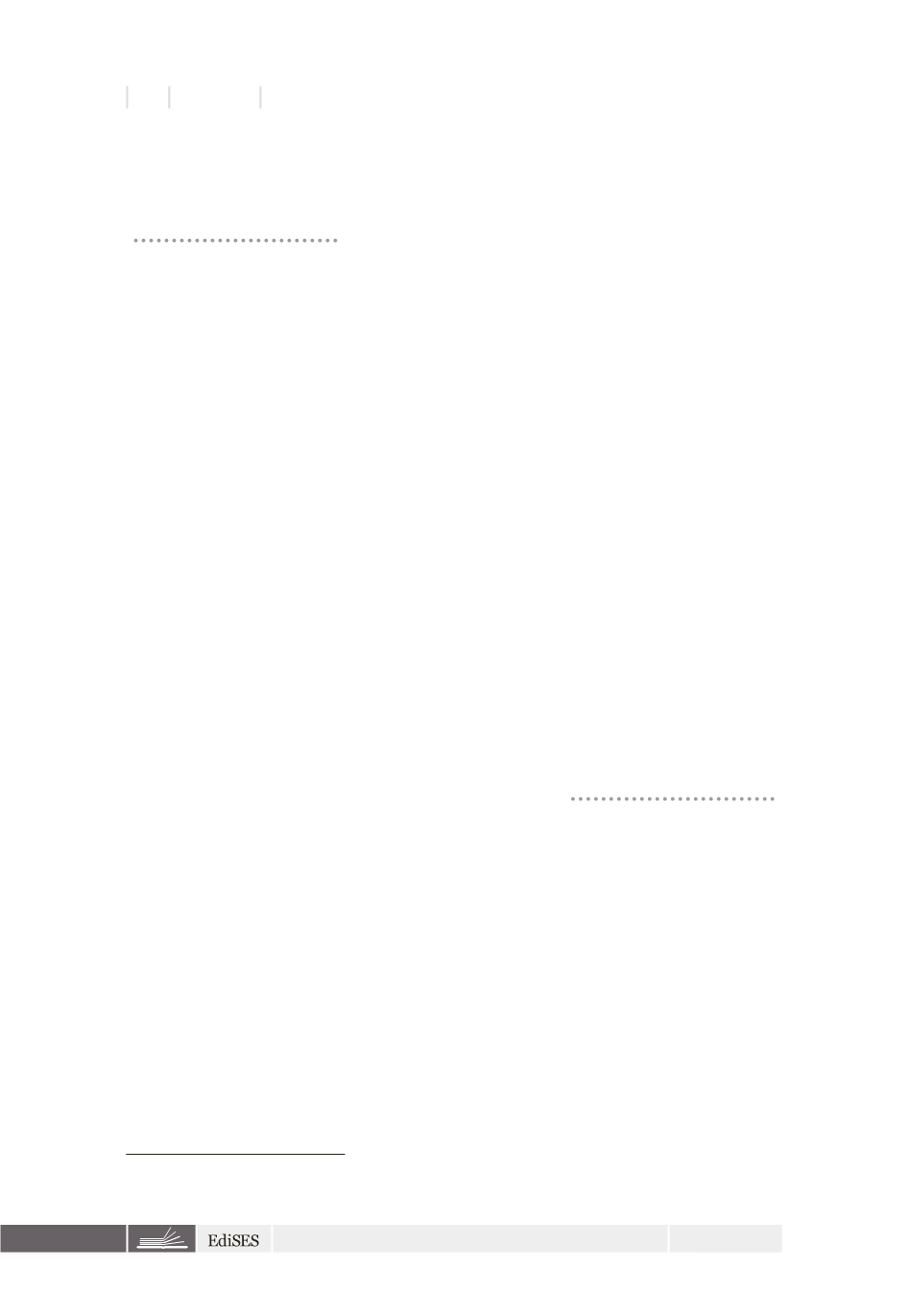
426
Parte Terza
Esempi di Unità di Apprendimento
www.
edises
.it
siero di Spinoza, ossia, in particolare, l’importanza del potere assoluto unita
alla necessità che questo potere sia moderato, tollerante e rispettoso dei diritti
naturali.
Documento 5
5
Il diritto naturale di ciascuno è determinato non dalla retta ragione, ma dal desiderio e
dalla potenza (…) qualunque cosa ciascuno, considerato sotto il solo comando della natura,
giudica per sé utile, o per la guida della retta ragione o per l’impeto delle passioni, per su-
premo diritto di natura gli è lecito appetirla e prenderne possesso in qualunque modo, sia
con la forza sia con l’inganno sia con le preghiere. (…)
Ha il supremo diritto su tutti colui che ha la suprema potestà, con la quale può costringere
tutti con la forza e tenerli a freno con la paura del supremo castigo, temuto da tutti senza
eccezione; e manterrà questo diritto fintantoché manterrà questa potenza di fare ciò che
vuole, altrimenti comanderà in maniera precaria... Ne segue che la suprema potestà non è
obbligata da nessuna legge, mentre invece tutti devono ubbidire a essa: infatti tacitamente
o espressamente tutti dovettero pattuirlo allorché trasferirono ad essa ogni propria potenza
di difendersi, quindi ogni loro diritto. (…)
Invano infatti [la suprema potestà] comanderebbe al suddito di odiare chi lo ha legato a sé
con un beneficio, di amare chi gli ha recato danno, di non sentirsi o eso dalle ingiurie, di
non desiderare di liberarsi della paura, e molte altre cose simili che derivano necessaria-
mente dalle leggi della natura umana. (…)
Se dunque nessuno può rinunciare alla propria libertà di pensare e giudicare ciò che vuole
ma ciascuno per massimo diritto di natura è padrone dei propri pensieri, segue che mai
nello Stato si può tentare, se non con esito del tutto infelice, di fare in modo che gli uomi-
ni, sebbene siano di opinioni contrarie, non dicano niente se non quanto è prescritto dalle
supreme potestà... Ciascuno ha rinunciato soltanto al diritto di agire in base alla propria
decisione, ma non di ragionare e giudicare; e perciò può senz’altro ragionare e giudicare
anche contro il decreto delle supreme potestà, a condizione che parli e insegni soltanto
con schiettezza e sulla base della ragione, e non con inganno, con ira, con odio.
A questo punto, si può introdurre il pensiero di Kant e mostrare come il con-
trattualismo tenda a “scoprire le carte” e a rivelare che quella del contratto è
solo una
ctio iuris
. Il docente potrebbe qui soffermarsi sulla funzione della
ctio
.
Quindi si mostra come il “patto” diventa una metafora, o un sinonimo, per
“unione civile”; si tratterebbe allora di un “patto obbligato” e, come tale, singo-
lare, perché a detta di Kant per gli uomini lasciare lo stato di natura ed entrare
in un’unione civile è necessario e moralmente doveroso, e conseguente alla loro
innata dignità.
Possiamo, ora, affrontare Rousseau, il cui contrattualismo ha caratteristi-
che profondamente diverse rispetto a quello individualistico degli autori
precedenti, e la cosa va preliminarmente fatta notare. Quello di Rousseau è
un contrattualismo innovativo e “sociale”. Si deve innanzitutto sottolineare
5
B. Spinoza,
Trattato teologico-politico
, capitoli 16, 17, 20.
















