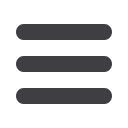
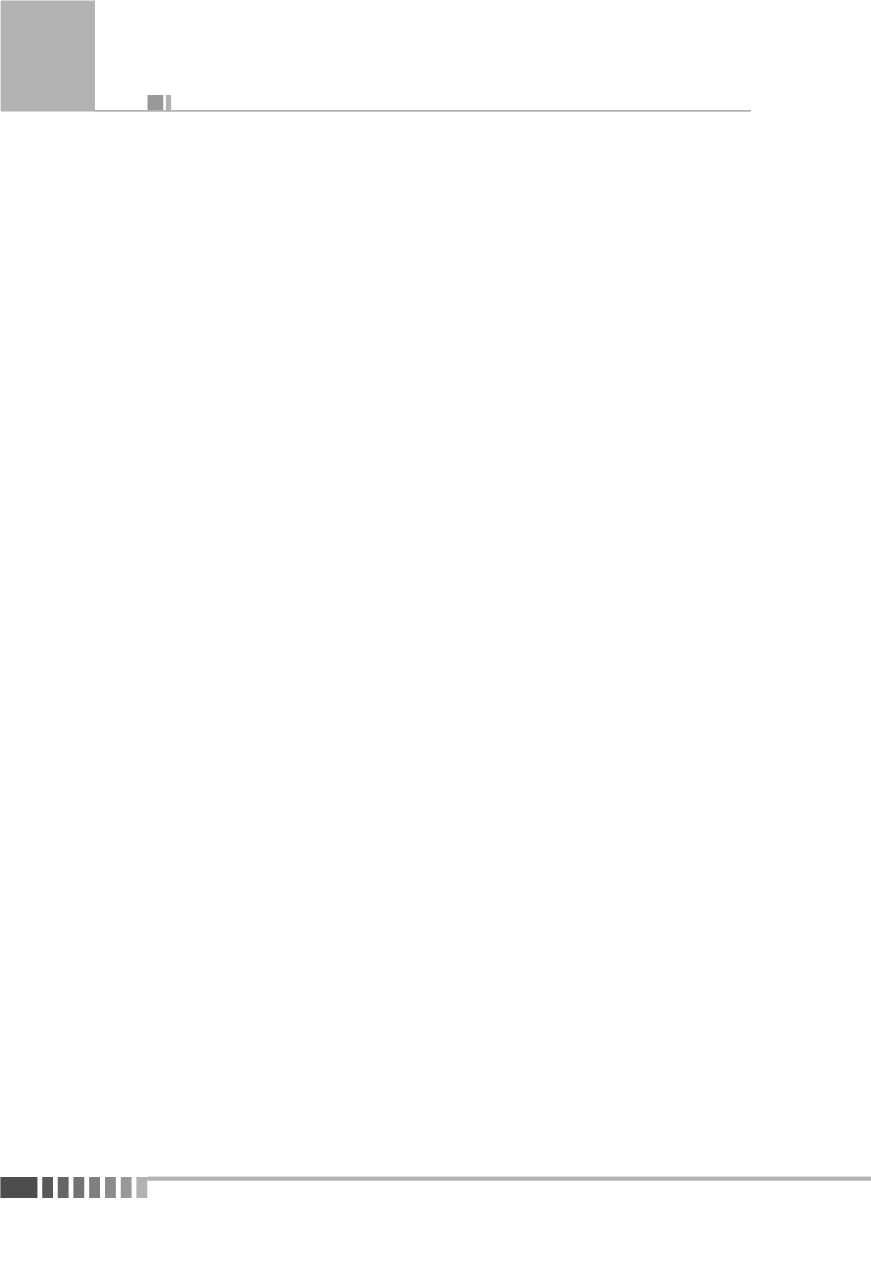
14
Parte I - Prerequisiti
20) Tra le osservazioni qui riportate UNA SOLA NON È DEDUCIBI-
LE dai dati raccolti:
A. nella popolazione esaminata convincere gli incerti può modificare
radicalmente la percentuale di assenso alla donazione da cadavere
B. nella popolazione esaminata l’incertezza nei confronti della donazio-
ne da cadavere è superiore a quella relativa al trapianto da vivente
C. nella popolazione esaminata i ragazzi non sono convinti dell’efficacia
terapeutica del trapianto renale
D. riguardo alla popolazione esaminata mancano i dati relativi ai risul-
tati dei due tipi di trapianto
21)
“La realtà storica è unica, le diverse discipline e scienze operano su
di essa, la interpretano e la rappresentano attraverso specifici linguag-
gi, artistici, tecnici, comuni, matematici, scientifici, musicali, filosofici.
Dietro ogni linguaggio c’è un’epistemologia, una particolare struttura
logica che coglie una prospettiva, un punto di vista, ma l’acquisizione
dei diversi sistemi concettuali deve essere coerente. È solo l’unità delle
prospettive che forma il patrimonio culturale, che consente di cogliere
sistemi, connessioni e relazioni nel tutto. Interdisciplinarità non significa
allora fine delle discipline né annullamento delle differenze. Annullare
una disciplina potrebbe comportare la riduzione di una parte della realtà.
L’interdisciplinarietà non è un complesso di conoscenze, è una metodo-
logia, anche didattica, una forma mentis, un modo diverso non solo di
costruire conoscenze e d’insegnare, ma anche di comprendere e di vivere
la realtà, l’ambiente socio-culturale e storico-geografico che ci circonda.
Uno dei più rilevanti problemi del nostro tempo è proprio ‘la sintesi delle
conoscenze, possibile solo in una visione interdisciplinare complessiva che
riconduca anche le scienze e la tecnologia alla ricerca sull’uomo. La sintesi
interdisciplinare non è mai una somma, né il risultato di esemplificazioni:
è l’interazione di linguaggi diversi, tradotti, confrontati, interconnessi e
armonizzati attraverso la scoperta di analogie e differenze. La cultura del-
la complessità si sviluppa in una difficile e sofferta dicotomia tra umanisti
e scienziati, che non sembra ancora riuscire a conciliare la differenziazio-
ne e l’autonomizzazione con l’interconnessione sistemica. Scienza e tec-
nologia debbono tornare a essere strumenti finalizzati all’uomo, alla sua
felicità e libertà, per prevenire quella eliminazione della libertà personale,
quella dittatura non più fisica, ma mentale, ipotizzata da George Orwell
in 1984, attraverso il tentativo di rendere immortale il Grande Fratello. La
scuola deve confrontarsi sulla dicotomia tra la cultura umanistica e quella
scientifico-tecnologica, e i docenti non possono delegare ai singoli studenti
















