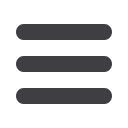

11
Comprensione di testi
nome in (quasi) partenza l’hanno cambiato anche i due fratelli più famosi
del Novecento italiano, Giorgio de Chirico e Alberto Savinio, l’uno pittore,
l’altro talento più poliedrico. E il minore, Alberto, lo cambiò perché, quan-
do cominciò a lavorare a Parigi, il fratello era già conosciuto. Da dove, poi,
lo pseudonimo saltasse fuori, non si sa con certezza. (…) Oggi Ruggero
Savinio (che è figlio di Alberto Savinio e ha voluto, invece, conservare il
nome paterno) è un pittore affermatissimo: s’è appena chiusa la mostra
dei suoi ultimi lavori, a Montecitorio. (…) C’era un “understatement” in
Savinio senior, un metter la professione in prospettiva, che il figlio ricor-
da con gratitudine: “Un pomeriggio nello studio di mio padre, avrò avuti
sedici anni, lui parla di me con un amico in visita. Gli dice: “Vorrei che
Ruggero diventasse un grande uomo. O almeno un grande pittore.” Mi
ricordo la frase per quell’“almeno”, una specie di viatico…”
M.G. Minetti,
Destino d’artista
, “Specchio”, 21/4/2001
Il discorso di Minetti suscita alcune riflessioni e suggerisce alcune
considerazioni: tra quelle qui riportate, UNA CONTRADDICE quanto
si afferma nell’articolo. Quale?
A. Un nome famoso costituisce un peso certamente, ma non si può
escludere che offra anche alcuni vantaggi, non ultimo quello di smi-
tizzare il valore della fama
B. Con un padre famoso, poco o molto che sia, ai nostri giorni un figlio
deve essere dotato di determinazione e coraggio per seguire la mede-
sima strada
C. Il nome di famiglia, se noto, è stato per secoli un titolo di credito da
esibire; dal Romanticismo in poi è diventato un’eredità da rifiutare
D. Da circa duecento anni figli, fratelli e nipoti si tengono rigorosamente
alla larga dalla professione di genitori e parenti, mentre era frequente
nel passato che figli, fratelli e nipoti coltivassero l’arte per cui i loro
familiari erano famosi
16)
“Dal fatto che le opinioni si rivelano tutte ugualmente confutabili o
sostenibili, Socrate non trae, come Protagora, la convinzione che la dialet-
tica abbia il compito di persuadere o dissuadere in merito all’una o all’al-
tra, indipendentemente dal vero, cioè egli non ne evince la tesi che tutte le
opinioni sono vere, bensì, al contrario, che esse, in quanto possono essere
tanto vere quanto false, non hanno quel carattere di sapere stabile proprio
dell’universale, cioè della scienza. Il compito della dialettica diventa un
compito critico: essa non deve mettersi al servizio di questa o di quella opi-
nione, per sostenerla o per demolirla, ma deve invece mettere alla prova
















