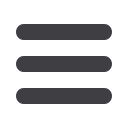

12
Parte Prima
Elementi di progettazione per una lezione efficace
prodotto di osservazione analitica. Un itinerario lineare di apprendimento,
pertanto, sembra non corrispondere al processo di apprendimento natu-
rale del bambino, fondato principalmente sull’osservazione di fatti e feno-
meni.
Un’acquisizione di conoscenza, veicolata prevalentemente dall’ascolto,
inoltre, necessita di comportamenti connotati da immobilismo e silenzio.
Il gruppo-classe, in ognuna delle nostre scuole, infatti, è apprezzato se cia-
scun allievo siede compostamente nel proprio banco, in fila, l’uno dietro
l’altro, ben disposto a un ascolto attento, impegnato in esercitazioni di-
sciplinari che escludono la collaborazione con i compagni, elemento di
disturbo, questo, anche per una valutazione delle abilità.
Le regole prevalenti dell’essere disciplinato nella scuola restano ancor
oggi, come ai tempi di Gian Burrasca, il “far silenzio” e lo “star fermi” nel
proprio banco.
Ci chiediamo allora: quale comunicazione, scambio di idee, condivisione di
scopi e cooperazione può essere in questa dimensione individuale e passiva
dell’apprendere?
Un siffatto modello di apprendimento, sostanzialmente per ricezione,
privilegiato ancor oggi dalla scuola, è congruente con gli stili cognitivi
che gli allievi del nostro tempo hanno sviluppato, oggi, in contesti diversi
rispetto al passato?
I linguaggi tecnologici e la ricorsività e modularità degli ambienti informa-
tici, la pluralità e la simultaneità degli stimoli esercitati dai mass media han-
no favorito nelle nuove generazioni lo sviluppo di stili di apprendimento di
tipo reticolare, connotati dal metodo della comparazione.
Gli allievi, pertanto, percepiscono come “monotono” un apprendimento
di tipo “lineare”, mentre vengono sollecitati nelle loro curiosità da situa-
zioni complesse, critiche, che pongono problemi e invitano a risolverli. In
tal caso, nascono motivazioni all’impegno, attenzione al compito, tensioni
attualizzanti verso la realizzazione di mete progettuali.
Proporre loro, anziché spiegazioni e “lezioni” prefigurate, problemi da
risolvere, e da questi ultimi far scaturire domande e orientare la ricerca
delle risposte verso le conoscenze disciplinari, luogo dei “saperi” storica-
mente determinati, significa ricostruire “dal di dentro” le discipline con
piena consapevolezza dei linguaggi e delle logiche che le connotano. Si-
gnifica, altresì, comprendere che le conoscenze disciplinari non sono se-
parate o appartenenti a culture diverse (per esempio, quella scientifica e
quella umanistica) ma costituiscono prospettive particolari da cui osservare
l’unità del “reale”. In natura, infatti, non esistono discipline, ma “reali”:
ciascun “reale” è “unità molteplice” di aspetti descrivibili (attraverso l’uso
della lingua), collocabili sulla linea del tempo (prospettiva della storia) e
nello spazio, quale luogo di fatti e fenomeni (prospettiva della geografia),
misurabili e quantificabili (prospettiva della matematica).


















