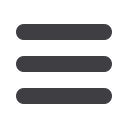
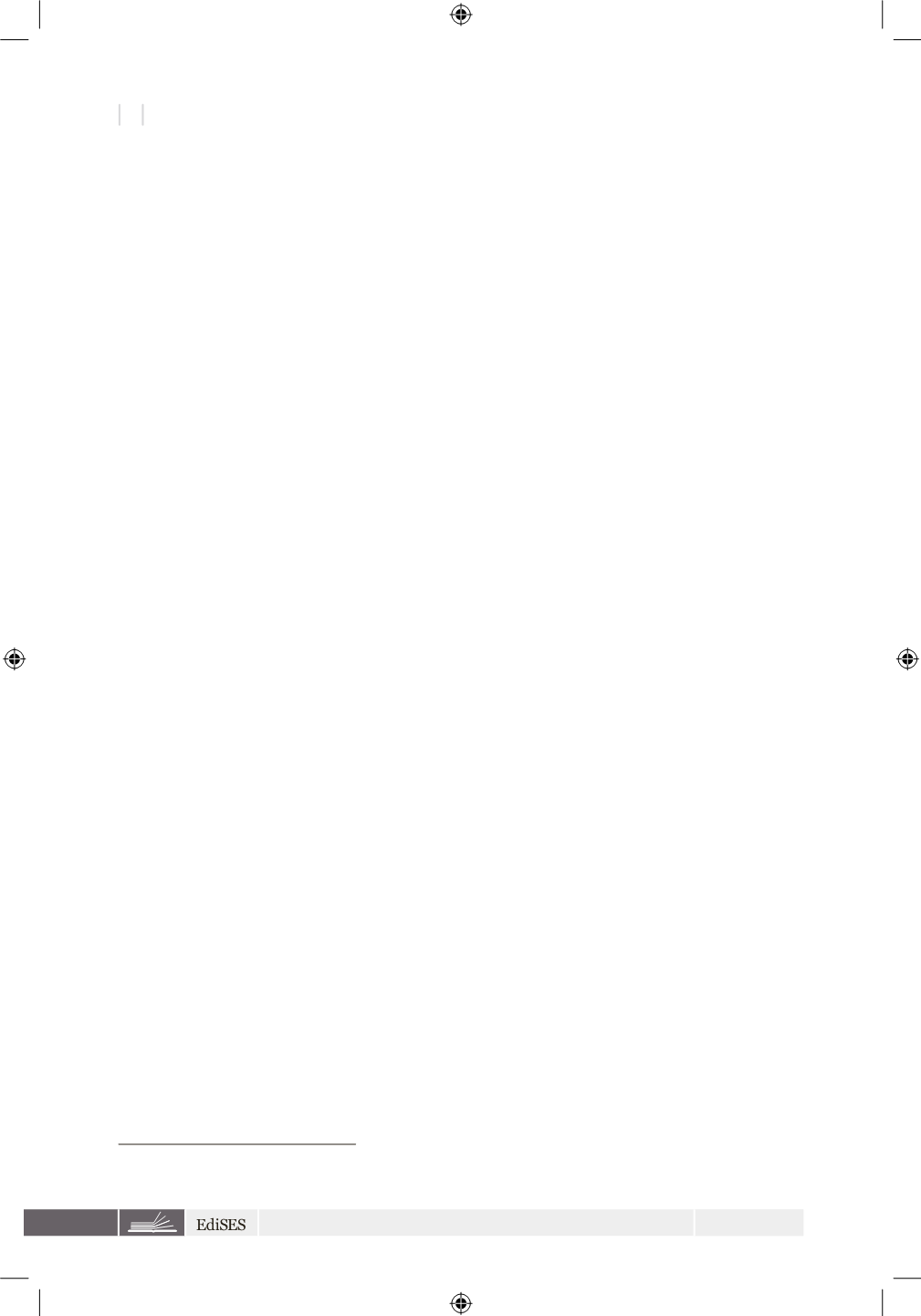
www.
edises
.it
4
Metodi e strumenti per l’insegnamento e l’apprendimento della Chimica
decifrabile soltanto da una élite ristretta in possesso di certi codici specializzati e non sarà
un caso che le esperienze letterarie più autenticamente feconde del nostro Novecento, le
più innovative, le più ricche di contenuto nutrizionale per la mente del lettore, ci vengano
da tre scrittori i cui interessi tecnico-scientifici si sono felicemente coniugati con un solido
sostrato di cultura classica: l’ingegner Carlo Emilio Gadda, Italo Calvino (figlio di bota-
nici, che aveva fatto sua la disposizione ordinatrice e classificatrice dei genitori), e Primo
Levi, dottore in chimica...
Lo scienziato è mosso dalla curiosità: essere curiosi significa osservare, porsi delle
domande e trovare delle risposte. La ricerca delle risposte richiede certamente un
ragionamento rigoroso, un approccio analitico, “scientifico”, che però deve essere
accompagnato dalla fantasia e dall’abbandono di qualsiasi pregiudizio. La fantasia è
peraltro alla base di ogni espressione artistica (letteratura, cinema, pittura, scultura,
musica …). La fantasia è il minimo comune denominatore per la scienza e per l’arte,
che sono due facce della stessa medaglia, derivanti entrambe dalla curiosità innata
dell’essere umano e dal duplice desiderio di esplorazione: interiore (l’arte in ogni
sua forma come espressione del sé) ed esteriore (la scienza studia il mondo che ci
circonda).
L’esplorazione del sé e del mondo intorno a noi è un desiderio particolarmente forte
e trainante nei bambini, e per questo motivo l’insegnamento della scienza ed un
approccio scientifico nell’osservazione del mondo esteriore dovrebbero essere intro-
dotti fin dalla scuola dell’infanzia. Chi è più fantasioso dei bambini?
L’approccio umanistico e quello scientifico dovrebbero aver ugual peso e integrarsi
l’uno con l’altro nella programmazione della didattica nella scuola dell’infanzia e, a
maggior ragione, nella scuola primaria.
La disputa tra chi pratica le scienze e chi si occupa di materie umanistiche trova pro-
babilmente una prima testimonianza nella cultura del Novecento nella pubblicazione
del chimico britannico Charles P. Snow,
Le due culture
(1959). Il dibattito sulle “due cul-
ture”, che cerca di portare all’affermazione dell’una sull’altra, è un tema chiave di tutti
i tempi, attuale anche nella nostra società, come dimostrano le diverse opere di autori
italiani e stranieri. Talvolta, ad inasprire il dibattito, intervengono notizie di cronaca
in cui la scienza e il progresso tecnologico da essa derivante sono ritenuti responsabili
di varie calamità: dai disastri ecologici agli effetti collaterali imprevisti e/o dannosi di
farmaci a ogni tipo di inquinamento (reale, presunto o ipotetico).
Scrive S. J. Gould, ne
La vita meravigliosa
: “Io temo che
Homo sapiens
sia una cosa
tanto piccola in un vasto Universo, un evento evolutivo estremamente improbabile
nell’ambito della contingenza. Il lettore può prendere questa conclusione come gli
pare. Alcuni troveranno questa prospettiva deprimente, io l’ho sempre considerata
esaltante: una fonte insieme di libertà e di conseguente responsabilità morale”.
L’uomo ha una responsabilità morale; la scienza è un’espressione dell’attività umana,
e come tale soggetta ai limiti della nostra natura, del nostro egoismo, del non otti-
male (se non talvolta pessimo) utilizzo delle nostre scoperte. Esempio sicuramente
significativo è la ricerca nell’ambito dell’energia nucleare
2
i cui studi sono stati appro-
fonditi quasi esclusivamente per soddisfare impieghi bellici e che solo in un secondo
2
La storia, la scienza e la politica dell’energia nucleare sono raccontate nel saggio di Giancarlo
Sturloni dal titolo
L’atomo diviso
, Sironi Ed.
















