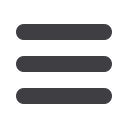
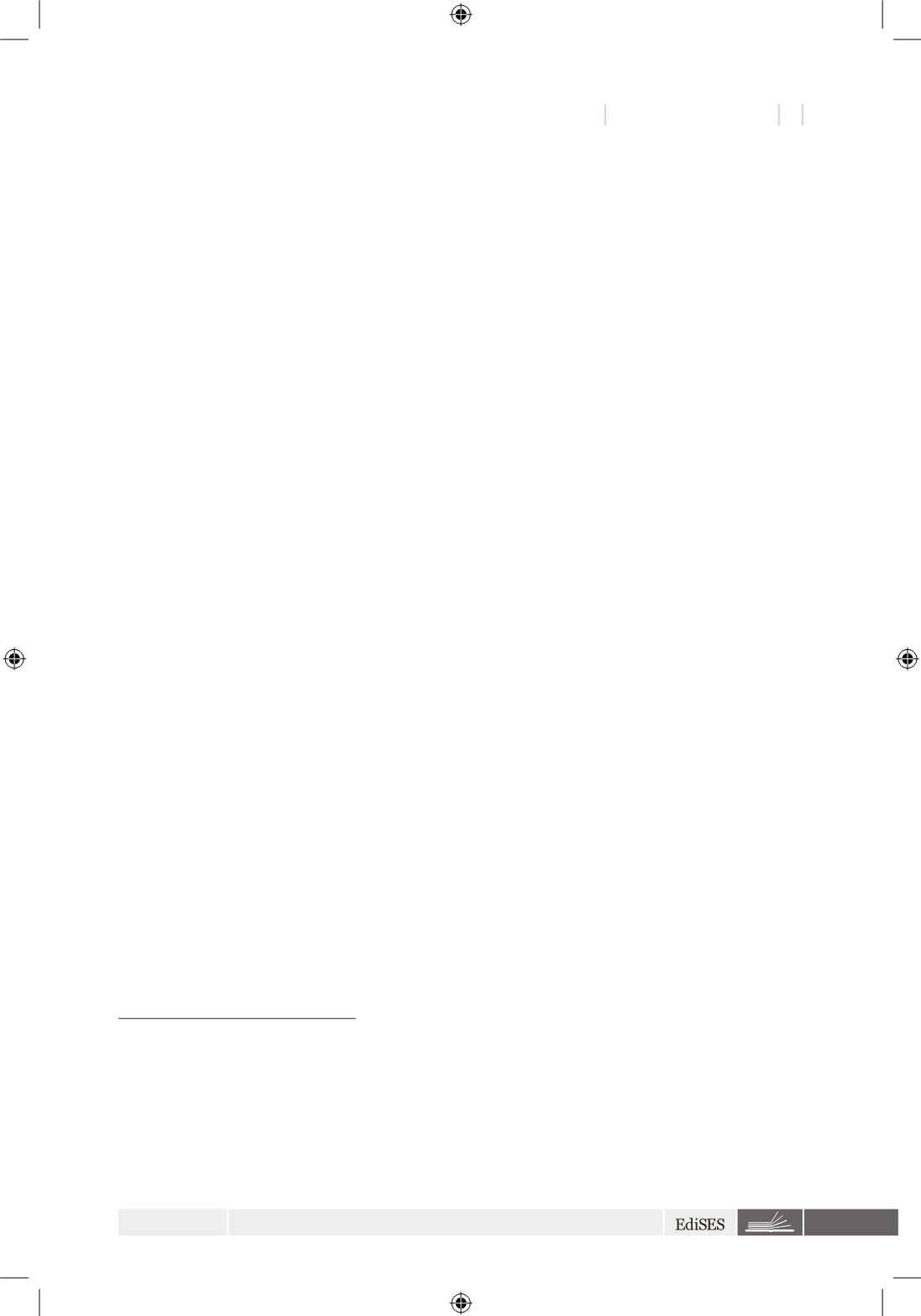
www.
edises
.it
CAPITOLO
1
Scienza, chimica e società
5
tempo hanno portato ad applicazioni in ambito civile (importantissime tra l’altro
quelle in campo medico-diagnostico).
A questo proposito è significativo il commento di K. Bainbridge, responsabile del Tri-
nity Test, effettuato il 16 luglio 1945 nel New Mexico: “Nessuno che l’abbia visto potrà
dimenticare quel laido e terribile spettacolo. Ora siamo tutti figli di puttana”. In queste
poche forti parole appare assolutamente evidente che l’uomo è totalmente responsabi-
le dell’utilizzo delle conoscenze acquisite tramite lo studio e la ricerca.
Al dibattito sulla rilevanza culturale della scienza rispetto alle discipline umanistiche
si aggiunge la percezione comune che le discipline scientifiche, prime tra tutte la
fisica, la chimica e la matematica, siano così difficili da risultare inaccessibili. Re-
sponsabile di questa percezione è il linguaggio utilizzato dallo scienziato, ricco di
tecnicismi, formule matematiche, formule chimiche, equazioni, al punto che alla
fine risulta difficile o peggio impossibile comprendere chi non ha fatto di quella
scienza la sua professione. Rende bene l’idea Carlo Bernardini, quando afferma che
se c’è “un problema di incomunicabilità, questo è dovuto soprattutto ai linguaggi,
che diventano divergenti, là dove il linguaggio scientifico si prende la sua autonomia
e lascia in soffitta il linguaggio di tutti i giorni”. Gli scienziati hanno in questo una
forte responsabilità: devono imparare a comunicare le loro scoperte, la loro scienza,
ognuno deve farsi comprendere. “L’incomprensibilità deliberata è una perversione,
una forma di ostilità gratuita verso i propri simili”
3
.
È necessario formare figure professionali che siano abili comunicatori scientifici, che
abbiano una solida e rigorosa preparazione scientifica accompagnata dalla capacità
di divulgare correttamente ed in modo “banalmente” comprensibile l’informazio-
ne
4
, l’essenza della scienza. Purtroppo, i mezzi d’informazione di massa spesso pro-
muovono notizie, o peggio ancora intere trasmissioni in cui si fa pseudoscienza; “La
denutrizione scientifica... la corriva tolleranza umanista verso l’irrazionale… questo
pensiero che bada solo a essere erudito ed elegante e non si preoccupa minimamente
del rigore semantico, può avere enormi responsabilità nella formazione dell’uomo
contemporaneo (Bernardini, De Mauro Contare e raccontare).
La divulgazione e l’insegnamento delle scienze sono fondamentali per poter costru-
ire un sapere scientifico consapevole all’interno della società
5
, al fine di formare
cittadini con una adeguata istruzione scientifica, non necessariamente professionale,
ma tale da consentire la partecipazione critica ai dibattiti pubblici su come applicare
i risultati della ricerca scientifica.
Diversi scienziati, prevalentemente fisici, sia italiani che stranieri, si sono prodigati
nella scrittura di diverse opere divulgative e sono riusciti, in modo molto efficiente, a
comunicare e promuovere le loro discipline
6
. Possiamo citare, tra gli altri, Tullio Reg-
3
Bernardini, De Mauro,
Contare e raccontare
.
4
Si potrebbe citare questo episodio ad una lezione di farmacologia. Il docente, alla domanda
di uno studente di chiarire la differenza tra farmaco e veleno, rispose: anche le paste alla crema,
oltre il 25° kg, possono essere letali. Concetto “banalmente” comprensibile anche ai bambini
per illustrare il legame dose-effetto.
5
Marteen Rees,
Da qui all’infinito. Una riflessione sul futuro della scienza
.
6
Alcune opere che l’autore ritiene particolarmente significative:
Breve storia dell’atomo
,
Come si
sbriciola un biscotto
,
Elementi
,
L’atomo diviso
.
















