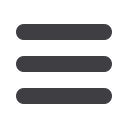
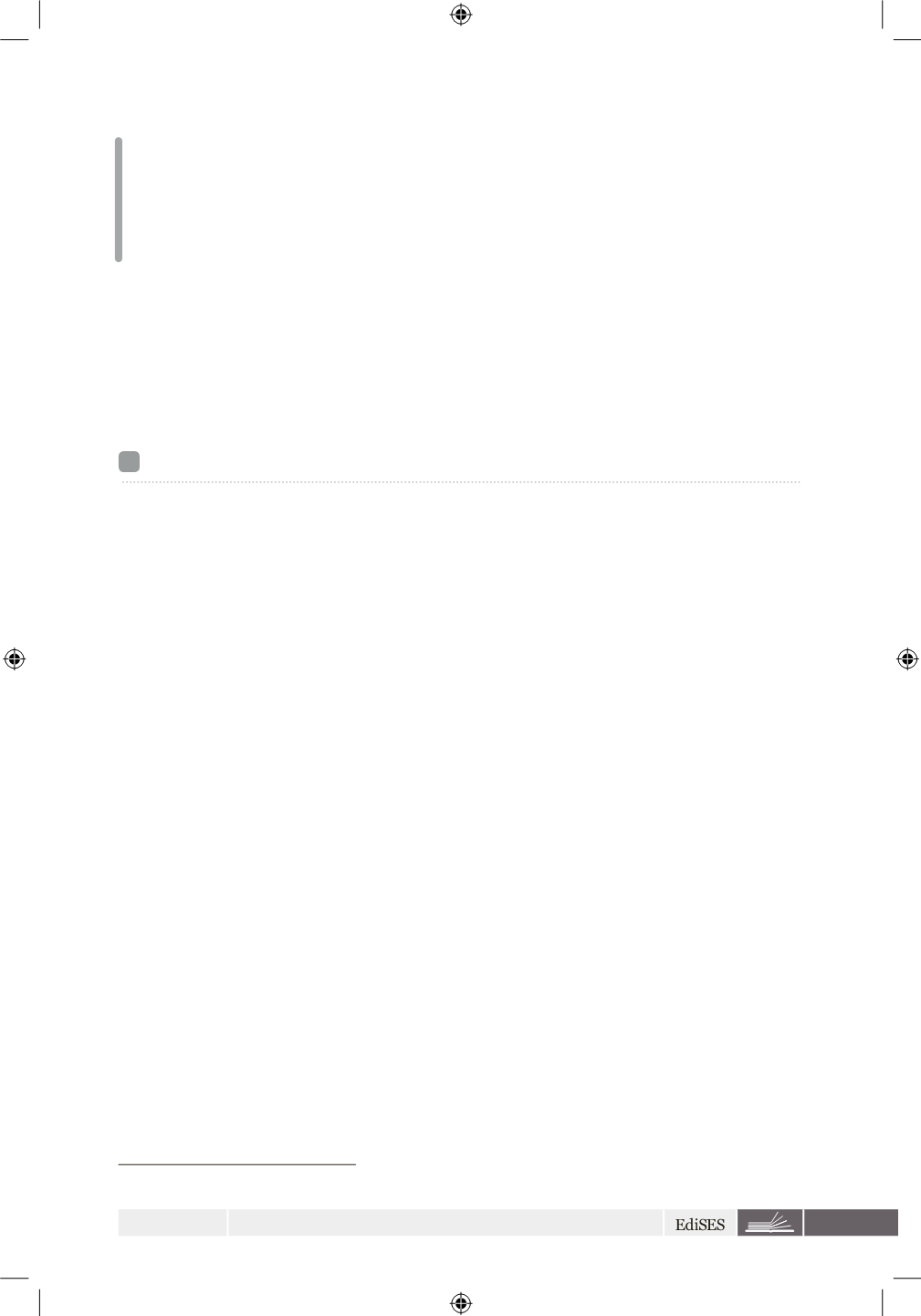
www.
edises
.it
CAPITOLO
1
Scienza, chimica e società
Considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver come bruti, /
ma per seguir virtute e canoscenza
[Dante,
Inferno
, c. XXVI, vv. 118-120]
1.1
•
Scienza e società
“È nella natura umana pensare in modo saggio e agire stupidamente.”
(Anatole France).
Nella società attuale, sempre più basata sul sapere scientifico, la cui pratica applica-
zione si manifesta tramite tecnologie più o meno complesse e sofisticate che di fatto
determinano il vero progresso del mondo intero, è tuttora presente l’errata convin-
zione che le materie umanistiche siano formative, al contrario di quelle scientifiche,
considerate aride, informative, estremamente specializzate. Oggi, nel comune sen-
tire, i termini “filosofia/filosofo” e “scienza/scienziato” sono identificati come “ma-
terie/professioni” del tutto antitetiche, se non addirittura tra loro incompatibili. Il
termine greco “filosofia” significa letteralmente “amore per la sapienza” e si riferisce
ad “un campo di studi che si pone domande e riflette sul mondo e sull’uomo, indaga
sul senso dell’essere e dell’esistenza umana, tenta di definire la natura e analizza
le possibilità ed i limiti della conoscenza”. È quindi evidente che filosofia e scienza
(sapienza) sono intimamente interconnesse e non antiteticamente contrapposte. Già
Anassimandro di Mileto, filosofo greco del 600 a.C. che ricercava le origini del mon-
do e ne definì gli elementi fondamentali (aria, acqua, terra, fuoco, a loro volta origi-
nati da un elemento indefinito denominato
apeiron
), passò dalla teoria alla pratica:
pare infatti che sia stato il primo cartografo, “inventando” così una nuova scienza
(“sapienza”). In questo contesto, anche la celebre terzina dantesca citata in epigrafe
può apparire emblematicamente significativa.
L’immagine dello scienziato è molto spesso riferita ad una figura maschile
1
, povera
di spirito, fredda, poco o per nulla emozionabile e con scarso senso artistico. Anche
questo stereotipo, tuttavia, non corrisponde alla realtà, come ben evidenzia Ernesto
Ferrero nell’introduzione de
I racconti
di Primo Levi:
Solo chi dispone di strumenti concettuali e conoscitivi che siano al tempo stesso com-
plessi, sofisticati e duttili può tentare la vera creatività. Non credo di conoscere persone
più creative dei fisici, dei biologi e dei matematici: il vero “romanzo”, la vera avventura di
conoscenza e di scoperta è quella che loro corrono, anche se il linguaggio che usano è
1
Sex and the citadel of science
, Michelle Francl,
Nature Chemistry
, 2011, 3, 670.
















