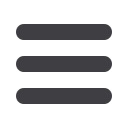

10
Parte Prima - L’insegnamento di Lingua e cultura latina
sostenibile” (capace cioè «di garantire il soddisfacimento dei bisogni attuali
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di far fronte ai loro
bisogni») debba vertere esclusivamente sull’utile dell’
oggi
senza immaginare
prospettive diverse per il
domani
? Non è forse proprio questo uno dei mali at-
tuali più radicati, una sorta di dittatura del presente, che, concentrando tutta
l’attenzione sull’
hic et nunc
, finisce per rendere impossibile il confronto con
il passato e la costruzione del futuro? Su questo punto è forse necessario ag-
giungere alcune riflessioni. È evidente che lo studio del latino (e del mondo
antico) ha a che fare con la costruzione della nostra identità; il punto, però, è
come si vuole intendere la nostra identità e quella dei nostri avi se in maniera
rigidamente compatta, come una sorta di bagaglio, di “cassetta degli attrezzi”
(più o meno ingombrante, più o meno funzionale) di cui servirsi all’occor-
renza, oppure se in maniera dinamica, fluida, mutevole, come qualcosa che si
costruisce col tempo anche sulla base di un confronto/scontro con il passato.
L’identità culturale, allora, non potrà esserci senza una precisa e consapevole
azione di selezione del passato, senza un’acquisizione voluta e responsabile di
aspetti dell’eredità antica. Ciò significa che non esiste il
Classico
come valore
perenne e immutabile, sempre uguale a se stesso con cui il presente (even-
tualmente) si metta in contatto per farlo tornare in vita (quasi che il richiamo
al passato costituisca una sorta di grande seduta spiritica collettiva); esistono,
invece, tanti
Classici
quante sono le epoche della storia che hanno costruito la
propria identità anche colloquiando/scontrandosi con l’antico. Risulta chiaro,
perciò, che richiamarsi al mondo antico non comporta un atteggiamento di
passività, ma al contrario necessiti una sfida creativa da parte di chi si confronta
col passato selezionandone gli aspetti che più gli sono congeniali; sfida creativa
che ha come fine quello di definire meglio la propria identità.
Rimane una domanda: ammesso pure che questo atteggiamento agonistico
sia quello giusto nel rapporto passato/presente, è davvero necessaria un’ope-
razione simile oggi in un’epoca segnata dalla globalizzazione? A tal propo-
sito appaiono particolarmente significative le parole di Gian Biagio Conte:
«Nella fase di globalizzazione, quale è quella verso cui siamo inevitabilmente
sospinti, ricercare l’identità è opportuno; anzi è necessario, altrimenti questa
si perde; ma perderla significherebbe un indebolimento dei rapporti con le
altre culture. Non avremo niente da portare agli altri … Nel panorama della
mondializzazione e del multiculturalismo, termini di cui si fa tanto abuso, esi-
ste una sorta di strabismo da evitare. Con un occhio si guarda a una cultura
planetaria che risulterebbe, alla maniera dell’esperanto dalla convergenza e
fusione delle varie culture; con l’altro si percepisce che le culture politicamen-
te ed economicamente più deboli si chiudono a riccio su se stesse applicando
il cosiddetto fondamentalismo (e si sa che i fondamentalismi sono soprattutto
paura di uno sradicamento). Raddrizzare gli occhi, guardando avanti, signifi-
ca essere consapevoli che i processi storici possono condurre al di là di una
vero volano della ripresa economica, il “petrolio” dimenticato dell’Italia. Il rapporto è con-
sultabile al sito
www.symbola.netnella sezione documenti.


















