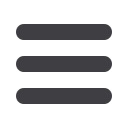

8
Parte Prima - L’insegnamento di Lingua e cultura latina
deve costituire un mezzo non il fine dell’insegnamento. Su questo punto critici
e difensori del latino sembrano trovare numerosi punti di contatto
6
.
Altre critiche contenute nel documento meritano poi attenzione. In primo luo-
go, i detrattori del latino attaccano l’eccessivo numero di studenti che (con
scarsi risultati) si dedicano allo studio di questa materia. In effetti, fatte salve
le riduzioni apportate dalla riforma Gelmini, l’eccezionalità della condizione
italiana rispetto agli altri paesi occidentali si spiega facilmente se si tiene conto
che più di ogni altra nazione l’Italia vanta un patrimonio storico-archeologico
considerevole del quale il latino è parte integrante. La disparità nel confronto
con gli altri sistemi scolastici, a nostro parere, ha una ragione d’essere anche
sotto questo profilo. Riguardo, poi, al problema dell’obbligatorietà del latino
si dimentica che il liceo è una delle scelte possibili per lo studente che ha su-
perato l’esame della scuola media inferiore. Nei fatti, dunque, l’obbligatorietà
non esiste visto che gli indirizzi tecnici consentono comunque l’accesso alla for-
mazione universitaria. Se il problema, allora, è l’eccessivo numero di studenti
“indebitati”, è facile rispondere che la stessa percentuale riguarda la matema-
tica: chi si azzarderebbe a chiedere per questo l’opzionalità della matematica?
È stato opportunamente rilevato che nell’intervenire sul sistema scolastico oc-
corre molta prudenza in quanto si finisce per incidere più o meno profonda-
mente sul futuro: stabilire oggi cosa i giovani debbano apprendere a scuola
condiziona inevitabilmente il loro avvenire e quello dell’intero paese. Prima,
dunque, di eliminare una disciplina come il latino, che ha comunque avuto il
suo peso nel curriculum scolastico, bisognerebbe chiedersi con che cosa sosti-
tuirla e a quale scopo. È di primaria importanza evitare da un lato cambiamenti
che si risolvano in un impoverimento e dall’altro “salvare” quanto di sbagliato
c’è nella tradizione.
A ben guardare, la vera obiezione che viene mossa riguarda la
scarsa “attualità”
del latino
, la sua non “spendibilità” nell’immediato. In definitiva, sembra pro-
prio che la critica al latino, e più in generale agli studi classici, maggiormente
condivisa discenda da una
prospettiva economicistica
per la quale si è portati
a chiedersi: “A che mi
serve
il latino
oggi
?”. In questa prospettiva si innesta la
dicotomia cultura umanistica/cultura scientifica: la richiesta di ridimensionare
la presenza del latino nella scuola − e in generale della cultura classica − rap-
6
Si veda ad esempio quanto afferma anche Maurizio Bettini nel documento di TreeLLLe: «Lo
studio del latino nella sola prospettiva di apprenderne la lingua non mi pare attuale; allo stesso
modo, penso anche che uno studio puntiglioso della storia letteraria di Roma antica – le tragedie
perdute di Ennio, la data di composizione delle orazioni di Cicerone, le bucoliche di Nemesiano
– suoni decisamente fuori tono nella scuola di oggi. Quello che occorrerebbe far conoscere ai
giovani è piuttosto la cultura antica nel suo complesso, non solo nelle sue forme codificate. Lo
studio della lingua e della letteratura latina potrebbe dunque essere inglobato all’interno di un
progetto formativo più vasto, che comprenda anche questi aspetti della elaborazione culturale
antica, ma non solo questi: lingua e letteratura assieme ai modi di vita degli antichi, alla loro
storia, alle istituzioni che si sono dati nel corso del tempo, ai loro costumi, ai grandi modelli di
pensiero che hanno elaborato» (p. 77).


















