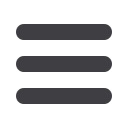

Capitolo 1 -Il latino nella scuola italiana
9
presenta un’inevitabile conseguenza dell’assoluta superiorità che nella società
attuale è attribuita alla cultura scientifica, considerata come maggiormente le-
gata ad una finalità pratica.
A questo punto è legittimo domandarsi se nella scuola tale dicotomia sia reale
o se invece, come vuole Giuseppe Cambiano, la vera contrapposizione debba
essere fatta tra saperi facili (cioè saperi di superficie, semplici da apprende-
re, ma incapaci di promuovere una vera crescita del giovane) e saperi difficili
(maggiormente dispendiosi sia per i discenti che per la struttura scolastica, ma,
proprio per questo, costituiscono un concreto stimolo al conseguimento dello
spirito critico
7
). Come non essere d’accordo con Piergiorgio Odifreddi quando
dichiara: «L’obiettivo della Cultura dovrebbe allora essere non la contrapposi-
zione delle culture, ma la loro unificazione in un sapere più vasto che inglobi
in sé matematica, scienza, letteratura e arte di ogni contesto geografico e stori-
co»? In quest’ottica non può che apparire avvilente ogni intervento che in sede
di impostazione didattica si riduca a un taglio netto di materie (“Togliamo il
latino e sostituiamolo con l’inglese, la matematica, l’informatica ecc.”).
Riguardo poi all’
inattualità
del latino − e degli studi classici − in quanto discipli-
na inutile, cioè incapace di offrire prospettive concrete nel famigerato mercato
del lavoro, conviene anche in questo caso assumere una visuale più generale.
A tal proposito, c’è chi ha invitato a distinguere tra «utilità immediata» e «uti-
lità differita»
8
dal momento che in una realtà come quella odierna, sottoposta
a continui e radicali rivolgimenti, non è detto che ciò che oggi appare im-
portante continui ad esserlo anche domani (e viceversa)
9
. E, per venire più
specificamente al mondo della scuola: siamo davvero sicuri che una “didattica
7
Così lo studioso del pensiero antico nel suo articolo
Sapere umanistico/sapere scientifico: uno
pseudo conflitto?
si esprime: «Entrambe le forme di sapere [
sc.
sapere umanistico e sapere
scientifico] contribuiscono, ciascuna nelle sue modalità, alla costruzione, al tentativo di ride-
stare – usiamo un’espressione un po’ retorica – il cosiddetto “spirito critico”. Spirito critico
in che senso? Io lo intendo in questo modo, cioè di far sì che le menti non siano comple-
tamente schiave di ciò che è ovvio, non accettino cioè opinioni come delle ovvietà o delle
verità naturali. Io credo che su questo obbiettivo non ci sia alcun contrasto tra cultura uma-
nistica e cultura scientifica».
8
Il concetto di «didattica sostenibile» e la distinzione tra «utilità immediata» e “utilità differi-
ta” sono in D. Puliga,
Percorsi della cultura latina. Per una didattica sostenibile
, Carocci, Roma, 2008.
9
Nei primi mesi del 2012 il supplemento domenicale de
Il Sole 24 Ore
ha lanciato una ve-
emente campagna a difesa della Cultura come fattore di crescita economica: investire in
cultura in Italia, dicono i dati forniti dai promotori, potrebbe rimettere in moto l’economia.
Il titolo del manifesto significativamente sintetizza: «Niente cultura, niente sviluppo» (19
febbraio 2012). Da ultimo, si può citare la ricerca
L’Italia che verrà: Rapporto 2012 sull’industria
culturale in Italia
presentata a Treia (Macerata) a cura della Fondazione Symbola e di Union-
camere con il patrocinio della Regione Marche secondo cui il comparto “cultura” pesa sul
PIL nazionale per il 5,4%; si tratta, cioè, di un comparto che produce quasi 76 miliardi di
euro assorbendo il 5,6% degli occupati in Italia (in cifre un milione e 400 mila persone).
Visto che aggiungendo anche l’indotto si arriva al 15% del Prodotto Interno Lordo con ben
il 18,1% degli occupati, il settore cultura – stando ai dati della ricerca – si conferma come il


















