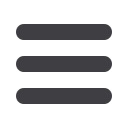
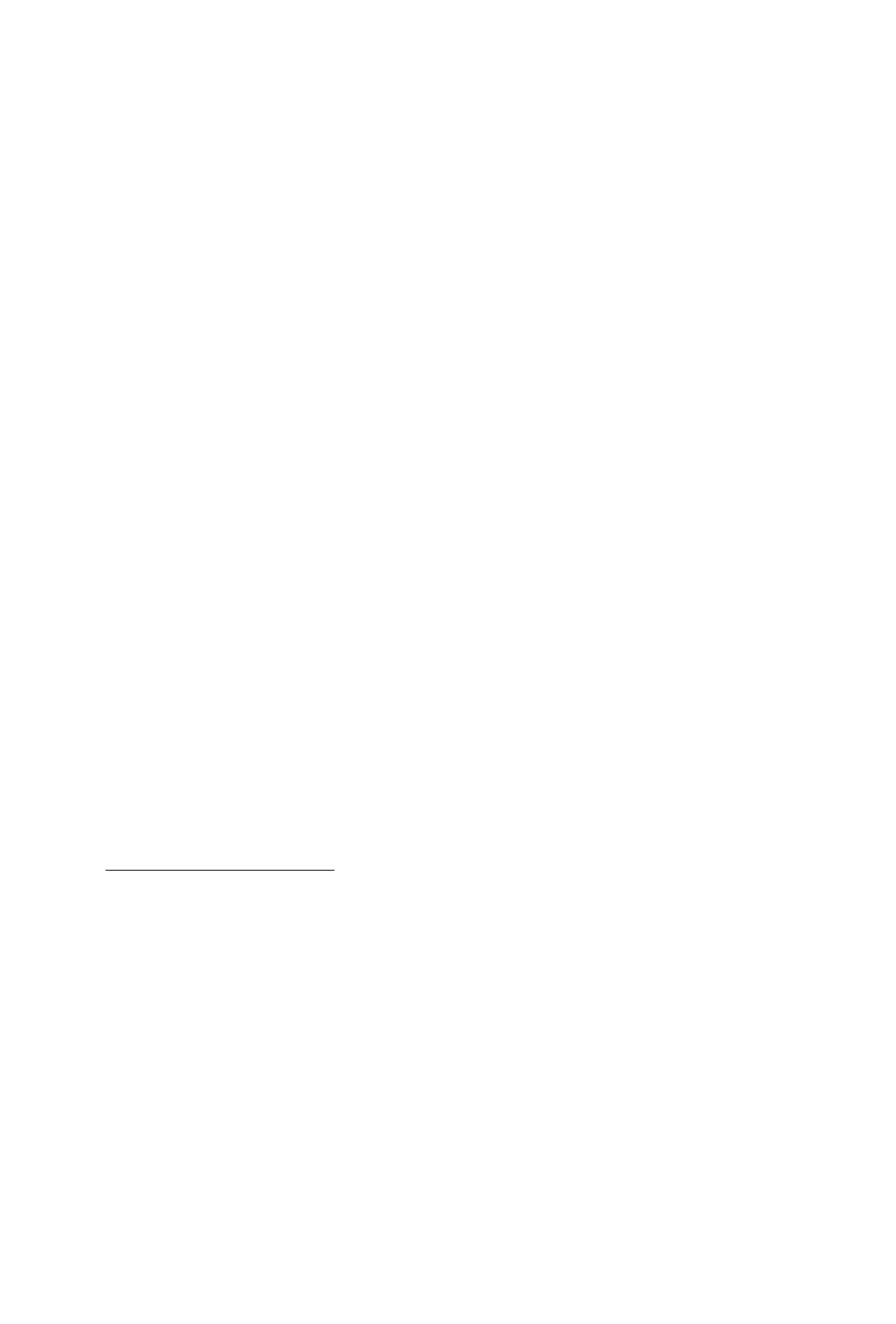
Capitolo 1 -Il latino nella scuola italiana
7
classista
”
4
− quella cioè di alzare un muro divisorio tra la classe dirigente lati-
nista e la classe subalterna non latinista − certamente non in linea con l’ideale
tanto decantato di umanesimo o con la funzione di unificazione culturale. È
chiaro, però, che chi si fa oggi difensore di tale disciplina è ben lontano dal
voler riproporre gli errori del passato. D’altro canto, Rosario Drago nota come,
in barba al principio dell’obbligatorietà degli studi classici nell’indirizzo licea-
le, sussista nella realtà una “opzionalità clandestina”: molti studenti subiscono
il cosiddetto “debito formativo” proprio nelle discipline classiche, cioè vedono
sospeso il loro giudizio finale in attesa di una verifica prima dell’inizio del nuo-
vo anno scolastico. In realtà solo per una percentuale irrisoria di studenti il
debito formativo comporterà la bocciatura o il completo recupero; l’alunno si
trascinerà sino all’esame finale con le sue difficoltà in latino (e/o in greco) sen-
za aver mai affrontato davvero il problema. Si tratta, dunque, di un’opzionalità
di fatto poiché nel frattempo lo studente avrà scongiurato il rischio di non esse-
re promosso indirizzando i propri sforzi verso altre discipline. Chiunque abbia
un minimo di pratica scolastica sa bene che questa situazione è tutt’altro che
rara. Ma tutto questo non si verifica forse anche per altre materie? È corretto
risolvere tale apatia dei discenti semplicemente stabilendo l’opzionalità? Non
spetta, invece, alla classe docente mettere in campo tutto il proprio impegno,
la propria inventiva e la propria professionalità per evitare un tale fenomeno di
dispersione (in latino così come in ogni altra materia)?
In altri termini, è doveroso stabilire se siamo di fronte ad un problema di di-
sciplina o di
metodologia didattica da cambiare
. Non v’è dubbio, infatti, che
abbiano ragione coloro che criticano l’approccio didattico dominante fino a
qualche anno fa che identificava lo studio del mondo antico con lo studio del-
la lingua (latina o greca)
5
; con il suo bagaglio di nozioni morfosintattiche, la
lingua, pur rimanendo importante per dare dignità scientifica alla disciplina,
la diversa distribuzione di licei sul territorio: nessuno mette in dubbio che tale divario esista
ma crediamo che la questione meriti un approfondimento maggiore piuttosto che la sempli-
ce constatazione di una differenza di percentuale.
4
L’espressione è di Luigi Berlinguer nel suo contributo alla ricerca
Latino, perché? Latino per chi?
5
Inoppugnabili in questo senso le parole di Berlinguer nel saggio sopra citato: «Va rivisto il
rapporto fra lingua, cultura, arte, società, costumi, per favorire una conoscenza equilibrata
dei segni distintivi di quel mondo, un approccio certamente molto più affascinate ed attraen-
te, quindi più efficace ed insieme più corretto storicamente, rispetto al metodo attuale» (p.
54); l’impostazione didattica tradizionale «avendo contratto o escluso emozioni e curiosità
ha impedito la sinergia – nell’apprendere – fra intelligenza razionale e intelligenza intuitiva,
emozionale, curiosità, meraviglia, senso dell’utile e del tangibile; la capacità di ragionare sui
fatti, di trasformare conoscenze in competenze, in sapere pregnante, di volgerlo in diretta
interpretazione del reale, di abituarsi alla severa spietatezza della verifica fattuale: tutto ciò
che fa la ricchezza dell’intelligenza umana, della creatività giovanile, della fisiologia dell’ap-
prendimento» (p. 51).


















