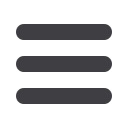

1
Capitolo
Il latino nella scuola italiana
In questo capitolo esamineremo la presenza del latino nel contesto scolastico
italiano alla luce delle trasformazioni che la riforma Gelmini ha imposto in
termini di monte-ore, obiettivi, finalità.
1.1
Perché studiare/insegnare il latino?
L’attività didattica negli ultimi decenni ha conosciuto profonde trasformazio-
ni che trovano spiegazione nei cambiamenti significativi che si sono registrati
nell’ambito delle strutture sociali, dei modelli gnoseologici e della comunica-
zione. L’obbligatorietà della frequenza scolastica ha determinato la formazio-
ne di una “scuola di massa”, il che ha comportato la necessità di assicurare a
un’utenza più vasta una
pluralità di curricula
formativi
. Ancora più significati-
ve le conseguenze derivate dalla cosiddetta “rivoluzione copernicana” che si è
avuta in ambito gnoseologico: all’idea che la conoscenza passi da una posizione
“forte” ricoperta dal docente a una “debole” propria del discente, si è sostituito
un modello di apprendimento “costruttivista” in base al quale docente e di-
scente concorrono entrambi all’elaborazione del sapere, per cui la falsa conce-
zione del professore “sole” intorno al quale deve ruotare lo studente “satellite”
si è drasticamente ridimensionata.
Lo sviluppo, inoltre, di nuove forme di comunicazione di massa sempre più
potenti e sempre più pervasive (televisione, internet, social network) ha sot-
tratto alla scuola l’esclusività del ruolo di soggetto formatore per le nuove ge-
nerazioni: essa, pertanto, oggi è solo
uno
degli attori che opera nella creazione
e trasmissione del sapere (e probabilmente neanche il più attrattivo). A tutto
questo si aggiunga la crisi ormai acclarata della struttura familiare tradizionale
che rende più vulnerabile il giovane studente e si riverbera inevitabilmente
sull’istituzione scolastica: in mancanza di una guida genitoriale autorevole e
forte si chiede spesso alla scuola di supplire a tale funzione nell’imporre ai
giovani modelli di comportamento corretti. Appare chiaro, allora, come la fun-
zione dell’insegnante sia stata investita di maggiori responsabilità; situazione
alla quale, però, ha fatto seguito paradossalmente un ridimensionamento del
suo prestigio sociale che, peraltro, il docente condivide con la figura dell’intel-
lettuale, trasformatasi negli ultimi anni da “legislatore” ad “interprete”: da un
ruolo attivo nella formazione del senso (ruolo che la comunità formalmente gli
attribuiva e gli riconosceva) si è passati a una più modesta funzione “esegetica”
consistente nel contribuire al processo di comprensione di regole, modelli di


















