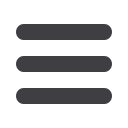

www.
edises
.it
888
Libro X
Reati contro la Pubblica Amministrazione
Tuttavia, sia in dottrina che in giurisprudenza, si osserva che la quali ca di soggetto
attivo competa altresì al “possessore” e al “detentore”, dato che una interpretazione
riduttiva del termine “proprietario” escluderebbe dalla tutela penale una serie di
beni pubblici che, in quanto
res communes omnium
, non possono de nirsi strettamente
“propri” di determinate persone siche preposte alla loro effettiva salvaguardia.
La
condotta
incriminata consiste nel
distruggere
,
deteriorare
o
comunque danneggiare
un
monumento o altra cosa propria di rilevante pregio, purché ciò determini un
nocu-
mento al patrimonio archeologico, storico od artistico dello Stato.
La punibilità del fatto è dunque subordinata al veri carsi della
condizione oggettiva
(art. 44 c.p.) del citato
nocumento al patr
i
monio archeologico, storico o artistico nazionale
come conseguenza della condotta.
Ai ni dell’imputabilità della contravvenzione è necessaria quella
volontarietà del
fatto
, sia essa dolosa o colposa, che, di regola, è suf ciente per l’imputabilità do ogni
altra contravvenzione.
Il soggetto attivo, pertanto, deve aver avuto, anzitutto volontà cosciente e non coar-
tata di compiere l’azione o l’omissione che ha cagionato la distruzione, il deteriora-
mento o il danneggiamento (con o senza l’intenzione di distruggere, deteriorare o
danneggiare). È inoltre necessario, come espressamente esige l’art. 733 c.p., che sia
stato consapevole del rilevante pregio archeologico, storico od artistico della cosa.
4.3.4
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito
protetto (art. 733-
bis
c.p.)
Il D.Lgs. 121/2011, attuativo della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’am-
biente, varata dal legislatore europeo per rafforzare la disciplina di contrasto contro
i fenomeni di aggressione all’ambiente considerato nel suo complesso, ha fra l’altro,
inserito tra le contravvenzioni del titolo II del Libro III del codice penale la fattispe-
cie di
distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto
, corret-
tamente collocandola all’art. 733-
bis
,
subito dopo la previsione del danneggiamento
al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.
Ai sensi della norma citata,
chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’in-
terno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione,
punito con l’arresto no a 18 mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro
.
Oggetto di tutela
della norma è l’
interesse dello Stato al mantenimento dello stato
di conservazione di un habitat naturale
, interesse tanto più pregnante in virtù della
progressiva importanza che nel tempo ha assunto, nella considerazione della colletti-
vità nazionale ed internazionale, il bene “ambiente”, e quindi la necessità di una sua
preservazione da condotte offensive.
Quanto al
soggetto attivo
, l’art. 633-
bis
c.p. con gura un
reato comune
, essendo in-
dividuato il soggetto agente in “chiunque” pone in essere una delle condotte tipiche
individuate dalla fattispecie incriminatrice e cioè la
distruzione
dell’habitat e il
deterio-
ramento
dell’habitat,
compromettendone lo stato di conservazione
.
Le condotte alternative di distruzione e di deterioramento assumono rilevanza pena-
le soltanto se spese
all’interno di un sito protetto
, ossia in una zona od area di particolare
pregio ambientale. Si tratta di condotte a
forma libera
, poiché sono inin
uenti le mo-
dalità attraverso le quali si determina la distruzione od il deterioramento.
















