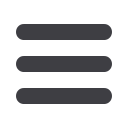
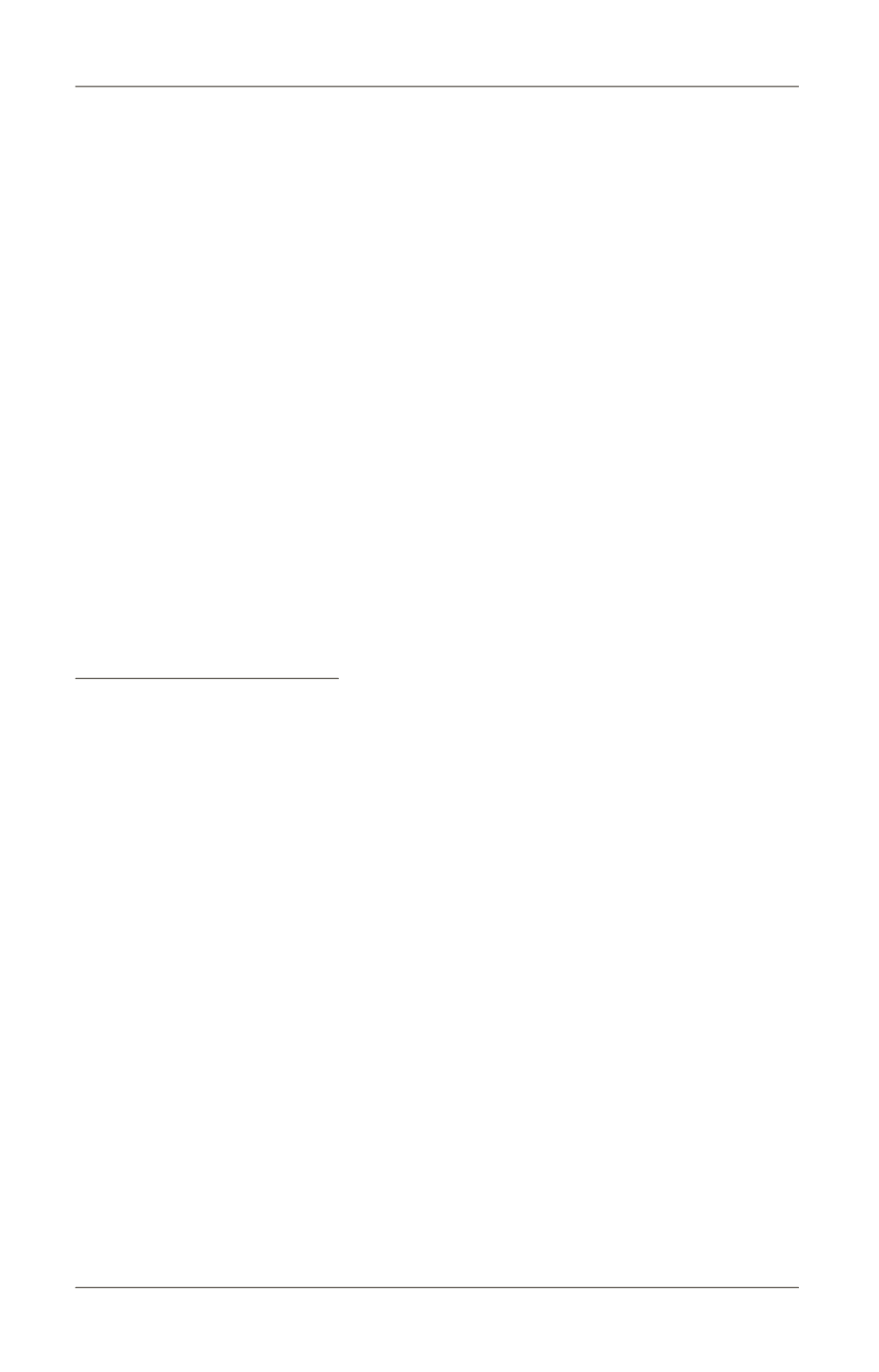
Lo sviluppo professionale dei docenti
20
Che cosa vogliono dire, così, “includere” e il suo contrario “escludere”?
1
Una concezione sociale e politica dell’inclusione non può che prevedere,
innanzitutto, un’organizzazione e una gestione democratiche di tutte e di
ciascuna istituzione, ai vari livelli politici e sociali: includere vuol dire non
escludere, non separare, non isolare, non decentrare, ma al contrario, raf-
forza i significati e le pratiche per inserire, avvicinare, chiamare in causa,
fare partecipe; significa non allontanare, ma avvicinare, chiamare a rendere
conto, a portare il proprio contributo, a seconda delle proprie possibilità
e capacità, di idee, di conoscenze e di competenze; significa favorire il dia-
logo e la partecipazione tra le parti, o meglio tra le persone, in famiglia e a
scuola, così come significa, ancora, sviluppare la compartecipazione dei vari
soggetti coinvolti nelle scelte comuni, al di là delle diverse visioni della vita
e della cultura, quelle stesse che aiutano a migliorare la vita quotidiana e ad
incrementare il significato di una esistenza costellata da processi di ricerca
continua di apertura verso gli altri, quindi di empatia e di “com-passione”
2
.
Ne consegue che la scuola e, in particolare, una scuola che accoglie, condi-
vide, sorregge e intende risolvere, tra gli altri, i problemi dei “diversi”, possa
fare riferimento ai molteplici aspetti della questione, sia di natura conosciti-
va che organizzativa e gestionale
3
.
1
Il verbo “includere”, a nostro parere, può essere letto secondo due linee di significato
che possono, tra loro, sia convergere che divergere. Un
primo significato
, infatti, ci rimanda
all’azione di un soggetto (o di più soggetti) che “includono” ossia “chiudono dentro”; un
secondo significato
, invece, è sinonimo di “comprendere”, ossia di contenere. Ebbene, se
noi ci fermassimo al primo significato, in termini pedagogici, sceglieremmo un model-
lo educativo chiuso, di tipo unidirezionale, trasmissivo, direttivo, nel senso che c’è chi
“chiude dentro”, da una parte, cioè opera la scelta, ha il potere di farlo e chi, dall’altra, la
subisce. Il problema che si pone, in proposito, è: il “rinchiuso” (si potrebbe dire il recluso)
quando e come si emancipa? Quando trova la possibilità di uscire dal recinto? Metafori-
camente, come e quando potrà pensare con la propria testa?
Il secondo significato
, invece, è
più vicino alla nostra scelta pedagogica perché l’inclusione si presenta qui come modello
metaforicamente aperto; includere, in questo caso, è sinonimo di comprensione (capire
insieme, interagire, dialogare, fare scelte comuni, lavorare e cooperare per il “bene co-
mune”). Ebbene, secondo noi, è effettivamente in grado di comprendere solo colui che
non stabilisce chiusure; chi non costruisce classificazioni; chi non avanza motivazioni o
elenca pregiudiziali che allontanino anziché avvicinare. Uno dei compiti di fondo di un
educatore, tra gli altri, è quello di porre attenzione all’uso delle parole, alla loro “discrimi-
nazione positiva” perché funzionino ed acquisiscano senso pieno e profondo all’interno
del contesto (Musello, Sarracino, 2017).
2
L’empatia e la compassione sono sinonimi, in molte situazioni. Nel nostro caso li usia-
mo come tali con il significato di “sentimento di partecipazione verso l’altro”, come il
tentativo di mettersi dalla parte dell’altro o, ancora, delle ragioni dell’altro.
3
La scuola, come risulta dal profilo che emerge dai decreti delegati del 1974 e dalle nor-
me successive, frutto del dibattito degli anni Settanta, è un luogo (o dovrebbe esserlo) di
















