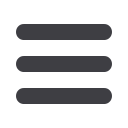
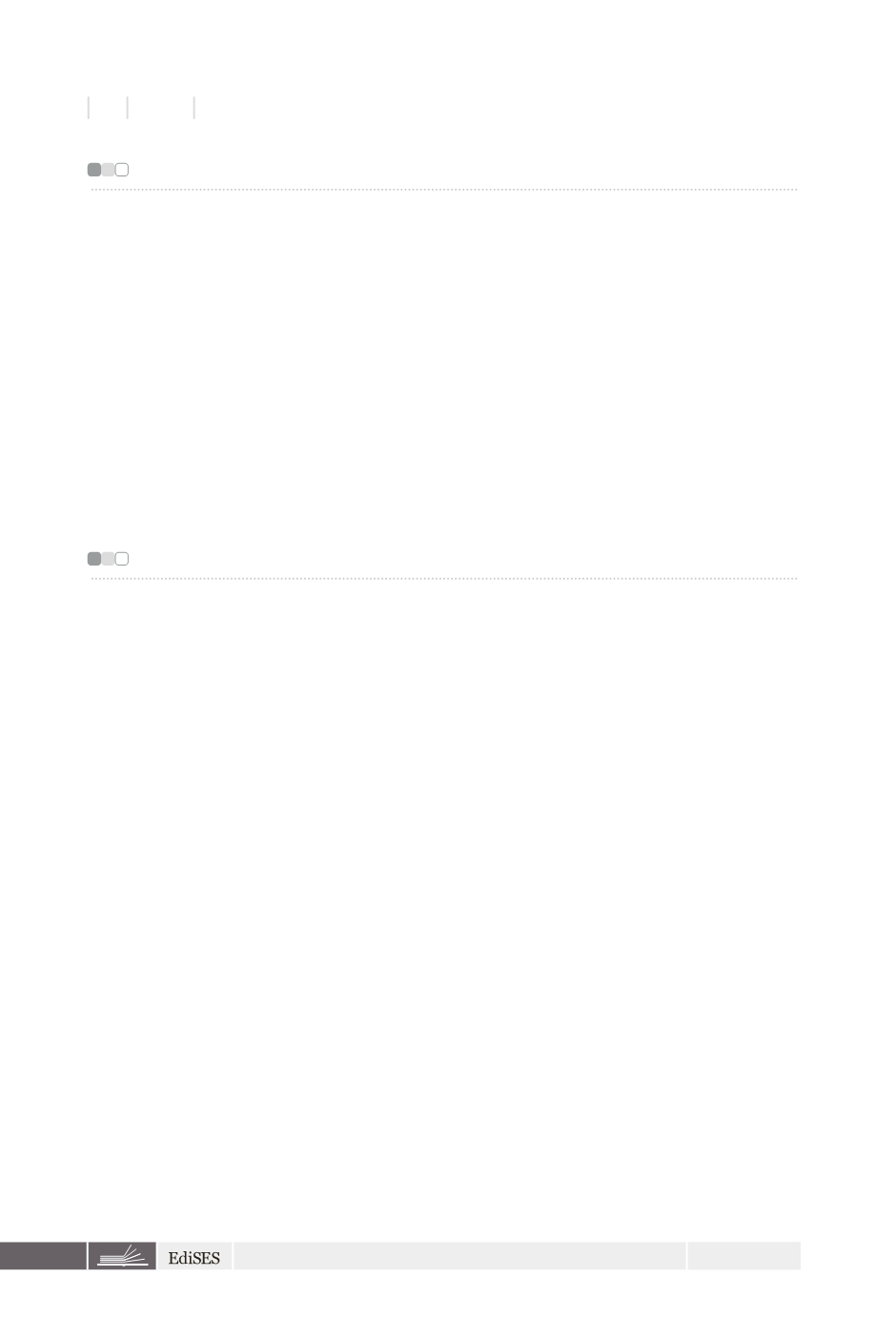
168
STUDIO
Cultura generale
www.
edises
.it
Le opere minori
La prima esperienza poetica di Dante fu legata al “dolce stil novo”. Le “
Rime
” gio-
vanili e la “
Vita nova
” furono scritte infatti in volgare !orentino e secondo i canoni
dello stilnovismo.
La “
Vita nova
”, scritta tra il 1292 e il 1293, è la storia dell’amore spirituale di Dante
per Beatrice.
Il “
De vulgari eloquentia”
è un trattato in latino, lasciato interrotto, che esalta l’im-
portanza del volgare. Il testo è in latino proprio perché Dante intendeva rivolgersi
agli intellettuali, indipendentemente dalla loro provenienza geogra!ca, per invitarli
a scrivere in volgare. L’argomento dell’opera è la
questione della lingua.
Il “
De Monarchia
” è un trattato in latino in cui sono esposte le idee politiche di Dan-
te. L’autore vi sostiene la funzione universale, di pari dignità e di reciproca autono-
mia dei due grandi istituti medievali: l’Impero, guida politica, terrena dei cristiani;
la Chiesa, guida spirituale.
La Divina Commedia
È il capolavoro dantesco, scritto durante gli anni dell’esilio e !no alla morte. La “
Com-
media
” a cui l’aggettivo “divina” fu aggiunto dal Boccaccio, è divisa in tre cantiche:
“
Inferno
”, “
Purgatorio
” e “
Paradiso
”, ciascuna formata da 33 canti, più un canto in-
troduttivo per l’ “Inferno”, per complessivi
cento canti
. Questi sono tutti in terzine di
endecasillabi a rima alternata (o in
terza rima
). Dante immagina un viaggio compiu-
to nell’aldilà, guidato da
Virgilio
, il maggiore poeta latino e simbolo della ragione,
nell’Inferno e nel Purgatorio, e da
Beatrice
, che simboleggia la teologia o scienza divi-
na, nel Paradiso. La visione è collocata nella settimana santa del 1300. Il poeta immagi-
na di essersi smarrito in una selva oscura, evidente allegoria della perdizione nel pecca-
to, e di essere rimasto atterrito dalla vista di tre !ere: un
leone
, simbolo della
superbia
;
una
lince
, simbolo della
lussuria
; e, peggiore di tutte, una
lupa
, simbolo dell’
avidità
.
A guidare fuori della selva il poeta, interviene Virgilio che, per ricondurre Dante alla
virtù e alla salvezza, deve accompagnarlo attraverso i tre regni dell’oltretomba.
Inferno
.
Il regno della dannazione è immaginato come un’enorme voragine a forma
d’imbuto che, apertasi al di sotto di Gerusalemme per il ritiro della terra quando Lu-
cifero e gli angeli ribelli vi furono fatti precipitare da Dio, si restringe gradualmente
!no al centro della Terra, dove è rimasto con!ccato lo stesso Lucifero.
Prima dell’inferno propriamente detto c’è l’
antinferno,
dove sono collocati gli ignavi,
quelli che in vita non hanno fatto né bene né male, tanto da essere ri!utati dai cieli
e dallo stesso inferno. L’inferno è diviso in
nove cerchi
: più è stata grave la colpa,
più giù sono posti i dannati, in quanto la pena è in rapporto con il peccato secondo
la
legge del contrappasso
. Il
primo cerchio
è il
limbo
, dove sono raccolti coloro che
non hanno avuto altra colpa che quella di non essere stati battezzati. Vi si trovano
anche molti grandi personaggi dell’antichità, vissuti prima della venuta di Cristo, tra
i quali lo stesso Virgilio. La loro unica “sofferenza” è quella di non poter mai vedere
la luce di Dio. Nel
secondo cerchio
sono puniti i
lussuriosi
, travolti da una bufera. Nel
terzo cerchio
sono puniti i
golosi
, riversi nel fango sotto la pioggia battente. Nel
quarto
















