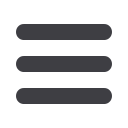
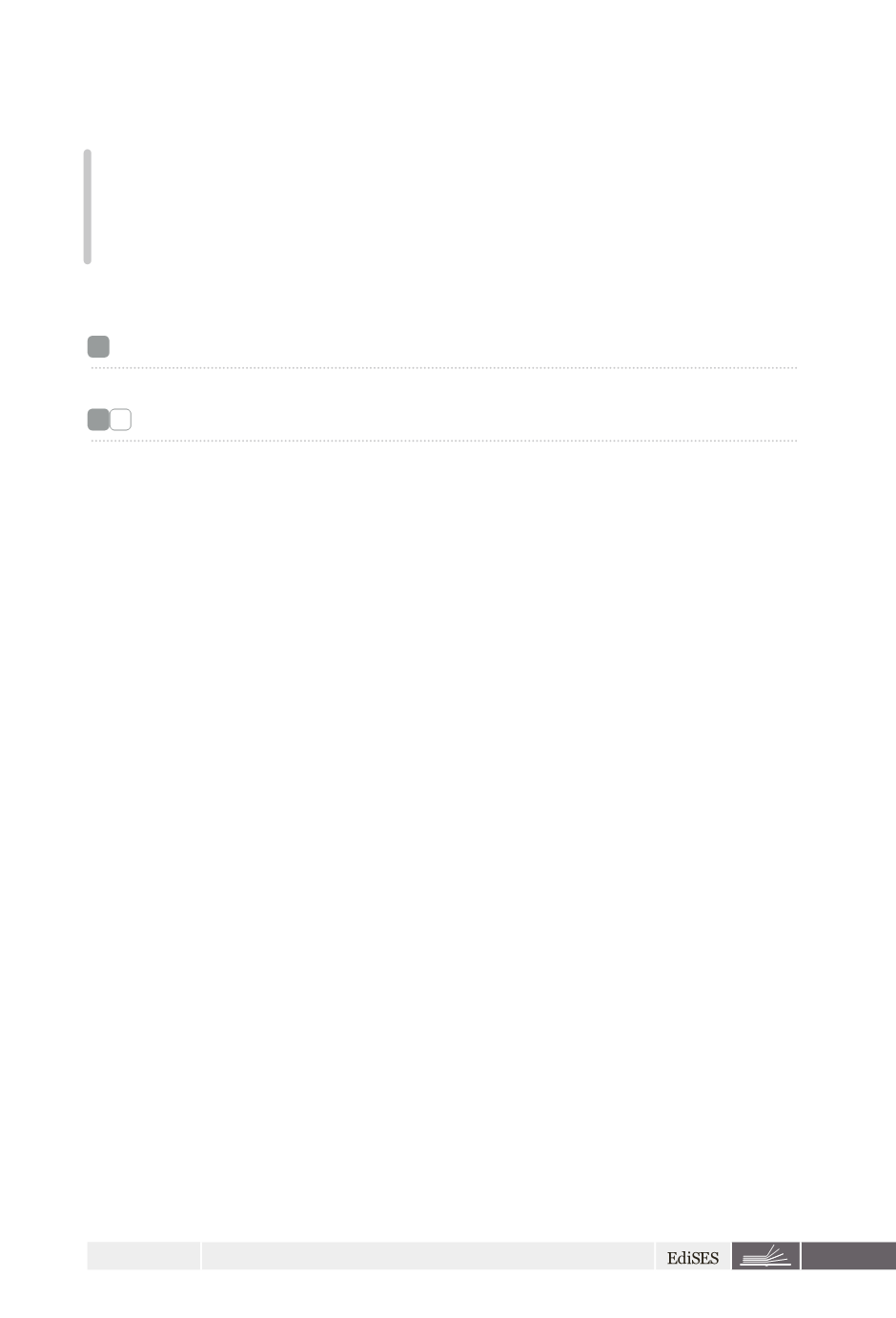
www.
edises
.it
CAPITOLO
1
Letteratura italiana
1
.
1
•
Medioevo
1.1.1
•
Le origini della letteratura in volgare
La letteratura in volgare, cioè nella lingua parlata dal volgo o popolo, nacque nel
XIII secolo
, af!ancandosi alla letteratura in latino. Le ragioni di questa
rivoluzione
culturale
sono varie e risalgono alla frantumazione dell’originaria unità linguistica e
culturale creata dall’Impero romano nel bacino del Mediterraneo. Le modi!cazioni
morfologiche e lessicali del latino portano allo sviluppo delle parlate locali che, dopo
ulteriori evoluzioni e differenziazioni, diventarono le cosiddette
lingue neolatine
(cioè derivate dal latino): i
volgari del sì
in Italia, il
volgare d’oil
nella Francia settentrio-
nale, il
volgare d’oc
nella Provenza (Francia meridionale), il portoghese, il castigliano
e il catalano nella Penisola Iberica. Venivano detti volgari perché tali lingue, come
detto, erano parlate dal volgo, un po’ come gli attuali dialetti. Il latino restò la lingua
scritta per tutto l’Alto Medioevo, ma conosciuto da una cerchia sempre più ristretta
di intellettuali, quasi esclusivamente ecclesiastici.
Nei secoli XI e XII cominciarono a svilupparsi le
letterature romanze
(questo termine
ha lo stesso signi!cato di neolatine): in particolare, in
lingua d’oil
si ebbero le opere
del
ciclo carolingio
(sulle imprese di Carlo Magno e dei suoi paladini) e del
ciclo bretone
(sulle imprese dei cavalieri della “Tavola rotonda” di re Artù), in
lingua d’oc
o proven-
zale si ebbe la
poesia cortese
.
Un’autentica letteratura in volgare si produsse nel nostro Paese a partire dal Duecento.
In Italia c’era un notevole frazionamento politico, per cui nelle regioni centro-setten-
trionali si erano sviluppati i Comuni, appro!ttando della crisi dell’Impero germanico;
nell’Italia centrale si era affermato lo Stato della Chiesa e nell’Italia meridionale uno
Stato accentratore che non tollerava autonomie cittadine, il Regno, prima normanno e
poi svevo, di Sicilia. Soprattutto nell’Italia dei Comuni, con la crisi del feudalesimo, si svi-
luppò una nuova classe sociale, la
borghesia mercantile urbana
, costituita da artigiani,
mercanti, banchieri, la quale cominciò a esprimere esigenze nuove anche sul piano della
scrittura. Divenne infatti necessario utilizzare il volgare anche per iscritto nelle transa-
zioni commerciali, mentre i Comuni avevano bisogno di personale colto per redigere
documenti, statuti, inviare messaggi, ecc., ovviamente in volgare. Nacquero pure nuove
esigenze culturali, come poter esprimere valori e idealità che la borghesia mercantile
avvertiva come propri e che non ritrovava nella produzione letteraria dei chierici.
Per tutte queste ragioni, accanto ai tradizionali intellettuali della Chiesa (i
chierici
)
che scrivevano in latino, si affermarono i
nuovi intellettuali laici
di estrazione bor-
ghese che scrivevano in volgare, ma che conoscevano anche il latino.
















