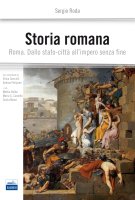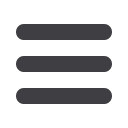

62
Roma. Dallo stato-città all’impero senza fine
rivestiva un notevole significato politico e strategico, sul piano religioso, cultu-
rale e simbolico e, in nome delle tradizioni comuni di Romani e Latini, Roma
fece propri i rituali della Lega, come dimostra ad esempio la conservazione e
l’inserimento nel calendario delle feste romane fino ad età imperiale avanzata
delle
Feriae latinae
, celebrate ogni anno dai popoli della Lega. La sintesi Romani/
Latini ebbe effetti anche a livello giuridico perché Roma fece propria la facoltà
di dedurre, oltre alle colonie di diritto romano, colonie di diritto latino, che fino
a quel momento erano state prerogativa della Lega. Nei territori acquisiti Roma
dedusse colonie, come Terracina, colonia romana, nel 329 a.C.;
Cales
(l’odierna
Calvi Risorta, sulla via Casilina presso Capua), colonia latina, nel 337 a.C.;
Fre-
gellae
, colonia latina (situata lungo la via Latina fra
Aquinum
, Aquino, e
Frusino
,
Frosinone, e identificabile forse con l’odierno abitato di Ceprano) nel 328 a.C.,
e trasformò in municipi i preesistenti centri abitati (come Suessula e Acerra nel
334 a.C., mentre Fondi e Formia ottennero la cittadinanza senza diritto di voto),
garantendosi così il controllo di tutta la via Latina tra Lazio e Campania.
L’alleanza con i Sanniti, le cui modalità e le cui clausole specifiche non ci
sono note, fu sicuramente fenomeno di breve durata: dopo la conclusione della
guerra latina, i Romani si preoccuparono di bloccare le potenziali spinte espan-
sionistiche sannitiche lungo il fiume Liri e in direzione del mare rispettivamente
fondando nel 328 a.C. la già citata colonia di
Fregellae
e intervenendo nel 327
a.C. a favore della colonia greca di Napoli. L’intervento romano (di fatto un’oc-
cupazione) a Napoli giungeva a seguito dei numerosi tentativi perpetrati dalle
colonie greche del sud Italia di liberarsi dalle sempre più incombenti popolazioni
italiche di Lucani, Sanniti, Iapigi e Messapi. Fallito il ricorso a diversi sovrani
ellenici (nel 343 a.C. Archidamo, re di Sparta, e nel 336 a.C. Alessandro il Mo-
losso, re d’Epiro e zio materno di
Alessandro Magno), le città magnogreche si
resero conto della necessità di scendere a patti con Roma per evitare di essere
assoggettati dalle popolazioni italiche. Nel 328 a.C., quindi, gli abitanti di Napoli
chiesero aiuto ai Romani che intervennero l’anno successivo inviando un eserci-
to al comando del console Quinto Publilio Filone, il quale sconfisse gli abitanti
di
Palaeopolis
, la parte vecchia della città ormai profondamente permeata dalla
presenza sannita, e concesse invece agli abitanti di
Neapolis
un trattato molto
vantaggioso, stipulato nel 326 a.C. Questo atteggiamento di Roma apertamente
ostile ai Sanniti determinò una forte reazione, che si concretizzò in due guerre
consecutive, che taluni storici ritengono un unico conflitto: le cosiddette secon-
da e terza guerra sannitica (rispettivamente 326-304 a.C. e 298-290 a.C.).