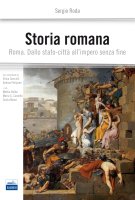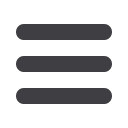

72
Roma. Dallo stato-città all’impero senza fine
sostentamento; la derivazione del termine
colonia
(dal verbo
colere
, coltivare) rende
evidente l’importanza di questo elemento nel processo di deduzione coloniaria.
Tuttavia non sempre i Romani procedevano a nuove fondazioni: quando nei
territori assoggettati esistevano comunità dotate già di un impianto istituzionale
funzionale, le mantenevano in uso attraverso la trasformazione in municipi. Il
termine
municipium
deriva dal latino
munus
(dovere) e
capere
(prendere): i municipi
erano tenuti, infatti, ad assolvere a specifici doveri nei confronti di Roma e, in
particolare, a corrispondere a Roma tributi. Gli abitanti dei municipi potevano
godere di disparati statuti giuridici: potevano essere cittadini romani di pieno
diritto così come cittadini privi del diritto di voto e tali condizioni non erano
fissate in modo assoluto, ma soggette a variazioni in base ai comportamenti
individuali o collettivi della comunità nel suo complesso. I municipi avevano
autonomia amministrativa ed eleggevano i propri magistrati.
Vi erano infine situazioni in cui l’intervento organizzativo romano nei territori
assoggettati era praticamente nullo e i rapporti con le popolazioni vinte erano re-
golati attraverso un trattato: era questo il caso delle
civitates foederatae
e dei
socii
italici,
ossia degli alleati, costituiti soprattutto dalle città greche ed etrusche. La posizione
delle
civitates foederatae
e dei
socii
era quella più sfavorita, poiché mentre per un verso
non beneficiavano delle varie forme di diritto di cittadinanza romano, per l’altro
erano costretti a fornire truppe, o comunque supporto, all’esercito romano e do-
vevano pagare tributi a Roma; privi di ogni autonomia nelle relazioni internazio-
nali, non potevano stringere trattati con altri o muovere guerra autonomamente.
Sebbene la condizione degli alleati si configurasse quindi in termini fortemente
penalizzanti tanto da prefigurare potenziali rivolte contro l’oppressione romana, i
casi di sollevazione furono nel complesso pochi e limitati grazie ad un sistema di
fidelizzazione delle
élite
locali attuato da Roma, che le rendeva meno propense a una
ribellione e, di conseguenza, acquietava anche le intemperanze delle classi inferiori.
Questo complesso sistema di controllo del territorio, la cui realizzazione fu
prevalentemente empirica e non dettata da una valutazione tecnico-politica pre-
ventiva, portò comunque non solo a un assoggettamento delle realtà locali ma
a una assimilazione culturale, che omologò nuove e vecchie comunità nel nome
di Roma. Questo fenomeno viene solitamente definito romanizzazione, termi-
ne, coniato nel XIX secolo, ma teorizzato nei suoi contenuti almeno a partire
dal Settecento. La romanizzazione e la sua interpretazione storica è da alcuni
decenni oggetto di serrata critica e di continui tentativi di revisione. La principale
obiezione che viene mossa è di essere frutto di una visione romanocentrica che re-
lega ad un livello subordinato il contributo delle comunità indigene alla creazione
della cultura che definiamo comunemente romana, ma che nascerebbe invece
dalla commistione di varie culture differenti; pur tenendo in considerazione gli