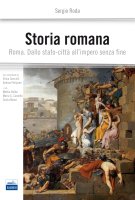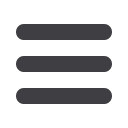
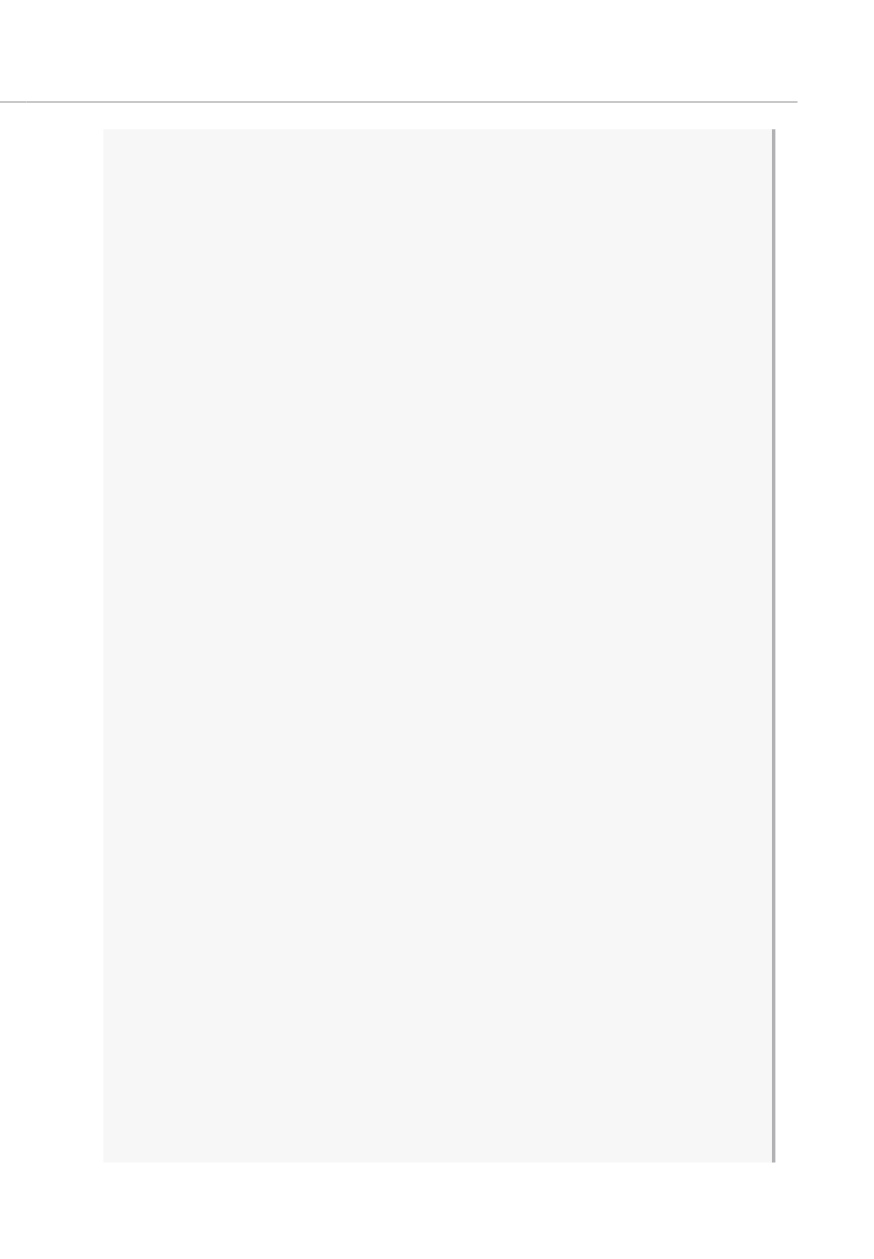
Capitolo Terzo
–
Roma e l’Italia
75
poi Augusto indicarono in Iulo, o Ascanio, figlio di Enea, il capostipite della
propria famiglia e quindi, indirettamente, il proprio legame con la dea Venere,
madre di Enea. Roma fu quindi identificata come la nuova Troia: da ricordare
in questo senso il confronto emblematico, espresso con forza alla caduta di Car-
tagine da Scipione che, secondo le fonti, avrebbe palesato il timore che anche la
fine di Roma potesse essere analoga a quella di Troia, presa dal nemico e data
alle fiamme. L’identità troiana di Roma veniva ribadita annualmente dal pelle-
grinaggio che i magistrati romani compivano a Lavinio, dove erano venerati i
numi tutelari portati da Enea nella sua fuga da Troia.
Tuttavia, non fu questa l’unica traccia identitaria significativa che i Romani
crearono; a partire dal III secolo a.C. e poi soprattutto nel II, quando le contese
conseguimento di cariche pubbliche a Roma si fecero più aspre, molti senatori
romani iniziarono a proclamare una propria identità etnica specifica: chi si dice-
va latino, chi sabino, chi etrusco. Mentre l’identificazione con Troia non aveva
effettiva consistenza storica, il richiamo ad etnie dell’Italia centrale si allacciava
davvero alle origini di Roma e alla precoce compresenza in essa di popoli diffe-
renti e voleva, naturalmente, essere un richiamo alla tradizione e al
mos maiorum
;
la scelta di un ascendente etnico piuttosto che un altro significava esaltare alcuni
valori specifici che si riconoscevano propri di quel popolo. Per evidenziare la
propria discendenza da un determinato gruppo etnico gli individui delle diverse
etnie adottavano simboli e riti che li differenziavano rispetto agli altri Romani:
coloro che si dicevano Sabini, ad esempio, manifestavano devozione verso di-
vinità ritenute tipiche di quel popolo, ad esempio Quirino o Feronia, e quando
ricoprivano la carica di magistrati monetari con il compito di coniare monete, vi
facevano apporre immagini che rimandavano alla mitologia sabina.
Il richiamo alla caduta di Troia venne adoperato per la costruzione di iden-
tità etniche fittizie ancora per lungo tempo dopo la caduta dell’impero romano
di Occidente e in luoghi anche molto distanti dal bacino mediterraneo ove il
mito aveva avuto origine: nell’
Historia Regum Britanniae
, scritta al principio del
XII secolo da Goffredo di Monmouth riprendendo leggende molto più antiche
già rielaborate nel IX secolo da Nennio nella sua
Historia Brittonum
, si racconta
della fondazione di
Troia Nova
, poi chiamata
Trinovantum
, la futura Londra, ad
opera di
Brutus
, nipote di Enea, che avrebbe anche dato il nome all’isola di
Britannia. Narrando questa storia, Goffredo di Monmouth costruisce l’identità
dei Britanni e la pone allo stesso livello genealogico di quella dei Romani, ma
la fissa in epoca precedente, assegnandole così una sorta di primato rispetto a
Roma. Col suo racconto Goffredo non solo svincola l’identità britannica da
quella romana, ponendo per la città di Londra una fondazione diversa e con-
correnziale a quella di Roma, ma nega anche ai Romani il ruolo di vincitori
dei Britanni addossando ogni colpa della caduta di questi alle loro proprie de-