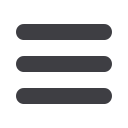
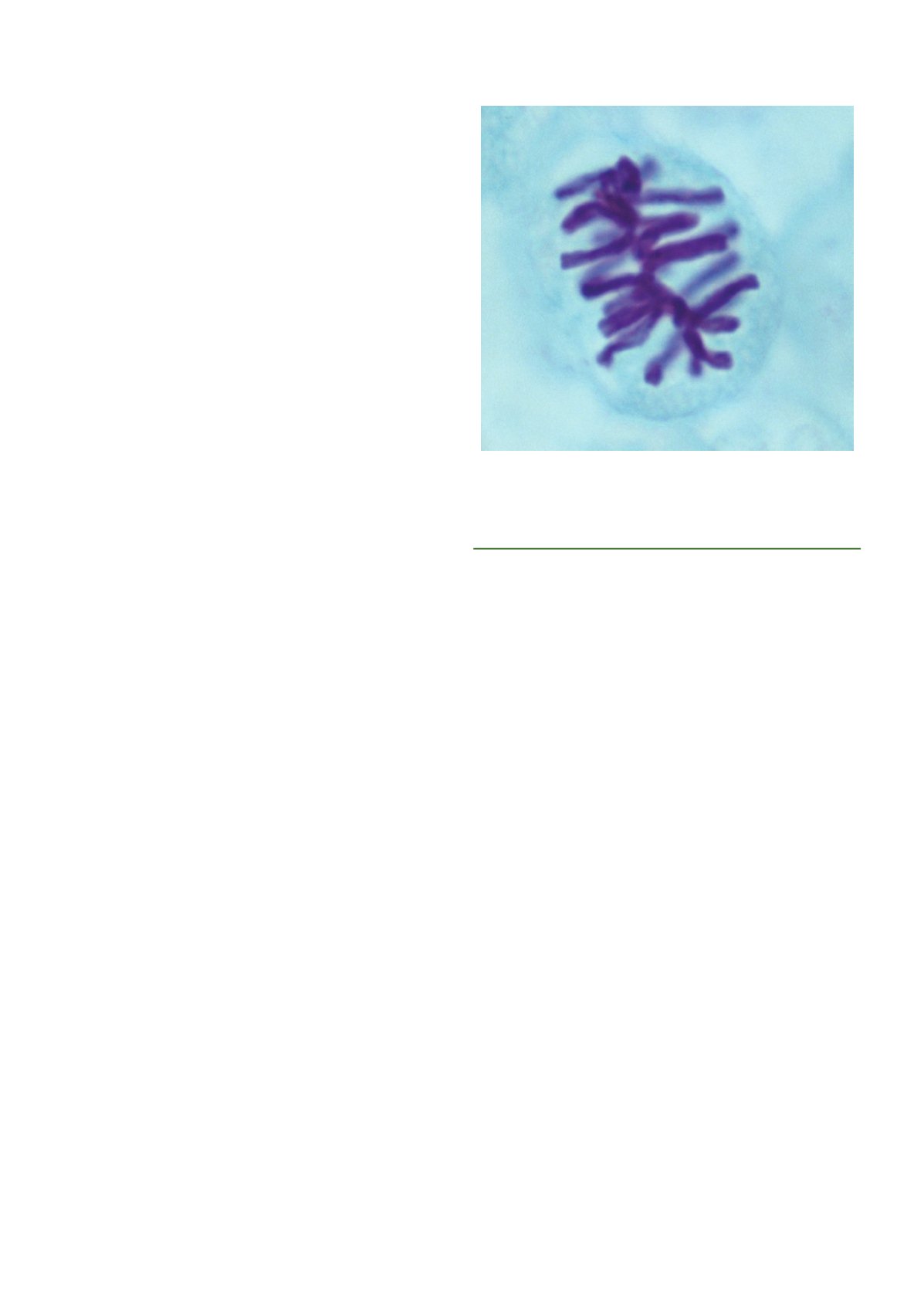
18.1
MICROSCOPIO OTTICO
735
dovrebbe essere possibile vederlo. Consideriamo il caso di
una pallina di vetro. Nella maggioranza dei casi, cioè, sulla
maggior parte degli sfondi, la pallina è visibile chiaramente.
Se, invece, questa pallina è lasciata cadere in un recipiente
di olio da immersione con lo stesso indice di rifrazione del
vetro, la pallina sparisce alla vista; essa non influisce più sulla
luce se non nello stesso modo del fluido che la circonda.
Chiunque abbia speso il suo tempo a cercare un’ameba si
sarà reso conto del problema della visibilità nell’uso del mi-
croscopio ottico.
Le cose che vediamo, attraverso una finestra o attraver-
so un microscopio, sono quegli oggetti che influiscono sulla
luce in maniera diversa rispetto al loro sfondo. Un altro ter-
mine per definire la visibilità, in questo senso del termine, è
contrasto
, ovvero la differenza di aspetto fra parti adiacenti
di un oggetto o fra l’oggetto e il suo sfondo. L’importanza
del contrasto può essere facilmente compresa se consideria-
mo le stelle. Mentre il cielo notturno sereno è pieno di stelle
luminose, lo stesso cielo diurno sembra privo di corpi celesti.
Le stelle difatti si sono sottratte alla vista, ma non sono spa-
rite dal cielo. Esse semplicemente non sono più visibili sullo
sfondo molto più luminoso.
Nel mondo macroscopico, noi esaminiamo gli oggetti
facendo cadere su di essi la luce e poi osserviamo la luce che
torna riflessa verso i nostri occhi. Al contrario, quando usia-
mo un microscopio poniamo l’oggetto tra la sorgente lumi-
nosa e i nostri occhi e osserviamo la luce che viene trasmessa
attraverso l’oggetto (o più precisamente, diffratta dall’ogget-
to). Se si prende un oggetto e lo si porta in una stanza con
un’unica sorgente di luce tenendolo tra la sorgente di luce e
l’occhio, ci si può rendere conto in parte della difficoltà di
una tale illuminazione; essa richiede che l’oggetto da esami-
nare sia quasi trasparente, cioè, traslucido. In questo risiede
un altro aspetto del problema: gli oggetti che sono “quasi
trasparenti” possono essere difficili da vedere.
Uno dei metodi migliori per rendere visibile un campio-
ne sottile e traslucido al microscopio è quello di trattarlo con
un colorante, che assorba solo certe lunghezze d’onda all’in-
terno dello spettro visibile. Le lunghezze d’onda che non
sono assorbite sono trasmesse all’occhio, facendo in modo
che l’oggetto trattato appaia colorato. Coloranti diversi si le-
gano a differenti tipi di molecole biologiche e, perciò, questi
procedimenti non solo rendono il campione maggiormente
visibile, ma possono anche indicare, nelle cellule o nei tessu-
ti, dove si trovano diversi tipi di sostanze. Un buon esempio
è la colorazione di Feulgen, che è specifica per il DNA, e fa
sì che i cromosomi appaiano colorati al microscopio (Figura
18.5). Uno dei maggiori problemi creati dai coloranti è che
essi di solito non possono essere usati con cellule vive; spesso
sono tossici, o le condizioni per la colorazione sono tossiche,
oppure non sono in grado di penetrare la membrana pla-
smatica. La colorazione di Feulgen, per esempio, richiede
che il tessuto sia idrolizzato in acido prima dell’applicazione
del colorante.
Differenti tipi di microscopi ottici impiegano diversi
tipi di illuminazione. In un
microscopio a campo chiaro
, il
cono di luce illuminante appare come uno sfondo lumino-
so sul quale l’immagine del preparato deve avere contrasto.
La microscopia a campo chiaro è adatta particolarmente per
campioni ad alto contrasto, come sezioni colorate di tessuti,
ma non darebbe una visibilità ottimale per altri campioni.
Nei paragrafi seguenti considereremo metodi alternativi per
rendere i campioni più visibili al microscopio ottico.
Preparazione di campioni per la
microscopia ottica
I campioni da osservare con il microscopio ottico possono es-
sere divisi generalmente in due categorie: preparati in toto o
sezioni.
In
toto
è riferito ad un oggetto intatto, vivo o mor-
to, che può essere un intero microrganismo, come un proto-
zoo, oppure una piccola parte di un organismo più grande.
La maggior parte dei tessuti di piante e animali è fin troppo
opaca per un’analisi microscopica che non sia fatta con fette
molto sottili, o
sezioni
. La prima fase del processo è l’uccisio-
ne delle cellule mediante immersione del tessuto in una so-
luzione chimica, detta
fissativo
. Un buon fissativo è in grado
di penetrare rapidamente la membrana cellulare e di immobi-
lizzare tutto il materiale macromolecolare in modo tale che la
struttura della cellula si mantenga il più possibile vicino allo
stato vivente. I fissativi più comuni per il microscopio ottico
sono soluzioni di formaldeide, alcol o acido acetico.
Dopo la fissazione, il tessuto è disidratato mediante tra-
sferimento attraverso una serie di alcoli e incluso in paraffi-
na (cera), che dà il supporto meccanico durante il seziona-
mento. Uno dei grandi vantaggi della paraffina, come mezzo
di inclusione, è la facilità con cui essa può essere disciolta
in vari solventi organici. I vetrini contenenti queste sezio-
ni in paraffina sono semplicemente immersi in toluene per
rimuovere la paraffina, lasciando sottili sezioni di tessuto at-
taccate al vetrino, dove possono essere colorate o trattate con
enzimi, anticorpi o altri agenti. Dopo la procedura di colo-
razione, si monta un vetrino coprioggetto sul tessuto usando
un mezzo di montaggio con lo stesso indice di rifrazione del
portaoggetto e del coprioggetto.
Il microscopio a contrasto di fase
Piccoli campioni non colorati, come le cellule viventi, pos-
sono essere molto difficili da distinguere con un microscopio
a campo chiaro (Figura 18.6
a
). Il
microscopio a contrasto
Figura 18.5
La colorazione di Feulgen.
Questo metodo di colora-
zione è altamente specifico per il DNA, come dimostrato dalla localiz-
zazione del colorante sui cromosomi di questa cellula di apice radicale
di cipolla che era in metafase mitotica al momento della fissazione.
(D
A
E
D
R
ESCHKE
.)
















