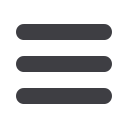

52
Parte Seconda
Le singole discipline – Diritto costituzionale
www.
edises
.it
I termini «
libertà
» e «
diritti
» stanno a indicare le
posizioni giuridiche soggettive
di vantag-
gio, che non ammettono interferenze o soggezioni a terzi, e richiedono di essere protette e
soddisfatte dall’ordinamento giuridico.
La formazione dello Stato moderno è stata caratterizzata dalla congiunta affermazione dei di-
ritti dell’uomo al ine di tutelare il popolo da possibili abusi da parte del Sovrano o dei pote-
ri pubblici.
I diritti e le libertà fondamentali hanno trovato un primo riconoscimento nelle Carte costitu-
zionali e nelle Dichiarazioni dei diritti dell’uomo redatte tra il XVII e XVIII secolo, in con-
comitanza con le rivoluzioni borghesi.
Con tali atti furono riconosciuti, in Europa e negli Stati Uniti, una serie di diritti al popolo che pri-
ma non godevano di un’espressa tutela giuridica:
-
Petition of Rights
del 1628 (Inghilterra);
-
Bill of Rights
del 1689;
- Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti del 1791 (i primi dieci emendamenti);
- Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 inserita nella Costituzione francese
il 3 settembre 1791 – sempre richiamata nel preambolo delle successive Costituzioni francesi –
dove si proclamano «i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo».
Si è anche affermata, in tutte le Dichiarazioni, la stretta connessione esistente tra la Costituzione e
diritti fondamentali dell’uomo, al punto di ritenere che non può esistere una Carta costituzionale di
uno Stato se in essa non è contenuta una effettiva garanzia dei diritti umani.
È quanto ad esempio afferma l’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del
1789: «Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri
issata, non ha una Costituzione».
A seconda del periodo storico di affermazione, i diritti sono raggruppati in generazioni.
I
diritti di prima generazione
, affermatisi con le rivoluzioni borghesi e con le connesse Dichiara-
zioni dei secoli XVII e XVIII, comprendono:
- i
diritti civili o libertà individuali
, intesi come libertà negative o libertà dallo Stato: il diritto alla
vita e all’integrità isica, la libertà personale, di pensiero, di religione, di circolazione, di domi-
cilio, libertà di manifestazione del pensiero;
-
le libertà economiche
: libertà di iniziativa economica e diritto di proprietà.
I
diritti di seconda generazione
si sono affermati a partire dalla seconda metà dell’Ottocento con
le rivendicazioni da parte del proletariato di una reale ed attiva partecipazione alla vita dello Stato,
nel contesto storico che segna il passaggio dallo
Stato liberale
allo
Stato liberaldemocratico
. Ne fan-
no parte:
- i
diritti politici
, o libertà nello Stato: il diritto di voto e diritto di accedere alle cariche elettive;
è riconosciuta e tutelata l’estensione dei diritti politici alla generalità degli individui, senza pre-
giudizio di ricchezza o di ceto per il loro esercizio;
- i
diritti associativi
: diritto di riunione, di associazione, di costituzione e di adesione ai partiti po-
litici e sindacati;
- i
diritti economici
: vi rientrano il diritto allo sciopero e il diritto alla tutela sindacale. Le libertà
economiche oggi non sono più considerate come diritti inviolabili dell’uomo.
I
diritti di terza generazione
si affermano nel primo Novecento, dopo la prima guerra mondiale e
dopo la crisi economica degli anni Trenta. Si chiedeva allo Stato un’incisiva azione per riequilibrare le
disparità sociali e rendere le libertà accessibili alla collettività mediante l’azione attiva dello Stato.
Ne fanno parte i diritti sociali: diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione, all’assistenza e alla previ-
denza, all’abitazione.
















