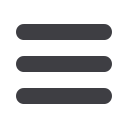
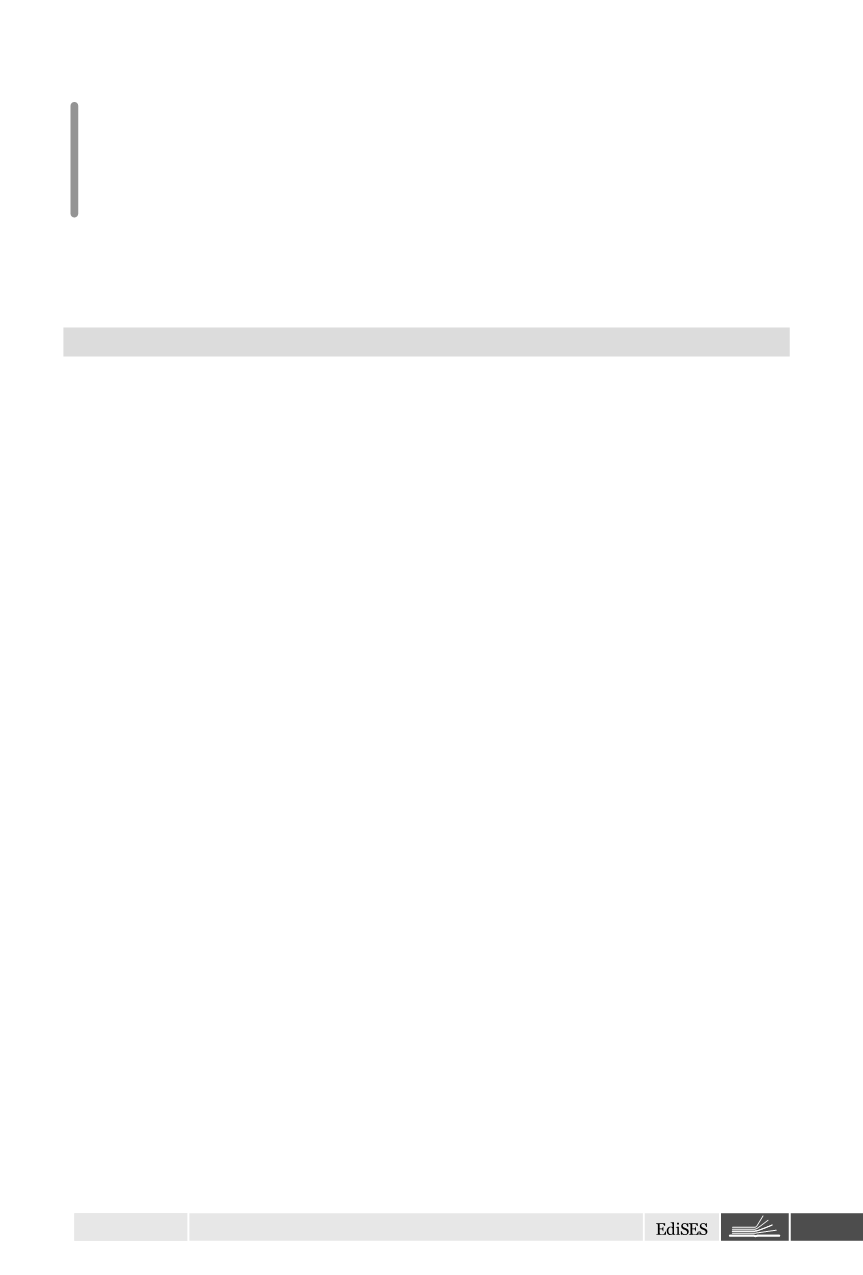
www.
edises
.it
Capitolo 3
La Costituzione italiana
3.1 Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana
Lo Statuto albertino è stata la principale fonte ordinamentale dell’Italia unita dal 1861 al 1948.
Era una costituzione “
ottriata
”, cioè concessa dal Sovrano (Carlo Alberto, re di Sardegna),
che nel 1848 riconobbe ai sudditi prerogative particolari che limitavano il suo potere garan-
tendo una serie di diritti. Lo Statuto fu recepito dallo Stato unitario nel 1861. Lo Statuto era
un tipo di
costituzione breve e lessibile
ed aveva valore di
legge ordinaria
. Questa sua carat-
teristica ha consentito al Parlamento di adottare leggi ordinarie che hanno modiicato, senza
abrogare lo Statuto, il regime dello Stato durante il periodo fascista, da monarchia costituzio-
nale parlamentare a dittatura del primo ministro «duce del fascismo». La
Camera dei depu-
tati
perse il suo carattere elettivo divenendo la «
Camera dei fasci e delle corporazioni
».
All’indomani della caduta del regime fascista, il nuovo equilibrio politico venutosi a creare nel
Paese trovò espressione normativa nel decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
poi convertito nella XV disposizione transitoria della Costituzione. Il decreto demandava al po-
polo la scelta della forma di governo, repubblicana o monarchica, disponendo al primo comma
dell’art. 1, che «dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scel-
te dal popolo italiano, che a tal ine eleggerà a suffragio universale diretto e segreto una
Assem-
blea Costituente
per deliberare la nuova Costituzione dello Stato». L’atto legislativo sanciva
anche l’impegno dei ministri a «non compiere ino alla convocazione della Assemblea Costi-
tuente» atti che potessero pregiudicare la «soluzione della questione istituzionale». Il decreto le-
gislativo luogotenenziale n. 98 del 1946 stabilì, inine, che la forma monarchica o repubblicana
dello Stato sarebbe stata deinita direttamente dal popolo mediante referendum.
Il
referendum
istituzionale
si svolse il 2 giugno 1946, contestualmente all’elezione dei depu-
tati all’Assemblea costituente. Questa aveva il compito di scrivere il testo di quella che sarebbe
stata la Costituzione di una Repubblica o di una Monarchia a seconda dell’esito referendario.
I voti in favore della Repubblica furono circa 12 milioni e 700 mila, cioè il 54% dei suffragi
espressi, quelli per la Monarchia 10 milioni e 700 mila. Alla consultazione partecipò l’89%
degli aventi diritto.
I risultati elettorali portano nell’Assemblea costituente tre partiti di massa, Democrazia cri-
stiana, Partito socialista e Partito comunista, ed altri partiti minori.
L’incarico di predisporre il progetto di Costituzione fu conferito ad una
Commissione di 75
deputati
, designati con il criterio di rappresentanza proporzionale tra i diversi gruppi politi-
ci, presieduta da
Meuccio Ruini
.
La complessità e l’urgenza del lavoro spinsero la Commissione a deliberare la suddivisione
in tre sotto-commissioni: la prima, presieduta da
U. Tupini
, per i
diritti e doveri dei cittadini
;
la seconda, presieduta da
U. Terracini
, per l’
ordinamento costituzionale della Repubblica
, la
terza, presieduta da
G. Ghidini
, per i
diritti e i doveri economico-sociali
.
















