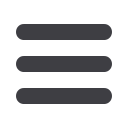

www.
edises
.it
VIII
Finalità e struttura dell’opera
avvalersi di un’approfondita conoscenza dei contenuti che vuole proporre. In
questo modo, egli riesce a declinarli con proprietà ed incisività, mettendo in
rilievo tutti gli aspetti critici. Analogamente, il docente deve essere in grado di
operare con padronanza e sicurezza usando le nuove tecnologie. Sono queste
ultime che possono mettere in rilievo gli stili cognitivi degli alunni, la loro
propensione a comprendere attraverso canali di comunicazione multimodale,
usando simulazioni, immagini in movimento, narrazioni sonore, diagrammi,
piuttosto che il solo testo. È opinione comune che, in futuro, il testo perderà
la propria funzione predominante di veicolo per la trasmissione della cono-
scenza e sarà affiancato (anche se non sostituito), con pari dignità, da altri
veicoli (suoni, immagini, simulazioni) con i quali gli studenti di oggi hanno già
familiarizzato.
L’attenzione si sposta quindi dalla pratica di insegnamento del docente al pro-
cesso di apprendimento dello studente. Questo vuol dire che la didattica tra-
smissiva, fatta di una mole interminabile di nozioni che allo studente rischiano
di apparire vuote di significati, occorre sostituire una didattica improntata alla
maturazione delle competenze negli alunni. Questi ultimi devono cogliere l’u-
tilità di quello che studiano e devono riuscire a richiamarne il significato in un
contesto reale, essendo capaci di applicare quello di cui sono entrati in possesso.
Inutile dire che la didattica delle discipline matematiche e scientifiche risen-
te particolarmente di queste criticità e potrebbe beneficiare oltremodo di un
approccio multimodale nella dinamica di insegnamento ed apprendimento.
Le discipline matematiche e scientifiche devono far maturare nello studente
quelle competenze che lo rendano cittadino partecipe e cosciente della società
di domani. Pertanto il docente deve sapersi allontanare dalla cattedra ed av-
vicinarsi ai banchi, assumendo anche il ruolo di tutor, ossia di professionista
della formazione, di persona che coglie i bisogni reali degli alunni e declina la
propria disciplina in base a tali necessità.
In particolare, la matematica deve diventare la “matematica dell’utile”, affin-
ché chi si avvicina ad essa possa comprenderne l’importanza in contesti pratici
e reali che certamente contribuiscono a rendere la disciplina più affascinante
agli occhi di chi la studia.
Le ultime indagini internazionali (OCSE-PISA, IEA-TIMMS) e le prove del ser-
vizio nazionale di valutazione a cura dell’INVALSI sono orientate proprio a
mettere in evidenza questi aspetti della disciplina. Probabilmente gli scarsi ri-
sultati conseguiti dagli studenti italiani nelle precedenti indagini internazionali
sulle materie scientifiche hanno messo in evidenza che questo approccio alla
disciplina viene poco seguito nella scuola italiana. Come controprova, l’eviden-
te miglioramento dei risultati nell’ultima indagine OCSE-PISA, determinato in
buona parte dal miglioramento dei risultati nelle regioni meridionali che in
precedenza avevano segnato il passo, è frutto di una serie di interventi sistemici
che il Ministero, gli enti di ricerca e le istituzioni scolastiche hanno posto in
essere negli ultimi anni.
La “matematica del pratico e dell’utile” assolve anche ad un altro obiettivo
istituzionale, ossia la maturazione delle competenze di base, in corrispondenza
















