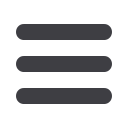
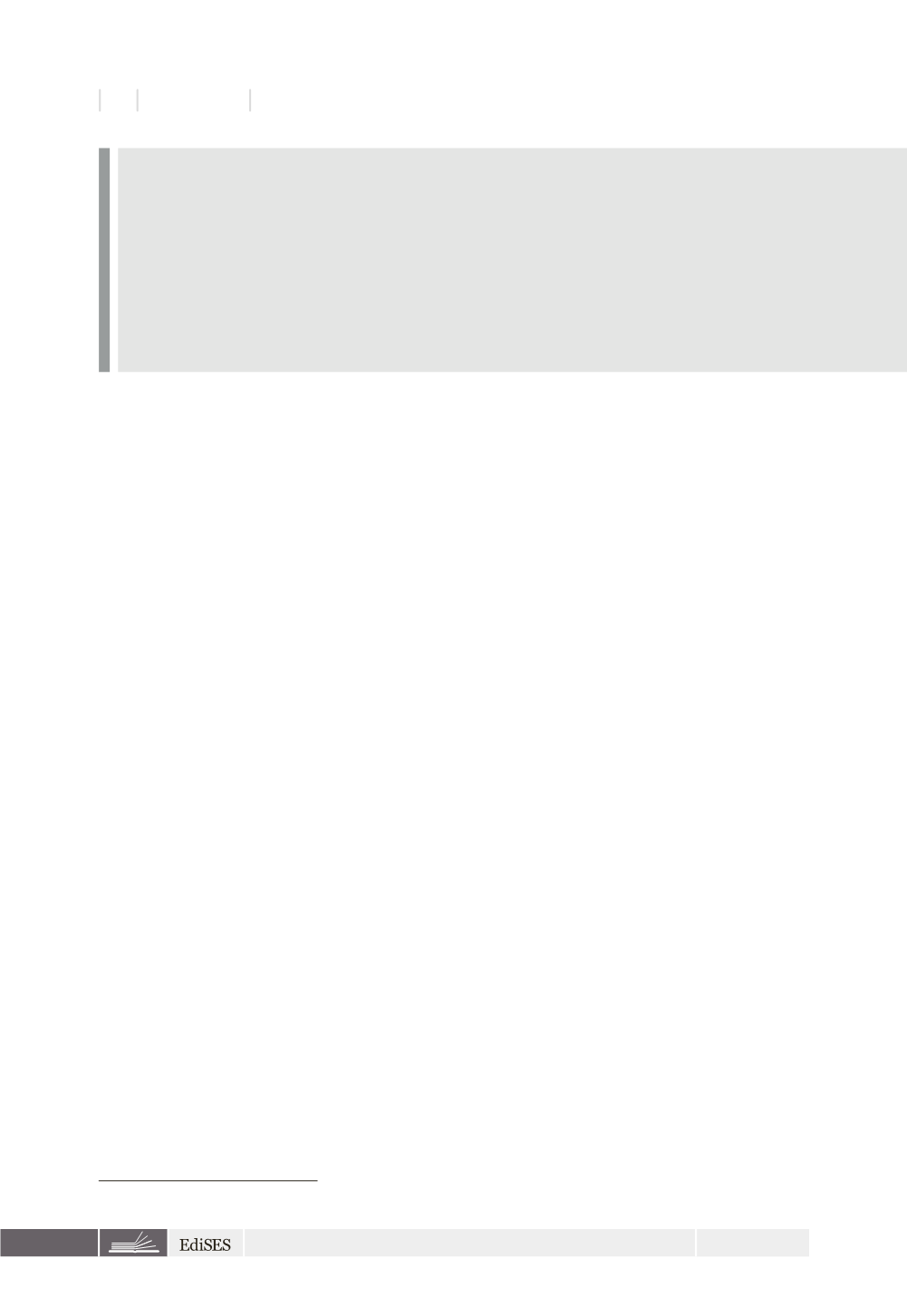
152
Parte Seconda
I bisogni educativi speciali
www.
edises
.it
Le attività di sostegno didattico
Esistono poi manifestazioni che, in rapporto all’età di insorgenza, costituiscono indica-
zioni assolute per un’immediata valutazione più approfondita: l’assenza di lallazione e di
gesti con funzione comunicativa dopo i
12 mesi
; la mancata pronuncia di parole singole
dopo i
16 mesi
, o di associazioni spontanee di due parole dopo i
24 mesi
; la perdita di
competenze già acquisite nelle aree della comunicazione, del linguaggio e della socialità,
indipendentemente dall’età in cui si verifica.
Lucio Cottini – Bruna Lani,
Il lavoro educativo con il bambino
con sindrome autistica
, in
Una introduzione all’Educazione Speciale
,
Salute & Società, Raffaello Cortina Editore, 2009
I progressi fatti dalla ricerca scientifica mostrano che con interventi biomedici
e terapie comportamentali tempestive e aggressive i bambini possono fare enor-
mi progressi, arrivando a esprimere tutto il loro potenziale.
Non esiste un singolo trattamento, ma il migliore possibile è un
sistema di in-
terventi
composto da:
>
diagnosi precoce;
>
accertamenti biologici e medici, supporto medico e farmacologico;
>
educazione del bambino;
>
sostegno psicologico alla famiglia;
>
continuità e coordinamento tra interventi e servizi nel corso dell’intero ciclo
di vita della persona.
Le
terapie
o gli
interventi
di tipo medico ed educativo/comportamentale, ca-
librati sulle forme e sulle caratteristiche che il disturbo può assumere nei di-
versi soggetti, hanno come principale obiettivo il raggiungimento di un grado
di qualità di vita soddisfacente per la persona del disabile e la sua famiglia: si
programmano attività strutturate per ridurre lo stress e l’ansia, si coordinano
azioni riabilitative per migliorare l’autonomia e le capacità di relazione inter-
personale e, all’occorrenza, si prescrivono farmaci per alleviare le manifesta-
zioni depressive, l’iperattività, l’aggressività e gli eventuali disturbi epilettici.
L’intervento deve essere globale e investire «sia lo sviluppo
percettivo-mo-
torio
che quello
emotivo-affettivo
per avviare alla strutturazione di capa-
cità relazionali e di modalità analitico-deduttive come presupposto di una
cognitività non più istintiva e prelogica (centrata sul
senso
), ma razionale e
simbolica (basata sul
significato
)»
2
.
11.2
Evoluzione storica degli studi sull’autismo
Il primo ad adoperare il termine «autismo» fu lo psichiatra svizzero
Eugen
Bleuer
(1857-1939) per descrivere nel 1938 una particolare forma di «chiu-
sura sociale» causata dalla schizofrenia. Nel 1943
Leo Kanner
(1894-1981),
psichiatra infantile, utilizzò il medesimo termine per indicare una sindrome
2
L
UCONI
R.,
Network di studio dell’autismo e delle psicosi infantili
.
















