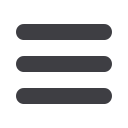

476
Parte Quarta
Sapere e saper fare: spunti operativi
www.
edises
.it
precedono, cosicché la stessa immagine può assumere una signicazione pro-
fondamente drammatica o irresistibilmente comica in rapporto all’immagine
che l’ha preceduta o a quella che la segue sullo schermo. Questi rapporti tra le
immagini hanno creato una nuova tecnica di comunicazione e di espressione,
che richiede da parte dello spettatore, data la complessità di abbreviazioni,
metafore e simboli visivi che le sono ormai divenuti propri, una particolare
sensibilità, una forma di assuefazione a “pensare otticamente”.
Di questa nuova tecnica di espressione e di comprensione si è tentato a diverse
riprese di denire le forme grammaticali seguendo una puntuale e precisa
analogia con le forme verbali. Gli elementi strutturali del lm sono:
>
il quadro
, cioè una parte di film che rappresenta degli oggetti senza visibile
discontinuità spaziale o temporale;
>
la serie
, cioè una successione di quadri;
>
la sequenza
, una successione di quadri che fornisce la rappresentazione uni-
taria di un concetto.
Tali elementi possono trovare una facile analogia con le parti che costituiscono
il linguaggio parlato o scritto: il quadro corrisponde alla parola, la serie alla
proposizione, la sequenza al periodo. L’insieme delle sequenze, nell’ordine
stabilito dal regista, costituirà il
montaggio,
cioè l’insieme della narrazione
cinematograca. I
tagli
, cioè i passaggi da una scena a quella seguente, costi-
tuiscono i segni di interpunzione del linguaggio cinematograco e, secondo
la diversa tecnica con cui vengono realizzati, corrispondono a delle pause nel
discorso, più o meno prolungate. Ecco perché i singoli fotogrammi di un lm
non sono solamente dei pezzetti di celluloide incollati uno dopo l’altro: essi
sono anche, per il loro contenuto, un ininterrotto succedersi di rapporti. Que-
sti rapporti sono voluti e determinati dall’autore del lm in vista di particolari
reazioni emotive che egli vuole suscitare nello spettatore.
Dall’insieme dei fattori emotivi del lm determinati dal taglio, dall’inquadra-
tura e dalla composizione dei quadri deriva il complessivo valore emotivo del
lm. Questa è proprio una delle obiezioni che più comunemente si muove
contro la possibilità di applicazione per ni pedagogici del linguaggio lmico,
e cioè che, basandosi principalmente sulle reazioni emotive dello spettatore,
non può contribuire alla formazione di giudizi logici e di valutazioni morali.
Inoltre, facendo presa in modo particolare sulle facoltà intuitive dello spetta-
tore, lo disabitua al ragionamento. A queste due obiezioni si può rispondere in
primo luogo con un’osservazione di carattere psicologico, cioè che il carattere
emotivo dell’esperienza sensoriale, suscitando l’interesse, facilita e non ostaco-
la l’apprendimento. Inoltre, il montaggio si avvale continuamente del processo
associativo delle idee e dei sentimenti, e queste associazioni si traducono in
conoscenze, giudizi o deduzioni logiche. In questo modo, per quanto nell’ap-
prendimento per mezzo del cinema si segua la via opposta a quella tenuta
dall’istruzione verbale, la fase della formulazione logica dei giudizi non manca,
anche se viene in un secondo momento. Inoltre, alcuni psicologi americani
sostengono che la persistenza della memoria di un fatto o di un fenomeno è
















