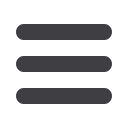

Parte III - Simulazioni d’esame
648
32) Il candidato legga il seguente brano, nel quale si parla dell’e-
ducazione nell’età dell’adolescenza, un’età nella quale l’educatore
deve mettere il ragazzo in condizione di fare esperienza degli altri,
un compito difficile e delicato per il quale possono servire la storia,
le biografie, le narrazioni:
«Ai segni manifesti di un umore che cambia si uniscono sensibili cambia-
menti di aspetto. La sua fisionomia si sviluppa assumendo l’impronta di
un carattere: la tenera e rada lanugine che ricopriva le guance diventa più
scura e prende consistenza. La voce cambia anzi si perde: non essendo
più un bambino e non essendo ancora un uomo, egli non riesce a pren-
dere il tono di nessuno dei due. Gli occhi, questi organi dell’animo che
finora non hanno mai parlato, trovano un linguaggio e un’espressione; un
fuoco nascente li anima, i loro sguardi più vivi conservano ancora una pia
innocenza, ma non hanno più l’ingenuità primitiva. […] È a questo punto
che avviene la seconda nascita: adesso l’uomo nasce davvero alla vita e
nulla di umano gli è estraneo».
Da quale opera è tratto il brano?
A.
Dal Capitolo Secondo di
Pensieri sull’educazione
di John Locke
B.
Dal Capitolo Terzo della
Didactica Magna
di Giovanni Comenio
C.
Dal Libro Primo di
Il Saggiatore
di Galileo Galilei
D.
Dal Libro Quarto dell’
Emilio
di Jean Jacques Rousseau
33) Il filosofo inglese John Locke, nell’opera
Pensieri sull’educazio-
ne,
si rivolgeva in particolare ai figli dei borghesi (
gentlemen
) e degli
uomini d’affari del suo tempo; riteneva che ci si educa e dunque
si diventa migliori non attraverso l’incorporazione mnemonica di
nozioni ma attraverso un processo di assimilazione interiore della
coscienza. Secondo Locke, la formazione avviene stando a contatto
con l’esterno e con l’esperienza; l’esperienza poi deve essere inte-
riorizzata, deve consentire lo sviluppo delle capacità del singolo e
l’acquisizione di idee per poi esteriorizzarsi nel rapporto con gli altri.
Nella prospettiva pedagogica di Locke, il modello ideale di educazio-
ne prevedeva che:
A.
il ragazzo dovesse seguire un curriculum di studi nel quale era
attribuita molta importanza alla composizione scritta (di solito
in latino, talvolta in greco) e alla declamazione di passi di autori
classici (o scritti dal ragazzo stesso) di fronte alla classe o davanti
a un pubblico
B.
il ragazzo dovesse avere un precettore privato, che poteva garantire
una migliore formazione morale, sapeva tenere nella giusta consi-
















