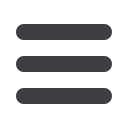

1.
La prova a test del concorso
19
Quando si lavora su argomenti di cui non si è estremamente com-
petenti, anche se le domande sono relativamente facili, è più proba-
bile effettuare piccoli errori confondendo le strategie risolutive. Ad
esempio un concorrente bravo in fisica saprà rispondere ai quesiti,
in questa materia, analizzando la domanda con precisione ed atten-
zione ai singoli dettagli “da professionista”, cioè non commettendo
“errori di leggerezza” o “non confondendo” le formule. Al contrario
è più probabile che lo stesso candidato effettui errori, per “confu-
sione”, anche a domande semplici su argomenti non caratterizzanti
il proprio profilo professionale o poco studiati nel proprio percorso
formativo. Questo vuol dire che sebbene un determinato argomento
venga studiato per il concorso in maniera approfondita, se non si ha
il
background
culturale pregresso di tale disciplina, è più probabile,
anche dopo aver conseguito un’adeguata preparazione, commettere
errori “evitabili”. Se si effettua un parallelo con la vita quotidiana si
può affermare che è più facile guidare la propria automobile, che si
conosce bene, in un contesto difficile come nel traffico urbano, che
guidare una macchina nuova, per la prima volta, su una strada più
facile. È utile per il concorrente aver presenti queste considerazioni
in modo da lavorare con maggiore attenzione alle particolarità e ai
dettagli tecnici dei quiz su argomenti “nuovi”, dove cioè è più pro-
babile effettuare errori di “distrazione”. Rispondere anche ad una
domanda in più in maniera corretta può cambiare l’esito della prova.
La non “abitudine” del candidato alle prove a test può indurre an-
che a non comprendere alcune peculiarità dei quesiti a risposta
multipla. Talvolta i quesiti presentano dei punti di “debolezza” nel-
la loro formulazione e lo studente può fare leva su questi “
bug
”.
L’esperienza e la pratica permettono di imparare ad osservare que-
ste “debolezze” dei quiz e a diventare bravi un po’ come un giurista
che riesce ad individuare alcune imperfezioni in un atto in contesti
di contenziosi legali. Ad esempio in un brano di tipo “informativo”
sarà difficile che la risposta corretta sia legata ad opinioni ed in-
terpretazioni dell’autore richiedendo al contrario un carattere mag-
giormente oggettivo. Oppure, ad esempio, in un sillogismo in cui le
premesse presentano le parole “alcuni, forse, una parte, maggiore”
è poco probabile che la risposta sia una “totalità”.
















