
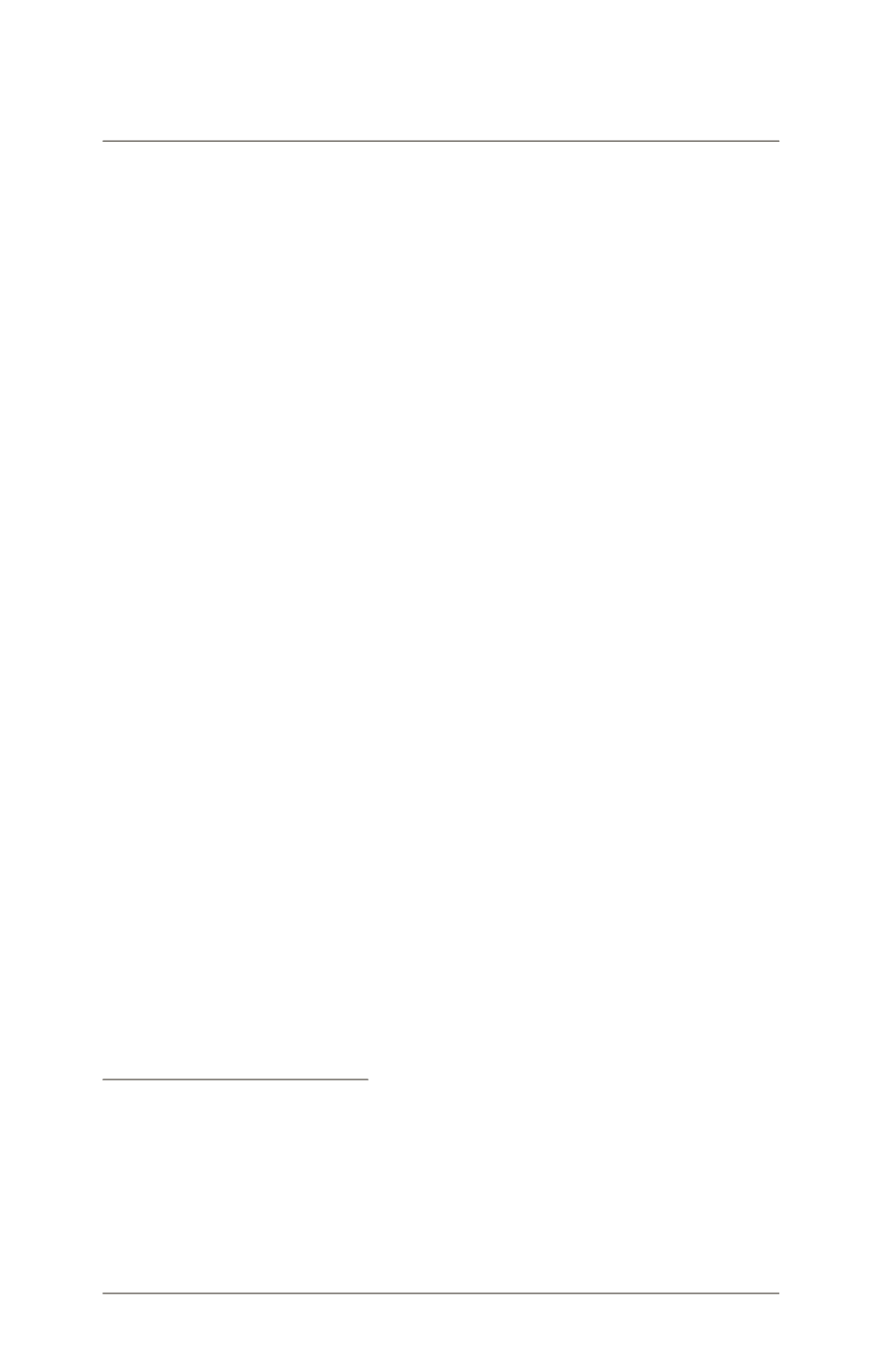
Risonanze emotive in adolescenza
12
mente sarebbero dovuti essere destinati alle esigenze dei gio-
vani
10
.
Si può notare già dagli aspetti che hanno determinato que-
sto processo di crisi, protrattosi dall’ultimo trentennio ad og-
gi, la presenza di una meta-categoria a sovrastare qualunque
condizione sociale; infatti, G. Lutte negli anni Ottanta, rileva
che: “quando si considera l’adolescenza, la condizione giova-
nile, nella sua evoluzione storica, nelle sue variazioni inter-
culturali, nella totalità dei fattori che la strutturano, si può
invece constatare che è un’istituzione socio-economica di
emarginazione e di sfruttamento che fa la sua apparizione
nella storia delle società umane perché corrisponde agli inte-
ressi dei gruppi sociali che detengono il potere, in particola-
re il potere economico”
11
.
Questa affermazione assunse per la ricerca sociologica un va-
lore scienti"co ineludibile tanto che i cambiamenti veri"cati-
si nelle masse giovanili si potevano leggere anche come fun-
zione di auto-adattamento nel circuito generale.
Le teorie sociologiche di questi anni apparivano condiziona-
te dalla “concezione ultrasocializzata dell’uomo”
12
e tentava-
no di descrivere la realtà giovanile come effetto diretto della
struttura sociale e della cultura.
La permanenza dell’idea socializzante estesa a chi la promuo-
veva aveva provocato una forma di conformismo privo di vere
e profonde esperienze, tale da produrre una condizione gio-
vanile in crisi e disorientata. Si evidenziavano pertanto:
>
la mancanza di scenari alternativi;
>
l’appiattimento nella quotidianità;
10
AA.VV. ,
Socializzazione e cultura giovanile in Italia
, ISEDI, Milano, 1978.
11
G. Lutte,
La percezione che i giovani studenti hanno della loro condizione. Contributo al
dibattito su “ giovani e politica
”, in
La critica sociologica
, estate 1979, 50, p. 224.
12
V. Cesareo, S
ocializzazione e controllo sociale
, Franco Angeli, Milano, 1974 (sulla
scorta delle posizioni di E. Durkheim e T. Parsons).
















