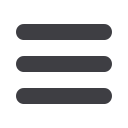

304
Parte Terza Competenze didattiche e spunti operativi
ambiti accademici (università, conservatori ecc.). Solitamente la composizione si
apprende in modo
precettivo
, secondo regole e norme, un po’ come per affron-
tare l’esame della patente di guida: questo si può fare, questo è vietato… questo
è un errore… la sensibile sale sempre…
la rotonda va percorsa in senso antiorario
…
la settima scende...
la precedenza a destra.
.. due quinte parallele...
un incidente
…
Ma l’evoluzione dei linguaggi musicali è avvenuta sempre per reazione a uno
stile consolidato che ormai appariva logoro. La tanto rinomata questione degli
errori di quinte e ottave parallele, ad esempio, nasce in epoca pre-tonale, sotto
forma di una vera e propria ribellione a certi parallelismi “vuoti” caratteristici
delle epoche precedenti. Per la stessa ragione, riaffiora all’alba del XX secolo
il bisogno di riappropriarsi di questi interessanti movimenti, raramente con-
sentiti in epoca tonale (Bach
Æ
Mahler).
Tra le tante testimonianze di questo rinnovato amore per le successioni di
quinte parallele, si pensi a Giacomo Puccini e all’
attacco
del II e del III quadro
de
La bohème
; o a Maurice Ravel e al suo linguaggio armonico di “cristallo”.
A questo punto se si immagina un futuro docente di scuola media alle prese
con un arrangiamento, con la sua piccola ma variopinta orchestra, vuoi di
tastiere, vuoi di fisarmoniche, vuoi di oboi, flauti, ottoni o violini, probabil-
mente questi avrà in mente un linguaggio sonoro che rappresenti una sorta
di sintesi tra tutti i linguaggi, accogliendo tutte le possibili tecniche e non già
solo quelle accademiche. Bisognerà, quindi, tener presenti alcuni andamenti
considerati in certi ambiti corretti e in altri sbagliati.
In questa sorta di vademecum dell’invenzione compositiva si dovrà perciò
rinunciare a una trattazione approfondita e anche a un certo inquadramento
storico-stilistico: ogni linguaggio e ogni epoca possiedono una propria teoria,
una propria trattazione e una serie di elementi caratterizzanti, che possono
essere desunti soltanto dall’osservazione delle opere prodotte in quel tempo e
con quello specifico linguaggio.
Il compositore e didatta Giusto Pappacena
suole ripetere una massima culi-
naria che perfettamente si addice all’arte della composizione: “l’alta cucina è
complessità risolta”.
Questo la dice lunga sul fatto che per capire ciò che si nasconde anche dietro
una semplice successione melodica occorre dapprima arrivare a possedere
certi mezzi e poi “risolverli”, dimenticandosene.
Claude Debussy, alle critiche mosse da chi riteneva il
Prelude à l’après midi d’un
faune
un pezzo senza forma, senza costruzione, rispose: “Il pezzo ha tutte le
cose che servono perché un pezzo sia ben costruito, ma cercherete invano le
colonne; dopo averle messe, infatti, le ho tolte.”
Ovviamente per acquisire tanta complessità, occorre studiare a lungo le pra-
tiche di scrittura delle epoche passate, riconoscere il senso e le differenze nei
linguaggi dei compositori e soprattutto mettersi l’anima in pace, perché un
libro di composizione che parli di tutto non esiste.
La vera conoscenza musicale si acquista osservando, deducendo e ripetendo
ogni gesto, ogni successione armonica, ogni connessione tra il linguaggio e la
















