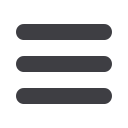

Capitolo
1
Composizione e armonizzazione di un canto
305
poetica, oltre che immedesimandosi nello spirito di un compositore o di un’e-
poca. Si impara a comporre consumando matite.
1.2
“L’arte precede sempre la teoria”
Nei capitoli che seguiranno si cercherà di ripercorrere, sotto forma di un dia-
rio di appunti, una precisa esperienza compositiva. Nell’affrontare lo studio
della musica si può comprendere come quella occidentale abbia seguito un
cammino analogo a quello che può compiere un compositore durante l’intero
arco della sua vita: un’evoluzione lenta per emanciparsi dal buio dell’istinto
verso una conoscenza concreta.
Schönberg scrive sul suo
Harmonielhere
:
“l’arte precede sempre la teoria”. Que-
sto significa che il compositore non scrive seguendo le regole desunte dallo
stile in voga nell’epoca, ma cerca, mettendo le mani avanti, brancolando nel
buio. La teoria viene sempre codificata in un secondo momento attraverso
l’osservazione delle opere del passato.
Le composizioni di Beethoven presentano una prevalente armonia triadica: i
suoi temi sono quasi unicamente formati di accordi spezzati di tre suoni.
Chiunque è capace di iniziare a comporre un tema con le note do, mi e sol,
tanto per intenderci. Beethoven potrebbe stupirci con una fantasia inventiva
straordinaria, come in effetti si può notare nelle numerose variazioni strumen-
tali scritte in epoca formativa (penso alla serenata per flauto, violino e viola o
al settimino).
Eppure egli preferisce richiamare a sé quelle semplici note che chiunque
avrebbe potuto pensare, evocando però i tre suoni come se questi provenissero
dal centro della terra e avessero la qualità sonora di un terremoto. Un’energia
misteriosa e inarrestabile giunge dall’interno e si rende conoscibile come feno-
meno naturale e quindi oscuro e inspiegabile.
La “musica” è complessità risolta
. Fra la posizione di chi scrive controllando tutto,
quella di chi fa con una sapienza diligentemente conquistata e quella di chi,
con incoscienza, cerca di sentire in profondità un complesso mondo sonoro
che appare impossibile da trattenere e fissare sulla carta, certamente occorre
una mediazione; tuttavia va detto che l’attitudine all’
incoscienza
e al
sentire
è
quella che più si avvicina all’atto creativo.
Il grande compositore georgiano Giya Kancheli, interrogato sul suo modo di
comporre, racconta che, per lui, la creazione è un mistero inspiegabile, e spesso
anche molto doloroso e sofferto; egli cerca di spiegare in che modo procede,
utilizzando pochi suoni, osservandoli, passandoci accanto giorni, mesi e anni,
non riuscendo mai a spiegarsi come sia arrivato al risultato raggiunto. E questo
mistero è nei suoni, nella loro ricchezza timbrica; essi vibrano e si accendono
come stelle, se si ha l’accortezza di garantire attorno a loro la necessaria
oscurità
.
Ogni evento sonoro deve essere considerato quale oggetto prezioso, unico e inimitabile
.
Anche un silenzio, un lamento, un fenomeno naturale come può essere il can-
to delle cicale in estate o un ruscello che scorre o una valanga che tuona o un
suono emesso da uno strumento o una pausa.
















