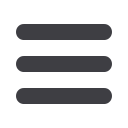

www.
edises
.it
8
Libro I
Diritto costituzionale ed elementi di diritto regionale
Secondo la tecnica impiegata, l’interpretazione può essere:
>
letterale
(anche detta “grammaticale” o “testuale”), quando alle parole della legge
è attribuito lo stesso signi cato che hanno nella lingua in cui sono scritte, senza
necessità di ricorrere ad altri criteri;
>
logica
, quando alle parole della legge è attribuito il signi cato che dipende dal loro
senso complessivo, scoprendo così la reale
voluntas legis
, ovvero ciò che il legislatore
ha voluto realmente intendere al di là del dato testuale;
>
sistematica
, quando non basta il criterio logico per scoprire la precisa volontà del
legislatore, ma il signi cato della regola giuridica viene chiarito collegandola ad
altre regole af ni, che operano nella stessa materia, e così ricercando il principio
generale alla base di tutte.
Si parla poi di
interpretazione autentica
per indicare l’attività interpretativa di una di-
sposizione già vigente, effettuata con legge direttamente dal legislatore (la legge di in-
terpretazione autentica è, dunque, una legge con cui il legislatore indica il signi cato
di disposizioni legislative precedenti); di
interpretazione uf ciale
, quando è effettuata
da organi dello Stato; di
interpretazione giudiziale
, quando è operata dal giudice; di
in-
terpretazione dottrinale
, quando è operata da accademici e studiosi; di
interpretazione
adeguatrice
, quando è diretta a conformare il signi cato di una disposizione a norme di
rango superiore; di
interpretazione
evolutiva
, quando è frutto di un necessario adegua-
mento della norma alle condizioni sociali del momento.
Secondo i risultati cui porta, l’interpretazione può essere:
restrittiva
, se riduce la
portata effettiva della norma giuridica rispetto a quella, apparente, che risulta dalla
sua prima lettura;
estensiva
, se applica questa portata al di là di quella formalmente
delineata dal testo della norma.
Se, anche dando alle norme esistenti la più dilatata interpretazione estensiva, il giu-
dice non riesce a farvi rientrare una certa fattispecie concreta perché il legislatore
non l’ha in alcun modo prevista, si può colmare la lacuna ricorrendo all’
analogia
,
mediante la quale il giudice applica al caso che resterebbe privo di giuridica re-
golazione la norma stabilita per un caso diverso, ma analogo al primo (cosiddetta
analogia legis
).
Se non esistono nemmeno norme che regolano casi o materie simili, il giudice potrà
ricorrere ai
principi generali dell’ordinamento
(cosiddetta
analogia iuris
). Se, infatti,
il giudice dichiarasse di non potersi pronunciare per l’impossibilità di attribuire un
signi cato giuridico ai fatti, questa decisione contrasterebbe con il
principio di com-
pletezza dell’ordinamento
giuridico
, in base al quale si presume che l’ordinamento
copra ogni situazione concreta della vita sociale, da cui derivino diritti e obblighi per
le persone.
Ciò nondimeno l’art. 14 delle preleggi esclude il ricorso al procedimento analogico
per le
leggi penali
(«…
le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali
o ad altre
leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in essi considerati
»). La dottrina prevalente, però,
supportata dalla giurisprudenza, ammette in materia penale la cosiddetta
analogia
in bonam partem
, ovvero quella favorevole al reo, purché la norma suscettibile di ap-
plicazione analogica sia in linea con il principio di tassatività e non abbia carattere
eccezionale.


















