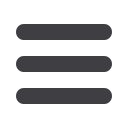

12
Parte Prima
La musica nell’ordinamento scolastico italiano
www.
edises
.it
A ogni lezione dovevano partecipare due alunni, impegnati per mezz’ora
ognuno nella propria lezione e nell’altra mezz’ora nell’ascolto partecipativo.
Il reclutamento dei docenti per l’insegnamento in questi corsi veniva fatto tra i
docenti di ruolo in educazione musicale o fra i docenti inseriti nelle graduato-
rie provinciali per l’insegnamento dell’educazione musicale o ancora tra nuovi
aspiranti forniti del diploma di strumento specifico e dotati di particolari doti
artistico-professionali, valutate da una commissione preposta.
Ai corsi ad indirizzo musicale, gli alunni potevano accedere tramite una prova
orientativa fisico-attitudinale, che aveva lo scopo di accertare il senso ritmico,
l’intonazione della voce e le caratteristiche fisiche in relazione allo strumento
prescelto. Gli organi di controllo di questi corsi sperimentali erano:
>
>
il comitato tecnico centrale, con funzione di organizzazione, coordinamen-
to e indirizzo della sperimentazione a livello più alto;
>
>
il comitato tecnico-scientifico provinciale, che traduceva a livello locale le
direttive centrali;
>
>
la commissione di coordinamento scolastico, con la funzione di seguire co-
stantemente l’andamento organizzativo e didattico della sperimentazione.
Questa esperienza ebbe notevoli ripercussioni nel panorama didattico italiano,
tanto che ben presto le mutate esigenze da parte di scuole e alunni spinsero il
legislatore a intervenire nuovamente in materia.
Il D.M. 13 febbraio 1996 intervenne in materia e disciplinò
ex novo
la sperimen-
tazione. Lo studio dello strumento musicale perdeva così la sua caratteristica
professionalizzante per essere inserito a pieno titolo nel progetto educativo
della scuola dell’obbligo e quindi aperto a tutti, anche a quegli alunni che
successivamente non avrebbero continuato lo studio della musica. Questi corsi,
allora, non avevano la pretesa di formare professionisti della materia, ma nello
stesso tempo diventavano propedeutici allo studio approfondito e sistematico
della musica, per cui risultavano molto importanti per tutti coloro che deside-
ravano proseguire lo studio musicale. Nell’allegato A di questo decreto, inol-
tre, venivano stabiliti finalmente i programmi da seguire per l’insegnamento
strumentale, che oramai non era più lasciato al caso, ma entrava a far parte
integrante del progetto educativo scolastico. A differenza di quanto previsto
dal d.m. del 1979, le modalità di svolgimento della lezione dovevano essere
stabilite all’interno del consiglio di classe e veniva finalmente riconosciuta l’im-
portanza della musica d’insieme, la cui quota oraria però non doveva superare
il 20% del monte ore generale.
Si ha una svolta decisiva nel riconoscimento dei corsi a indirizzo musicale con
la legge n. 124/99, la quale all’art. 11, comma 9, prevede “la riconduzione
a ordinamento dei corsi sperimentali a indirizzo musicale”. A questa legge
segue il decreto attuativo del 6 agosto 1999, n. 201, che all’art. 1 prevede che
“l’insegnamento dello strumento costituisce arricchimento e integrazione
interdisciplinare dell’educazione musicale nell’ambito della programmazione
educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia
con la premessa ai programmi della scuola media”. Rispetto al decreto del


















