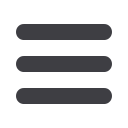
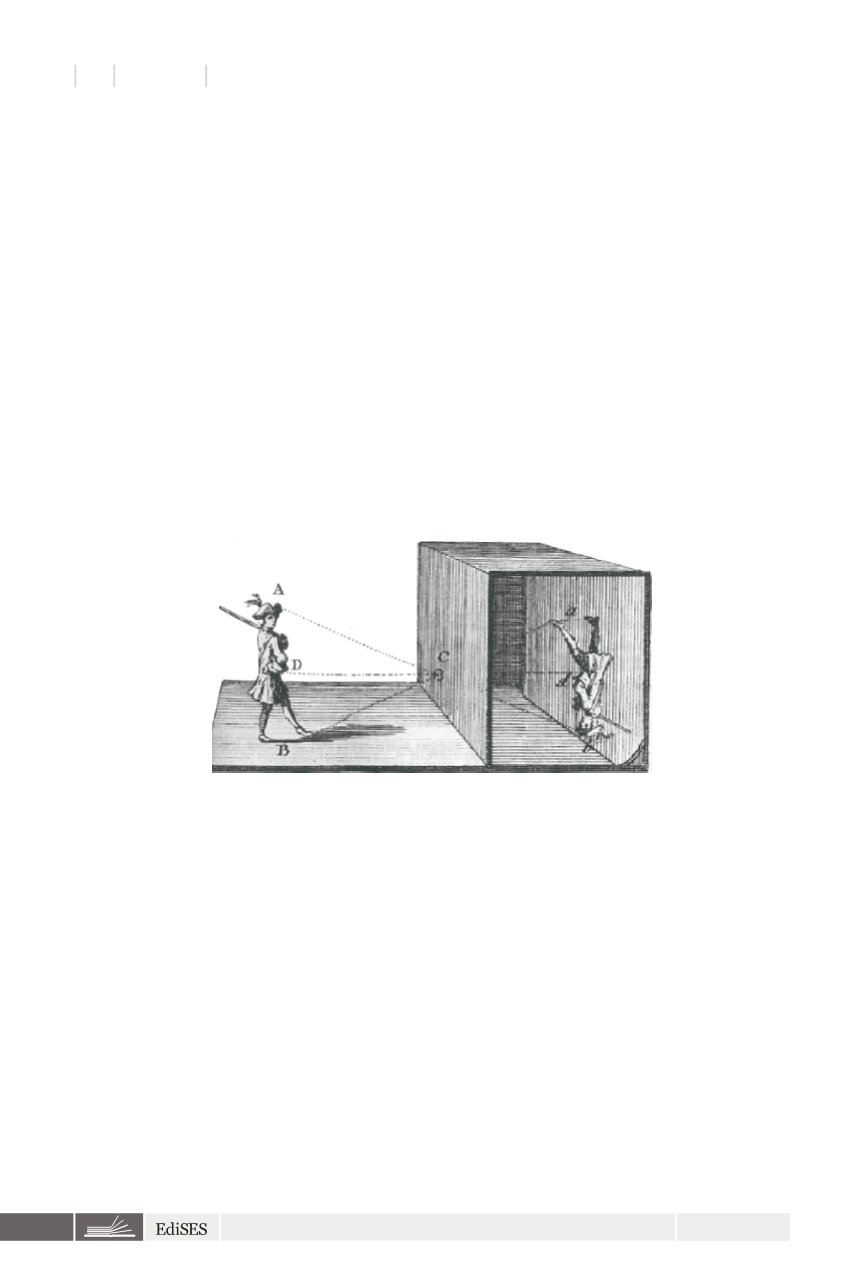
136
Parte Terza
La fotografia
www.
edises
.it
bastoncelli funzionanti nella retina. L’occhio, però, è più raffinato della macchina:
mentre nella pellicola ogni colore (nero compreso) ha la stessa sensibilità alla luce,
nell’occhio, in condizioni di scarsa luminosità, s’intensifica l’attività dei bastoncelli,
che, oltre al bianco e al nero, definiscono i contorni e le forme. Questo è anche il
motivo per cui, nelle fotografie, i contorni ci appaiono più sfumati rispetto a come li
percepiamo “dal vivo”.
La storia della fotografia ha inizio, idealmente, nel momento stesso in cui l’uomo
vede per la prima volta la propria ombra o, come il mitico Narciso, si rispecchia
nell’acqua di uno stagno. L’umanità prende coscienza lentamente, nel corso della
propria evoluzione culturale, dell’immagine della realtà, che all’inizio affida alla
memoria per poi riprodurre in segni grafici sempre più complessi e verosimiglianti.
La conoscenza della
camera oscura
è antichissima.
Aristotele
(384-322 a.C.) riesce
a osservare la conformazione del sole e della luna attraverso un foro praticato in
una specie di struttura tubolare.
Alhazen
(965 circa-1039), matematico e astronomo
arabo, osserva dall’interno di una “stanza buia” le eclissi solari, che si traducono in
immagini rovesciate e capovolte sulla parete opposta a quella su cui è stato praticato
un foro per far entrare i raggi luminosi.
Figura 1.1 -
La camera oscura
Durante il Medioevo numerosi alchimisti e sapienti sperimentano soluzioni e subli-
mati, portando avanti ricerche al limite della stregoneria, come trasformare in oro
il metallo, distillare elisir di lunga vita e, per l’appunto, fissare le immagini riflesse
da superfici speculari. Nei suoi studi sulla prospettiva
Leonardo da Vinci
(1452-1519)
descrive per la prima volta la camera oscura, assimilandola, sia pure in maniera ap-
prossimativa, all’occhio umano.
Gerolamo Cardano
(1501-76), per riuscire a otte-
nere immagini meglio definite, copre il foro della camera oscura con uno
specillo
(o
lenticchia
, come viene anticamente chiamata la lente) a forma di menisco convesso,
d’invenzione forse araba. A
Giambattista Della Porta
(1535-1615), commediografo
e scienziato, si deve poi la conversione della camera oscura in apparecchio per la
riproduzione di scene e vedute; gli esperimenti condotti per migliorare la nitidezza
delle immagini proiettate da una camera oscura di sua costruzione costeranno a
Della Porta l’accusa di stregoneria davanti al tribunale ecclesiastico e la condanna
all’esilio.
















