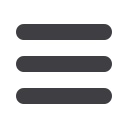
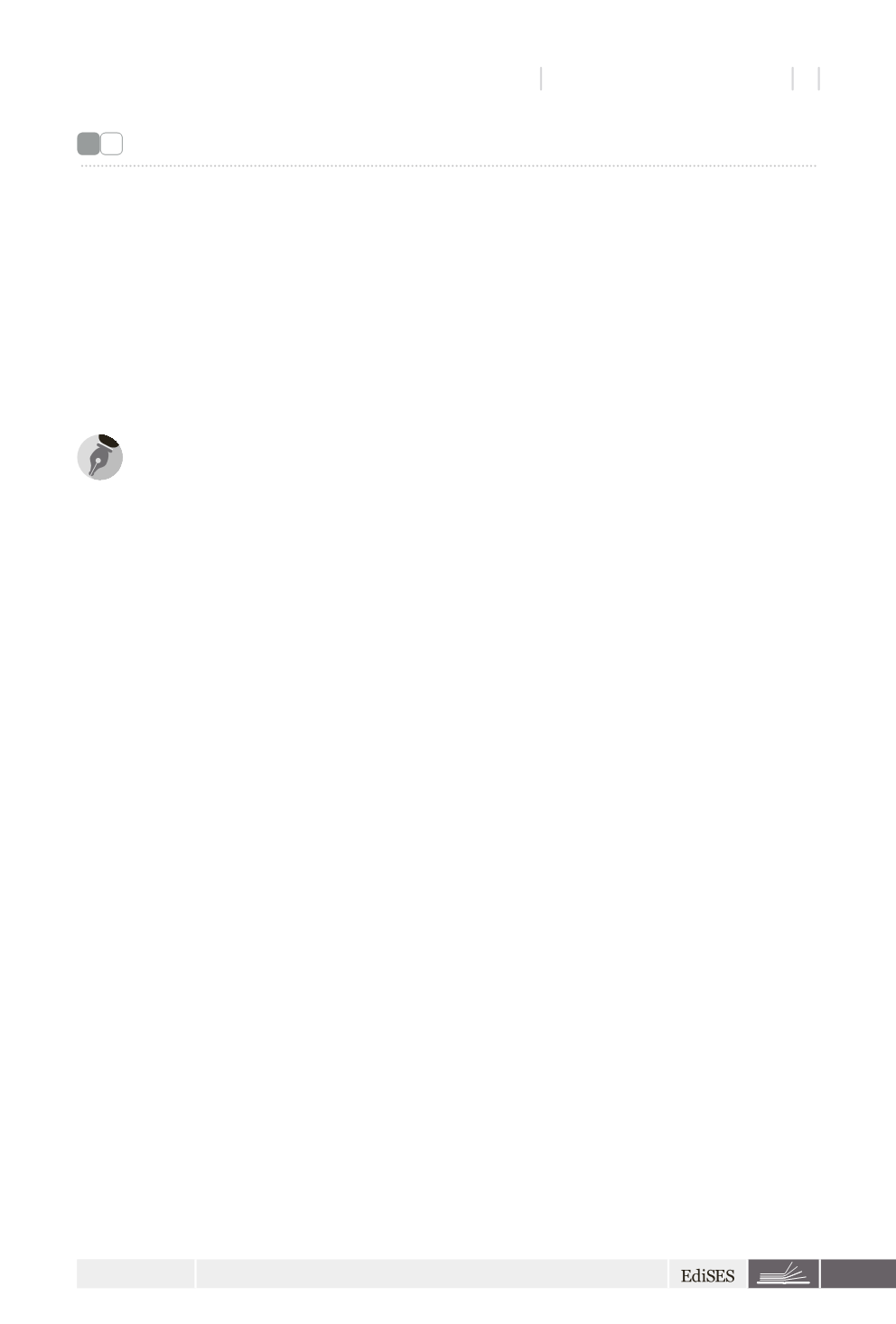
www.
edises
.it
Si de niscono usi aziendali quelli che, a differenza degli usi normativi, sono giuri-
dicamente riconducibili (
ex
art. 1340 c.c.) agli usi negoziali e, dunque, non possono
essere modi cati dalla sola iniziativa del datore di lavoro. Costituiscono fonte di un
obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti indivi-
duali con la stessa ef cacia di un contratto collettivo aziendale e, per questa ragione,
entrano a far parte del patrimonio giuridico del lavoratore.
Essi derivano dal
ripetuto e protratto comportamento datoriale di riconoscimento
di fatto di condizioni più favorevoli al lavoratore
. In tal senso, entrano a fare parte,
integrandolo, del contratto individuale di lavoro. Ovviamente la loro ef cacia è limi-
tata alla singola azienda ove sono applicati.
DOTTRINA
|
Secondo dottrina prevalente l’uso aziendale trae origine da un comportamento
unilaterale posto in essere dal datore di lavoro che, per via della
reiterazione nel
tempo
e dell’
identificabilità dei destinatari
(collettività aziendale o parte di essa),
perderebbe il carattere originario dell’unilateralità, diventando fonte di discipli-
na autonoma del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti (Sigillo Massara).
Alla base di detto indirizzo sembra essere il risultato di un indirizzo dottrinale per
il quale l’uso avrebbe rilevanza autonoma in quanto fonte di regolamentazione
del rapporto (Liebman).
Per quanto attiene al
processo di formazione degli usi aziendali
, si discute se gli
stessi debbano presentare i caratteri della reiterazione, della spontaneità, della
continuità, senza che possa aversi riguardo all’atteggiamento psicologico pro-
prio di ciascuno degli atti di cui questa si compone. Riguardo a tale problema si
è talora ritenuta sufficiente la mera reiterazione del comportamento. In più oc-
casioni si è tuttavia ritenuto necessario che il comportamento in questione fosse
accompagnato, oltreché dalla mera reiterazione, da un’effettiva volontà regolati-
va o modificativa. Da ultimo si è ritenuto che detta reiterazione debba risultare
a
posteriori
dalla verifica di una prassi consolidata senza che possa aversi riguardo
all’atteggiamento psicologico di ciascuno degli atti di cui si compone tale prassi,
atteso che in ogni caso il consolidamento di una prassi manifesta di per sé, sia
pure implicitamente, l’intento negoziale di regolare anche per il prosieguo gli
aspetti del rapporto di lavoro cui attiene.
Infine, occorre rilevare che sono state diverse le tesi che si sono succedute circa
la
natura degli usi aziendali
, e che hanno tentato di inquadrare il fenomeno, di
volta in volta, nell’ambito degli usi normativi, degli usi negoziali (art. 1340 c.c.),
dell’interpretazione del contratto individuale (art. 1362, co. 2, c.c.), di accordi ta-
citi, modificativi del contratto individuale, attraverso il richiamo allo schema del
contratto con obbligazioni del solo proponente (art. 1333 c.c.), della promessa al
pubblico (Spagnuolo Vigorita, Del Prato, Galantino, Picone).


















