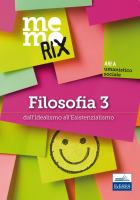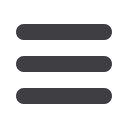
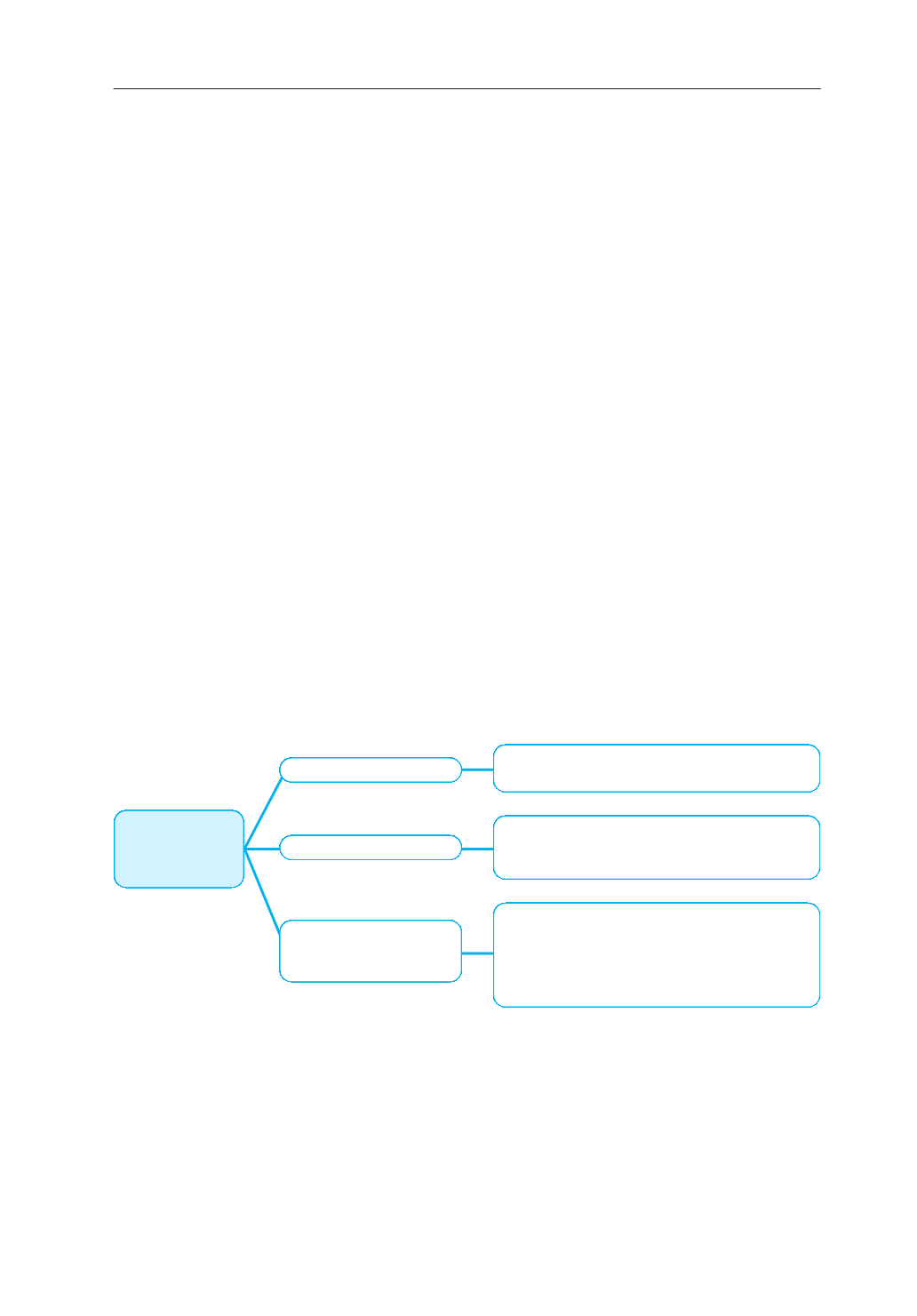
L’Io oppone entro di sé all’Io divisibile un non-Io divisibile.
La con-
traddizione che si manifesta nello sdoppiamento dell’Io deve
essere, infatti, eliminata e questo avviene nel terzo principio nel
quale l’Io assoluto dichiara che il non-Io non è negazione di sé
stesso, ma solo di una sua parte. L’Io assoluto, infatti, che è illi-
mitato e infinito, viene a trovarsi limitato e diviso dal proprio
atto auto-ponente e, quindi, oppone un Io limitato a un non-Io
limitato. Il terzo e ultimo punto mostra come l’Io, avendo posto
il non-Io, comprende di essere un individuo condizionato dalla
sua natura materiale e che la “purezza” dell’Io assoluto rappre-
senta solo un ideale.
I tre principi che definiscono la
dottrina della scienza
non devo-
no però essere interpretati in modo cronologico, bensì in senso
logico. Fichte, infatti, non intende dire che prima esiste l’Io infi-
nito, poi l’Io che pone il non-Io e infine l’Io
finito
. Il filosofo
tedesco sostiene più semplicemente che esiste un Io che, per
poter essere tale, deve presupporre il suo opposto (il non-Io) il
quale gli permette di esistere concretamente sotto forma di Io
finito
(ossia materiale).
4
Johann Gottlieb Fichte e Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
L’Io pone un non-Io
1.4. Wilhelm Joseph von Schelling: cenni biografici
Friedrich Schelling nacque a Leonberg, piccola cittadina del
Baden-Württemberg, il 21 gennaio 1775. A sedici anni entrò
nel seminario teologico di Tubinga, città nella quale conobbe e
L’Io pone il suo opposto (il non-Io), che
gli permette di assumere consapevolez-
za di se stesso.
Dottrina
della
scienza
Il concetto di Io si identifica con quello di
una attività autocreatrice.
L’Io, avendo posto il non-Io, comprende
di esistere concretamente sotto forma di
individuo condizionato dalla sua natura
materiale per la quale la “purezza” del-
l’Io assoluto rappresenta solo un ideale.
L’Io pone se stesso
L’Io oppone entro
di sé all’Io divisibile
un non-Io divisibile