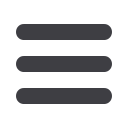

Il corpo inclusivo
2
Se i poeti mitici greci, come Omero, esaltano le prodezze fisi-
che, Platone professa una concezione assai classica del corpo,
un corpo che è il luogo transitorio dell’esistenza nel mondo
di un’anima immortale.
Per Platone, infatti, la salute ed il pieno sviluppo fisico sono
delle virtù nella misura in cui sono al servizio dello sviluppo
e dell’attualizzazione dei valori morali ed intellettuali. L’ani-
ma, puramente immateriale, appartiene alla totalità metafi-
sica e la reintegra allorché il corpo perisce. Questo è alle di-
pendenze dell’anima e, secondo il mito del carro alato, delle
sue tre virtù principali: temperanza, coraggio e giustizia.
Una concezione, quella di Platone, in cui è l’anima a identifi-
carsi con l’uomo, mentre il corpo diviene uno strumento, un
oggetto, mosso dall’anima stessa o, peggio ancora, un invo-
lucro in cui l’anima è contenuta. Certamente la prospettiva
di Platone tiene conto dell’influenza della “tradizione orfico-
pitagorica, per la quale l’anima preesiste al corpo, anzi è da
esso imprigionata nella vita terrena”
2
(Berti, 2007).
È così che Platone delinea le fondamenta per una successiva
riflessione che dovrà investigare sia sulla intrinseca costitu-
zione dell’uomo, quanto sulla effettiva possibilità di un iti-
nerario antropologico che sorga con la negazione del corpo.
L’influsso della ascesi platonica, riesaminata dal Neo-platoni-
smo e corretta dal Cristianesimo, tornerà ripetutamente nel-
la storia della filosofia, particolarmente negli indirizzi di tipo
spiritualista (Melchiorre, 1988).
3
Aristotele, più razionalista di Platone, interpreta l’uomo
come forma (1’anima) in cui si attua una certa quantità di
materia (il corpo).
2
Berti, E. (2007).
In principio era la meraviglia. Le grandi questioni della filosofia
antica
. Bari: Laterza, p. 141.
3
Melchiorre, V. (1988).
Il corpo
. Brescia: La Scuola, p. 49.
















