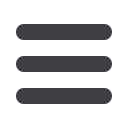

Capitolo 24
Le sindromi genetiche e la disabilità intellettiva
345
www.
edises
.it
non vengano adeguatamente «compresi» e dove manchi una relazione educativa
costruita sulla fecondità dello scambio, può avere sui processi motivazionali del
disabile conseguenze devastanti.
L’insegnante, perciò, deve sforzarsi di stabilire con l’allievo mentalmente debole
un rapporto improntato sul
confronto
, sulla
fiducia reciproca
e soprattutto sulla
collaborazione
, adottando la più ampia disponibilità a focalizzare, interpretare
e, per quanto possibile, soddisfare i bisogni specifici di cui l’allievo è portato-
re. In particolare, il docente deve tener conto del fatto che il disabile apprende
molto lentamente e che il suo apprendimento si attua prevalentemente
per imi-
tazione
di ciò che vede fare dagli altri e, in special modo, dalle figure di riferi-
mento. Occorre, inoltre, considerare che alla lentezza dell’apprendimento sono
tipicamente associate una
rigidità di pensiero
(inerzia intellettiva) e una relativa
tendenza a stereotipare
, per mancanza di elasticità mentale, gli atti e le strategie
operative.
L’
attività didattico-educativa
, per essere veramente efficace, deve promuovere
e valorizzare l’
operatività spontanea
, ponendo alla base di ogni proposta le
abi-
lità manipolative
, il «
saper fare
», prerequisito indispensabile per lo sviluppo
psichico di ogni essere umano. Al tempo stesso è importante che il disabile
sia stimolato a pensare per
categorie simboliche e astratte
, «
a riflettere sull’espe-
rienza per arrivare a generalizzare le acquisizioni concrete che l’azione educativa
produce
»
2
e arrivare così a ragionare a livello di logica ipotetico-deduttiva.
La continua sollecitazione di tutte le funzioni del corpo e della mente, in piena
integrazione con i compagni «normodotati», all’interno del gruppo di apparte-
nenza, permetterà all’allievo di esprimere al meglio le proprie potenzialità, di
percepirsi come una persona capace di affrontare positivamente gli impegni,
acquisendo sicurezza nelle proprie abilità e nella possibilità di avere successo, e
allontanando il timore del fallimento.
Diversificazione della proposta didattica e impostazione di un rapporto molto
stretto dal punto di vista umano, unitamente alla possibilità di lavorare a piccoli
gruppi per differenziare concretamente l’azione, sono condizioni indispensabili
per il perseguimento dei traguardi riabilitativi programmati, senza trascurare
il rapporto con i genitori dell’allievo, fondamentale per una continuità tra l’im-
pegno educativo domestico e quello scolastico.
2
d
’A
lonzo
L.,
Il lavoro educativo con il bambino con ritardo mentale
, in
Una introduzione all’Educa-
zione Speciale
, Salute & Società, Raffaello Cortina Editore, 2009.
















