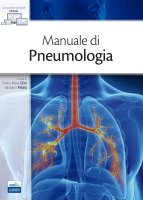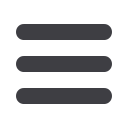
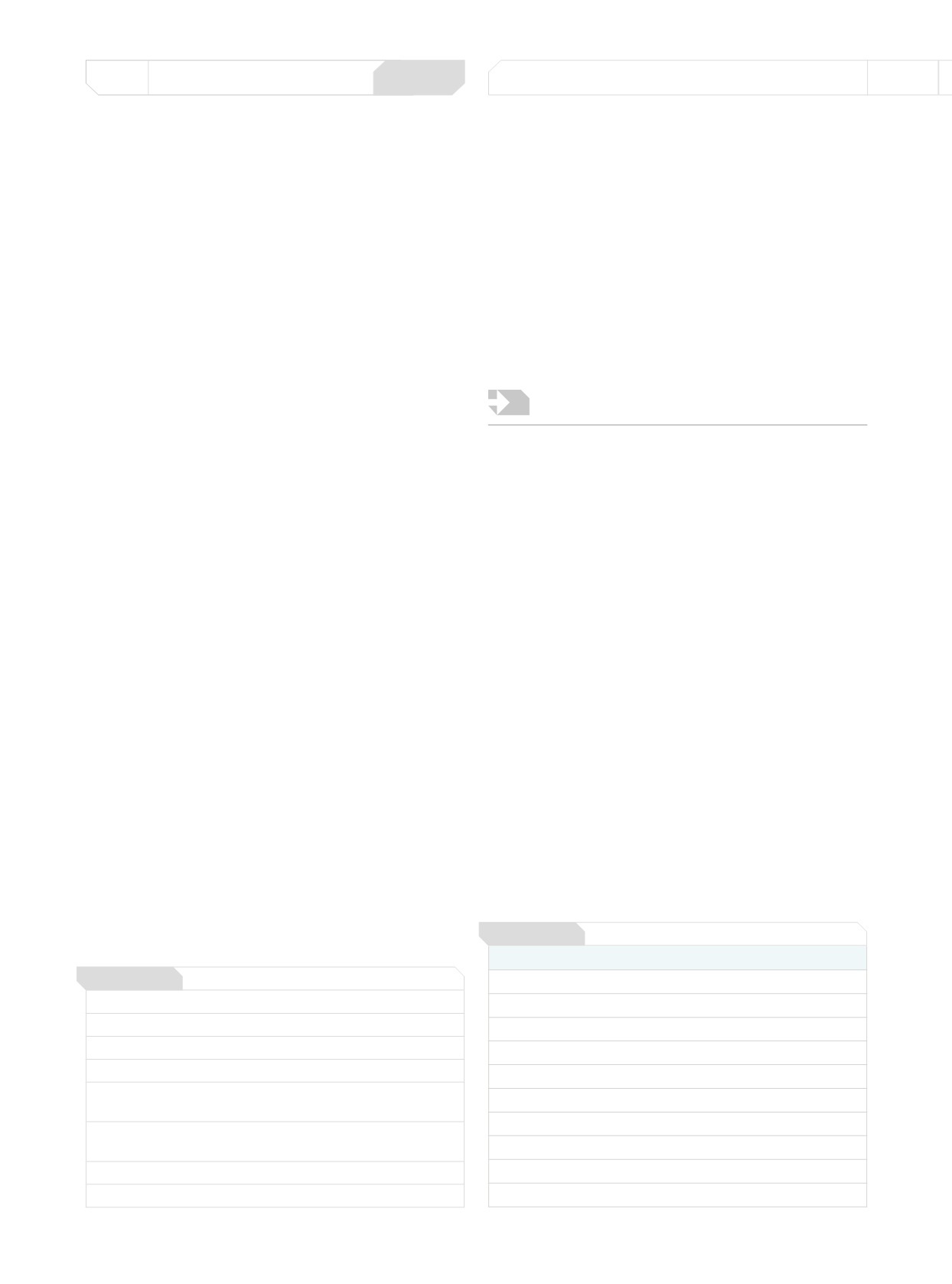
328
Disturbi respiratori del sonno e apnee
Capitolo
31
so un’alterazione qualitativa dell’architettura del
sonno, con assenza o marcata riduzione delle fasi di
sonno profondo.
Il collasso delle vie aeree superiori è favorito dalla
posizione supina e si manifesta soprattutto in fase
REM per la profonda ipotonia muscolare tipica di
questa fase. I fattori di rischio per l’OSAS (
Tabella
30.1
) sono rappresentati da tutte le situazioni che
riducono il calibro delle VAS in maniera permanen-
te (deviazione del setto nasale, ipertrofia dei turbi-
nati, ipertrofia adenotonsillare, ecc.) o temporanea
(infiammazione a livello delle vie aeree superiori),
soprattutto nei soggetti obesi. L’obesità viscerale,
con accumulo di adipe al collo, è un fattore di ri-
schio comune per OSAS e la minore frequenza di
OSAS nelle femmine può essere spiegata, almeno in
parte, dalla tendenza alla distribuzione periferica
dell’adipe nel sesso femminile.
La successione di eventi respiratori nel son-
no rappresenta un grave
stress
per l’organismo e
l’OSAS non trattata aumenta il rischio cardiovasco-
lare e cerebrovascolare. L’ipossia intermittente tipi-
ca dell’OSAS attiva meccanismi pro-infiammatori
e accelera i processi aterosclerotici. Inoltre, l’attiva-
zione simpatica che si verifica durante le apnee au-
menta la pressione arteriosa, con picchi ipertensivi
sistemici coincidenti con il ripristino della pervietà
delle VAS. Dati recenti indicano che l’ipossia inter-
mittente esercita effetti negativi sul metabolismo
glicidico e sulla funzione renale. Questa complessa
patogenesi spiega almeno in parte il ruolo causale
o favorente dell’OSAS nella genesi dell’ipertensione
sistemica non soltanto durante il sonno ma anche
nelle ore diurne. L’OSAS è un’importante causa di
ipertensione resistente al trattamento farmacolo-
gico e, in questi casi, la terapia dell’OSAS migliora
il controllo pressorio. La presenza di un’OSAS non
trattata è associata ad alta prevalenza di fibrilla-
zione atriale e frequente recidiva dell’aritmia dopo
cardioversione. Infine, più raramente, la cronica
ipossiemia notturna associata all’OSAS può causare
poliglobulia secondaria.
Il paziente affetto da OSAS può sviluppare, at-
traverso meccanismi eziopatogenetici non com-
pletamente chiariti, alcuni deficit cognitivo-com-
portamentali possibilmente conseguenti sia alla
frammentazione del sonno che all’ipossia/ ipercap-
nia intermittente.
Clinica
Le manifestazioni cliniche dell’OSAS (
Tabella 31.2
)
insorgono insidiosamente e possono persistere per
molto tempo prima della diagnosi. I
sintomi diur-
ni
comprendono la sensazione di sonno notturno
non ristoratore, astenia al risveglio, cefalea, secchez-
za delle fauci al risveglio, disturbi della memoria o
dell’attenzione e sonnolenza diurna. Quest’ultima,
presente in circa il 50% dei pazienti, inizialmente
compare in situazioni passive, ma nei casi più gravi
interferisce drammaticamente con la vita lavorativa
e sociale, oltre a causare incidenti stradali, domestici
o sul lavoro. Possono essere presenti calo della libi-
do fino all’impotenza e decadimento cognitivo.
I
sintomi notturni
sono il russamento abituale
e intermittente, e le apnee, la cui durata può pre-
occupare i partner. La fine dell’apnea è associata a
intenso russamento, respiri affannosi, gemiti e mo-
vimenti del corpo. Più raramente, il paziente può
risvegliarsi ansimante o con sensazione di soffoca-
mento (“choking”). I pazienti inoltre riferiscono ni-
Tabella
31.2
Elementi clinici per la valutazione dell’OSAS
Principali segni e sintomi
Sonnolenza diurna
Cefalea al risveglio
Russamento e/o secchezza fauci
Risvegli notturni
Apnee riferite
Choking
Enuresi e/o nicturia
Variazioni dell’attività sessuale
Disturbi cognitivo-comportamentali
Disturbi dell’attenzione e/o memoria
Tabella
31.1
Fattori di rischio per l’OSAS
Sesso maschile
Età
Obesità viscerale
Aumento della circonferenza del collo
Anomalie anatomiche delle vie aeree superiori (ostruzione nasale,
ipertrofia adenotonsillare, macroglossia, ecc.)
Uso di sostanze che riducono il tono muscolare: benzodiazepine
e barbiturici; alcol
Fumo di sigaretta
Disordini endocrini (ipotiroidismo, diabete, acromegalia)