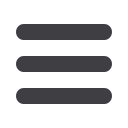

Parte III - Simulazioni d’esame
278
Rosina nel
Barbiere di Siviglia
di Rossini è un contralto. Gilda nel
Rigoletto
di
Verdi è un soprano leggero. La regina della notte nel
Flauto magico
di Mozart è
un soprano di coloratura, che è un soprano capace di ornare virtuosisticamen-
te una melodia. Il soprano di coloratura ha un timbro chiaro ed è molto agile,
per questo nel tempo è diventato sinonimo del soprano leggero.
20) C.
Nell’ambito della notazione del canto gregoriano i “neumi” sono i
segni grafici che designano la nota o i gruppi di note da cantare su una sillaba.
All’inizio del loro utilizzo la funzione dei neumi era puramente mnemonica:
erano, infatti, chiamati chironomici, cioè gestuali, perché richiamavano, nella
loro forma, i movimenti della mano del maestro che dirigeva. Solo col passare
del tempo si giunse allo stadio finale di precisazione degli intervalli.
21) D.
Il dramma liturgico medievale della
Visitatio sepulchri
veniva eseguito
in occasione della Pasqua. L’origine di questo rito risale ai primi decenni del
X secolo, ma raggiunse stabilità e una coerente strutturazione solo più tardi,
come ci testimoniano fonti che documentano la
Visitatio sepulchri
celebrata
nella cattedrale di Padova a partire dal XIII secolo. Nel caso padovano, la
celebrazione del dramma della Resurrezione si presenta arricchita di nuo-
ve componenti e parte integrante di una celebrazione liturgica più ampia e
unitaria, che comincia con la
Depositio crucis
, prosegue con l’
Elevatio crucis
,
continua con la
Visitatio sepulchri
e si conclude con la
Missa maior
del mattino
di Pasqua. Il dramma si basa sulla ripetizione della domanda
Quem quaeritis
in sepulchro
? fatta dagli angeli davanti al sepolcro di Cristo alle tre Marie che
il mattino di Pasqua andarono per ungere il corpo senza vita di Gesù. Alla
domanda segue l’antifona
Surrexit Dominus
, che corrisponde all’annuncio
della Resurrezione.
22) B.
La valenza educativa del canto popolare sta alla base delle teorie
pedagogiche di Zoltán Kodály. Nel 1906 questi si laureò in lettere con una
tesi sul canto popolare ungherese e ben presto, insieme a Bartók, intraprese
lo studio del patrimonio musicale popolare della sua terra. Kodály non scrisse
mai un trattato di pedagogia musicale, ma, attraverso lo studio degli esercizi
che proponeva e la lettura dei suoi articoli, possiamo ricavare il concetto del-
le sue teorie. Per Kodály la musica, per il suo grandissimo valore educativo,
doveva essere studiata da tutti gli individui, a partire dalla scuola dell’infan-
zia fino ad arrivare all’università. Bisognava utilizzare materiale musicale di
altissimo livello, ma adeguato alla lingua e alla cultura dei singoli paesi. Da
qui l’importanza della musica popolare, che diventava strumento di educazio-
ne attraverso lo studio e la riproduzione dei canti comuni alla tradizione.
Le teorie pedagogiche di Dalcroze, invece, si basavano sul fatto che le prime
esperienze musicali avvengono attraverso l’associazione di stimoli sonori a
movimenti del corpo. Associando particolari successioni di suoni a determina-
ti movimenti del corpo, il bambino poteva interiorizzare le strutture musicali
e specialmente la ritmica.
















